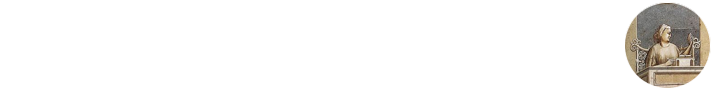Editoriale di Massimo La Torre
Il 2017 è stato, è e ancora sarà anno di elezioni in Europa. Dopo il Brexit e la spallata che questo ha significato per il progetto di integrazione europea una serie di appuntamenti elettorali sono visti e usati tutti come momenti nei quali si ripropone la questione del consenso dei paesi membri verso l’Unione Europea. E’ stato così nel caso olandese dove il partito xenofobo di Geert Wilders non è riuscito a sfondare, e un risultato simile abbiamo visto in Francia, dove la vittoria di Macron ha fermato quella che sembrava l’avanzata invincibile del Front National. Eppure c’è poco spazio per l’entusiasmo e le celebrazioni, nonostante qualche poco saggia celebrazione di Macron come il salvatore dell’Europa e il nuovo uomo di stato capace di rilanciare il progetto europeo. Nel recentissimo appuntamento elettorale britannico, nel quale il primo ministro conservatore intendeva cogliere i frutti del suo corso dato al Brexit, le cose le si sono complicate, e il verdetto delle urne è stato di sfiduciare una scelta chiaramente opportunistica. Verranno a settembre le elezioni federali tedesche, senza parlare di un certo profumo preelettorale che già si respira in Italia.
In questa congiuntura piena di incertezze si è riproposto con forza il tema (e la critica) del “populismo”. Che molta stampa ci dipinge come il nuovo spettro che si aggira per l’Europa, mettendone a rischio il progetto di civilizzazione depositatosi nelle istituzioni sovranazionali dell’Unione Europea. Ma che sarà poi questo “populismo”? Di che stiamo parlando? Invero, è tutt’altro che chiaro. Populista sarebbe la lega Nord in Italia, e ancora il Movimento Cinque Stelle, ma non il partito di Berlusconi. In Francia populista è Marine Le Pen, ed anche Mélenchon, il quale pure verso Marine è tutt’altro che tenero e ne rappresenta l’alternativa speculare. In Spagna si tratterebbe di Podemos, ma non del Partido Popular. E in Germania dell’attributo di populista si potrebbe fregiare l’inquietante Alternative für Deutschland. Si utilizza allora questa etichetta con certa generosità, al di là della ricerca della precisione.
Chi sarebbe allora secondo quest’uso “populista”? Sembrerebbe a prima vista ogni formazione che si presenta come alternativa ai partiti tradizionali, a quei partiti in cui si tramanda e si riproduce l’élite politica del paese da decenni, sia questa fissata nel partito socialista francese, o nella SPD tedesca, o nel Partido Popular spagnolo, o infine nel nostrano Partito democratico. Ma perché un tale fenomeno dovrebbe essere considerato negativo? Perche “populismo” costituirebbe un appellativo dispregiativo? Si potrebbe dire che i partiti “populisti” sono tali perché appellano alla “pancia” dell’elettorato. Ma come criticarli? Soprattutto se la “pancia” dei cittadini da qualche anno deve stringere la cinghia, e gli appetiti si riducono alla ricerca di un lavoro a tempo indeterminato e d’un salario che non supera i mille euro mensili, o d’una pensione che non si riduca sotto i cinquecento di euro. Scompaiono la classe operaia e il ceto medio, ci dice l’ISTAT. Rimangono quasi solo da un lato i “poveretti”, chi sbarca il lunario, chi si arrangia, e dall’altro le “grandi fortune” o il “grand commis”. Come criticare allora chi pensa con la pancia, se questa è vuota? Perché prendersela con chi difende il proprio status sociale, una volta dignitoso, se questo ora si sgretola a tutta velocità?
Ma, si potrebbe ancora dire, “populisti” sono quei partiti che fanno appello ai sentimenti più “bassi”, e meno nobili, della popolazione. Ma è proprio così? E’ questo il caso per esempio di Podemos, che raccomanda una generosa politica d’accoglienza verso i rifugiati? Non sarà allora piuttosto populista il Partito conservatore di Cameron, di Boris Johnson e di Theresa May? “Populista”, qualche altro dirà, è chi si oppone alla globalizzazione e rivuole il protezionismo. Ma forse che la “globalizzazione” la possiamo ricevere come un destino ineluttabile? E’ giusto e ragionevole che fabbriche e capitali si muovano da un paese all’altro senza tenere conto della comunità e del lavoro che li hanno alimentati? Possiamo consumare la carne cinese senza controlli sanitari? E comprare i loro giocattoli senza controlli che ne assicurino la sicurezza per i nostri bambini? E possiamo accettare che le nostre camicie e i nostri jeans, sempre meno cari, siano prodotti in qualche sweetshop della Manciuria con turni di lavoro di 12 ore, e con salari di fame, e in condizioni di semi-schiavitù? Parliamo tanto di diritti umani, ma questi non valgono forse anche dinanzi alle sorti progressive del mercato globalizzato?
E poi un po’ di protezionismo c’è sempre, ça va sans parler, tranne a non voler ripetere gli exploits della guerra dell’oppio con cui la Gran Bretagna forzava l’accesso del proprio commercio ai porti cinesi. Basterebbe leggersi The Great Transformation di Karl Polanyi, un libro oggi più attuale che mai, per capire cosa ha significato il dogma radicale del free trade nell’Inghilterra di fine Settecento e nella formazione, a lacrime e sangue, dei mercati capitalistici. Polanyi ci ricorda che il capitalismo si dà a tre condizioni, che il lavoro sia considerato e trattato come una merce, che dunque ci sia un “mercato” del lavoro, cosa tutt’altro che ovvia fino ad un paio di secoli addietro, che ci sia il “libero commercio”, che noi oggi chiameremmo “globalizzazione”, dunque la fine della protezione di ambiti locali di commercio, e di commerci regolati da dazi, tariffe e controlli sulle merci, e poi che ci sia uno standard fisso per il valore dato alla moneta di corso, una volta rigidamente l’oro, il “golden standard”, oggi potremmo dire mutatis mutandis l’aggancio all’Euro, almeno per quel che ci riguarda. Tre cose, tre condizioni, che oggi si dànno in termini radicali, e che sono radicalmente rivendicate dall’ideologia dello spirito del tempo. (Il mercato da luogo dello scambio di equivalenti, com’è ancora per Adam Smith, viene ridefinito come meccanismo di concorrenza da Müller-Arnack, Erhard, e compagnia). Seppure si accettasse che la propria vita, la stessa condicio humana, ogni nostra esperienza esistenziale, debba essere riformata e ritagliata come una “impresa individuale” (secondo il consiglio dell’ordoliberale Röpke), come si farà a reggere la competizione al ribasso con il lavoratore (imprenditore) cinese o nigeriano? Sarà forse dunque che “populista” è chi si oppone al Washington Consensus, ovvero allo Zeitgeist delle dislocazioni e del lavoro “flessibile” ?
In realtà –come ha detto bene Giuliano Amato in un’intervista al Corriere della Sera del 12 giugno scorso – il “populismo”, vale a dire la rivolta più o meno razionale ed ordinata alle politiche neoliberali portate avanti in un trentennio, è il risultato di “un fallimento politico di proporzioni storiche”. Che Amato individua nell’abbandono delle politiche socialdemocratiche di governo dell’economia, in una prospettiva – negli anni Novanta condivisa dallo stesso Amato – per cui si sosteneva che “ormai era la politica della concorrenza l’unica politica industriale che ci serviva”.
E tuttavia nei media più accreditati non cessa di ripetersi imperterrita, tenace, martellante, una narrativa che tesse le lodi della globalizzazione, e che equipara il controllo sulle merci, che è per certi versi inevitabile o almeno del tutto plausibile (si pensi ai controlli sanitari sugli alimenti importati), che equipara il controllo sulle merci –dicevo—al controllo sulle persone che passano da un paese all’altro, anche questo abbastanza ovvio nelle condizioni di insicurezza internazionale che viviamo. La globalizzazione dei capitali, le triangolazioni di denaro tra Londra, Wall Street e le Bahamas, le si equipara ai movimenti migratori di quanti sono alla ricerca di una vita migliore. Ma si tratta di cose ben distinte, il cui impatto morale va diversificato. D’altra parte si può ben avere una globalizzazione di capitali e di merci senza il libero movimento delle persone, come vuole e pretende il Regno Unito nella sua trattativa con l’Unione Europea: capitali senza frontiere, che varrebbero solo per le persone, per gli umani ai quali non si estende il diritto alla libera circolazione.
La globalizzazione allora non significa necessariamente, e forse nemmeno generalmente, “per lo più” (secondo la formula aristotelica), ampliamento e generalizzazione di diritti. Qui il liberalismo economico nuovamente si scontra col liberalismo politico. E questa contraddizione, evidente, eclatante, per chi la fa valere, non può giustificare l’accusa di “populismo”. Che rimane dunque un’etichetta abbastanza gratuita, tendenzialmente ideologica, quasi una cortina di fumo che ci impedisce di valutare il presente. Così che la reazione può essere di criticare col liberalismo economico anche quello politico, di farne di un’erba un fascio. Si possono allora sottovalutare i “diritti”, anzi ricominciare a guardarli un po’ di sbieco. Sarebbero questi “insaziabili”, “egoisti”, “sopraffattori”, omologatori di differenze e di valori fondamentali che costituiscono l’identità delle culture. I diritti renderebbero tutto “liquido”, oppure “piatto”.
Ora, in parte questa critica è giustificata, se si prendono in considerazione i diritti patrimoniali, il diritto “terribile” (parola di Beccaria) della proprietà e quell’altro dell’iniziativa privata (ultimamente sancito nella carta di Nizza). Il timore sui diritti può condividersi, se di essi si fanno dispositivi utilitaristici, “precetti di ottimizzazione”, che si applicano non deduttivamente, o secondo criteri deontologici, ma in maniera del tutto pragmatica, come ci spinge a fare la scuola di “law and economics”, e anche a malincuore, o forse suo malgrado, lo stesso Robert Alexy con la centralità (un po’ ossessiva, invero) ch’egli concede nel ragionamento giuridico al bilanciamento ed al principio di proporzionalità. Qui il diritto è malleabile, si espande e si ritrae, secondo considerazioni di ottimalità conseguenzialistica rimesse fondamentalmente alla discrezione del giudice. Questo diventa il protagonista di un’esperienza giuridica ritagliata essenzialmente come Privatrechtsgesellschaft, “società di diritto privato”, alla maniera di quanto hanno concepito e raccomandato (ed in buona sostanza conseguito) Hayek, Bruno Leoni, e gli Ordoliberali tedeschi.
Ma questa narrativa e questa dottrina dei diritti può contestarsi. Da noi lo ha fatto intelligentemente Luigi Ferrajoli. A poco vale riprendere a scagliarsi in toto contro la nozione di diritto soggettivo, come per esempio propone recentemente un filosofo come Christoph Menke che in Germania ha appena pubblicato una post-marxista, poderosa, e “furiosa” (lo dice Christoph Moellers) Kritik der Rechte (Suhrkamp, Frankfurt am Main 2016). Se ci tolgono i diritti, ci restano doveri e calcolo prudenziale, entrambi ragioni per agire le quali difficilmente potranno fondare una robusta modernità normativa, la “Zerrissenheit”, la “divisività”, che piace a Menke, e quel più giusto contratto sociale tra cittadini che ci aspetteremmo dallo Stato sociale e dall’Unione Europea.
Contro i diritti esercita la sua critica anche Gustavo Zagrebelsky in un saggio fresco di stampa, Diritti per forza (Einaudi, Torino 2017). Il costituzionalista torinese riprende la tesi di Simone Weil per la quale bisogna ripartire dai doveri al fine di ricostruire il “radicamento”, l’“enracinement”, sconvolto da una modernità tutta economicistica. E non gli si può dar troppo torto, se il “radicamento” è inteso innanzitutto come esperienza morale. Ché la morale è esperienza del “limite”, dunque dell’obbligo, del dovere, della soglia invalicabile, e non può darsi ab origine come sentimento del diritto e tantomeno come pretesa di questo. Il cartesianismo normativo dell’“Io voglio, ed agisco, dunque ho diritti”, ripreso dalla teoria morale per esempio di Alan Gewirth non funziona. Non riesce a costruire il ponte con l’altro da me che è necessario perché possa aversi il punto di vista morale. L’universalizzabilità dei diritti presuppone una certa empatia tra i vari loro detentori. E questa non si dà dalla prospettiva meramente monologica dell’“Io voglio”: o secondo l’ottica assolutistica del consumatore dell’“Il est mon plaisir”.
Altra cosa però è lo spazio della politica e del diritto, dove l’esperienza morale del limite si traduce intersoggettivamente nel riconoscimento del diritto altrui. La sfera pubblica produce e garantisce simpatia ed empatia. Il mio dovere si fa diritto dell’altro. Soprattutto allorché mi proietto in uno spazio discorsivo segnato dal dare ed ascoltare ragioni. Qui il ricorso ai diritti risulta inaggirabile, ineliminabile.
Senza diritti, ma con doveri e calcolo prudenziale non opereremmo più nello spazio del discorso tra uguali e della cittadinanza. Anzi, se ci priviamo dei diritti, e quello spazio ancora anche se minimamente attraversiamo ed usiamo, ne possiamo accelerare la decadenza. La critica del presente, del declino dello spazio pubblico, si farebbe allora motivo di una sua triste riconfermata proiezione nel futuro.