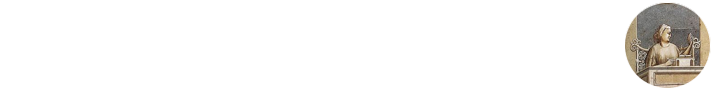EDITORIALE – Grandi narrative, l’orrore, e il ritorno dell’assurdo
DI MASSIMO LA TORRE
I.
Viviamo un momento in cui antiche certezze, consolidate in anni di sicurezza e di convivenza, ci appaiono sgretolarsi, sfumarsi dinanzi ai nostri occhi. Credevamo in una storia, ed ora la realtà effettuale ci costringe a interrogarci sul suo senso e sulla sua verità.
Pensavano che la società si fosse secolarizzata, e ci ritroviamo nuovamente minacciati dal fondamentalismo religioso. Credevamo che il fascismo fosse stato ricacciato tra i fantasmi del passato, e lo rivediamo nuovamente minacciare o erodere la cultura democratica in Europa e nel mondo. Ci eravamo illusi che lo Stato sociale fosse una conquista consolidata e che il capitalismo avesse subito la sua civilizzazione mediante strutture di controllo pubblico e diritti sociali, e lo dobbiamo di nuovo subire come quella forma spietata di sfruttamento economico che in realtà è sempre stato ed è nella sua essenza. Oppure ci ritroviamo dinanzi a fenomeni di populismo estremo che sfruttando il disagio sociale di decenni, spacciandosi per “libertario”, attacca frontalmente lo Stato come sfera pubblica e vuole “privatizzarla, vale a dire venderla al “mercato”, ai ricchi in poche parole. È la “grande trasformazione” di cui parla Karl Polanyi (The Great Transformation, London 1944) al contrario, rivolta contro se stessa, togliere ai poveri per ridare ai ricchi: la secessione dei ricchi, contro cui oggi non si vede ergersi nessun Menenio Agrippa. Il caso recente dell’Argentina si preannuncia drammatico, anche perché rivela ancora una volta che lo smantellamento dello Stato sociale è coevo e si accompagna al tentativo di far riemergere antiche pulsioni autoritarie ed addirittura di ristabilire forme dittatoriali di governo. Fu quello che accadde con Pinochet col sanguinoso colpo di stato cileno del 1973 ed è quello che si teme oggi nell’Argentina di Milei, l’anarco-capitalista.
Ai trenta anni “gloriosi”, tra i1 1950 e il 1980, che videro l’affermarsi impetuoso di diritti sociali e la conseguente riduzione della differenza di classe e delle ineguaglianze sociali, sono succeduti, dopo il decennio decisivo degli anni Ottanta, i trenta anni “ingloriosi” che hanno segnato l’osceno ritorno della disuguaglianza di reddito (vedi J. Rancière, Les trentes inglorieuses, Paris 2019). Di maniera che nella prospera e socialdemocratica Germania federale oggi l’uno per cento della popolazione possiede più del trenta per cento del patrimonio nazionale. E in Austria è addirittura lo 0,5 per cento che dispone del trenta per cento del reddito complessivo (cfr. U. Herrmann, Der Sieg des Kapitals, München 2021, p. 235). Per ciò che concerne l’Italia si stima che lo 0,6 per cento dei cittadini possegga il 43 per cento dell’intero patrimonio finanziario nazionale. La tassazione si è fatta “regressiva”, non più progressiva, così che le grandi ricchezze non arrivano a pagare un cinque per cento delle loro rendite, mentre l’operaio deve cedere allo Stato ben più del venti per cento del proprio salario.
Il lavoro, la sua fatica, ci parevano essere stati coronati dal riconoscimento pieno della loro dignità, come è sanzionato nel primo articolo della Costituzione della Repubblica italiana, ed ora il lavoro lo vediamo nuovamente oltraggiato, reso penoso, e disprezzato, mediante una sua radicale degradazione come forma d‘attività umana. Di molte dignità si parla e si discorre oggi e le si protegge o così si prova di fare, in genere dignità identitarie. Ma la condizione operaia ai giorni nostri è spesso peggiore di quella che descriveva con passione e compassione, e condivideva in fabbrica, Simone Weil. Il suo testo, La condition ouvrière (Paris 1951), sarebbe oggi quasi un esercizio utopico, perché ha nello sfondo un mondo operaio, che sì soffre ma che lotta e forte rivendica il suo diritto. E dove c’è ancora centrale la fabbrica, che al lavoratore dà una specifica identità, homo faber. Ma in questi nostri giorni la fabbrica ha perso la sua centralità di luogo paradigmatico della produzione di merci e di ricchezza ed allo sfruttamento non si oppone la coscienza di classe e la sua lotta, bensì la liquidita o “libertà” offerta dal neoliberalismo, dal consumismo e dalla società dello spettacolo, vale a dire solo la fuga nel privato e nel consumo e nello show permanente. Basta guardare la recente serie televisiva croata The Last Social Artefact per rendersi conto dell’abisso che oggi separa la situazione di chi tira a campare in un call center, o come rider, gli shit jobs di cui ci parla David Graeber (Shit Jobs, London 2017) e quella dell’operaio specializzato in una grande fabbrica capace di produrre una turbina idroelettrica. Alla intelligenza manuale ed intellettuale della fabbrica si è sostituito lo stordimento del call center, oppure il pedalare del riderche la sera ci porta la pizza che consumeremo sul sofà di casa guardando beati un reality show in televisione.
Credevamo che l’alfabetizzazione fosse un fatto consumato, una missione compiuta, ed i nostri giovani non sanno più tenere una penna in mano, né dove mettere l’acca in un verbo, e usano le parole più comuni della lingua italiana con stridenti sgrammaticature. L’educazione era servita ai nostri padri a prendere l’ascensore sociale, e noi non riusciamo a tenere il passo del livello sociale da loro raggiunto, e sprofondiamo in termini di reddito reale. E poi arriva la guerra, di cui oggi solo i vecchi, per esempio chi scrive queste righe, avevano ancora sentito l’odore di morte nei racconti del padre o della nonna. In particolare, avevamo creduto che l’integrazione europea fosse un progetto di pace e che la guerra fosse stata bandita dal vecchio continente, ed ora, la guerra, ce la ritroviamo in casa, foraggiata, impulsata, e celebrata come destino di vittoria (cf. L. Caracciolo, La pace è finita, Milano 2022). Dinanzi alla guerra di Ucraina, l’aggressione russa, e il massacro di inermi cittadini israeliani il 7 ottobre del 2023 rimaniamo attoniti, inorriditi. Ma l’orrore che ci suscita il progrom di Hamas non riesce a stordirci dinanzi a quello che ne è seguito in terra di Palestina.
II.
In realtà la guerra si riaffaccia in grande stile subito dopo la caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989. La fine della guerra fredda provoca una serie successiva e quasi permanente di guerre calde, certo non una guerra mondiale, uno scontro tra titani, come sarebbe stato un conflitto bellico tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Comunque, guerre cruenti e con la presenza in prima persone delle grandi potenze, in particolare ed in maniera massiccia degli Stati Uniti (cfr. S. Moyne, Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War, London 2022). Si comincia nell’inverno del 1991 con la prima guerra del golfo, questa voluta fortissimamente dagli Usa con una URSS che ancora esiste ma che non sa cosa fare e non è capace di fare. Sta a guardare quello che è una dimostrazione di forza tutta americana contro Saddam, il leader nazionalista arabo dell’Iraq, negli anni Ottanta campione dell’Occidente in un lungo e sanguinosissimo conflitto con l’Iran degli Ayatollah, conducendo per procura uno scontro che era invero tutto a profitto degli Stati Uniti, alla fine degli anni Settanta umiliati dagli Ayatollah persiani. Segue a partire dal 1991 la serie di guerre nella Jugoslavia che si autodistrugge. Qui l’Europa dimostra la sua inanità e profonda immaturità politica.
Nella lotta dei diversi staterelli in cui si frantuma la Jugoslavia gli Stati europei sembrano riposizionarsi secondo gli schemi e le alleanze della Prima guerra mondiale. Inghilterra e Francia con la Serbia, Germania e Chiesa Cattolica con la Croazia e Slovenia. Un paese che era stato un possibile modello di federalismo civilizzatore di nazionalismi etnici, per l’appunto la Iugoslavia di Tito, soccombe per mano del rinato nazionalismo etnico. Uno Stato forte, potente, ben armato, industrializzato, grande e popolato, viene smontato in una macedonia di staterelli cuscinetti, necessariamente stati vassalli della potenza che si erge ai loro confini, la Germania. È come se si fosse riportati ai primi decenni del ventesimo secolo. Nel 1995 abbiamo Srebrenica, una cittadina della Bosnia dove i Serbi bosniaci compiono il massacro di circa seimila uomini inermi, macellati nei boschi alla maniera dei Sonderkommando nazisti che terrorizzarono l’Unione Sovietica ed eliminarono la civiltà degli Ebrei Orientali, dello Shtetl, durante la Seconda guerra mondiale. Il contingente di caschi blu, forze ONU, non oppone resistenza al massacro, pur avendo giurato di difendere gli abitanti da ogni violenza. Il comandante olandese e le sue truppe, irlandesi, brindano con i soldati serbi, e il loro generale Mladic, ma tremano loro le mani nell’alzare il calice. Dutch Courage—si dice colloquialmente in inglese per bollare il codardo.
Infine, nel 1999 la NATO, senza l’approvazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, bombarda Belgrado, capitale della Serbia, perché questa pare minacciare e accanirsi su degli inermi kossovari. Dunque, gi anni Novanta dello scorso secolo, anni di speranza, anni ottimisti, gli anni del Trattato di Maastricht e dell’introduzione della Moneta unica europea, sono anni di guerra. Ma è come se non la vedessimo, ché la storia che ci racconta è nonostante progressiva. La percezione è che in Jugoslavia si tratti di una lotta tribale, che i cattivi solo siano questi brutali, ancora non civilizzati e feroci slavi del Sud. L’Europa è un’altra cosa, i Balcani un altro mondo. Per loro la libertà, e il mercato che ne rappresenta la costituzione materiale, deve passare per la guerra. Essere liberi dalle costrizioni precedenti del comunismo significa per questi bruti innanzitutto ammazzarsi tra loro. Dopo si vedrà, e si respirerà meglio, e si consumerà tanto, jeans, coca-cola, hamburger, Marlboro, MacDonald, Armani.
Dal 1999 della guerra del Kossovo all’11 settembre del 2001 e l’attentato alle torri gemelle di New York il passo è breve. L’islamismo radicalizzato con i soldi e ‘egemonia degli USA durante la guerra dell’Afganistan dove i Russi sono messi sotto scacco da una resistenza locale di fanatici religiosi colpisce la capitale dell’Impero: migliaia di morti. E l’Impero reagisce alla sua maniera. Si toglie i guanti, si libera le mani dai vincoli tradizionali del diritto. È the War against Terror, che non sente ragioni. I terroristi o piuttosto spesso quelli supposti tali non meritano misericordia ed ovviamente nemmeno le garanzie del diritto. Li si può torturare—afferma l’avvocatura federale dell’Unione, l’Office of Legal Council (Memoranda del 1 agosto 2002). E li si tortura, e li rinchiude (senza processo) in un campo d’internamento costruito nella base americana di Guantanamo a Cuba, un ridotto coloniale statunitense, ma fuori al territorio federale, di maniera che –si afferma—non valgono le tradizionali garanzie giuridiche né la protezione di diritti fondamentali e umani. Non varrebbe nemmeno la Convenzione di Ginevra a salvaguardia dei prigionieri di guerra siano questi civili o militari. A Guantanamo si continua per anni a torturare, e il campo è ancora lì a Cuba, e non è stato chiuso dopo più di vent’anni alla sua entrata in funzione.
Nel frattempo, si fa la guerra ai Talebani dell’Afganistan, che è invaso nel 2002 da forze americane ed europee. Ma questo ancora non basta a soddisfare l’idea neoconservatrice di sovvertire l’ordine dei paesi mediorientali e asiatici a favore di una piena egemonia americana. E così si arriva all’aggressione dell’Iraq da parte degli Americani e di una coalizione di “volontari” (tra cui in prima fila il Regno Unito e la Spagna). L’aggressione viene motivata con la menzogna della presenza nel paese di “armi di distruzione di massa” e addirittura, come dice Tony Blair in una dichiarazione pubblica, di ordigni nucleari pronti da far esplodere in 48 ore. Tutto falso. Ma il paese viene distrutto dalle bombe, e smembrato in varie zone, e “tribù”, secondo la logica del divide et impera già nota nell’Antichità. L’Iraq, paese ricco, forte e potente, viene spezzettato in varie zone, o “riserve indiane”, già come si era fatto per la Jugoslavia, e si farà in seguito per la Libia e la Siria, a séguito della cosiddetta “primavera araba. E come si sognerà di fare per la Russia, all’indomani del conflitto con l’Ucraina. Il Medioriente è così del tutto destabilizzato, i nemici tradizionali di Israele, Siria, Iraq, neutralizzati, ché di essi rimangono solo dei miseri monconi. Resta solo l’Iran come potenza ostile.
In questo percorso vi è un grande perdente oltre la pace e l’umanità, il diritto internazionale e quel sistema di sicurezza collettiva offerto alle relazioni tra Stati dall’intervento attivo degli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale. L’organizzazione che meglio rappresenta questo tentativo di pacificazione e civilizzazione delle relazioni internazionali ha per nome ONU, ma la l’invasione dell’Iraq si fa in spregio alle Nazioni Unite, e con costanti minacce a queste da parte dell’allora Presidente degli USA, George W. Bush. L’invasione dell’Ucraina diciannove anni più tardi ripeterà questo schema di disprezzo del vigente diritto internazionale. D’altra parte, da molti decenni è presente uno Stato nel Medio Oriente che ignora tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite e si è annessa la parte ancora non occupata della Palestina. Dalla guerra dei sei giorni del 1967 Israele non ha ceduto un metro dei territori vinti in quel conflitto, organizzandosi in una struttura politica nella quale si dà una parte del paese con tutti i diritti, che vive in prosperità e libertà, ed un’altra parte di reietti, continuamente cacciata dalle proprie terre, rinchiusa in ghetti, secondo un sistema che si può plausibilmente definire di apartheid.
III.
E d’improvviso il 7 ottobre ci coglie nuovamente la notizia di un orrore mediorientale. Miliziani di Hamas hanno rotto il recinto attorno a Gaza, isolata da anni, e addentrandosi in terreno di Israele vi hanno eseguito un vero e proprio progrom, massacrando civili inermi e sequestrando intere famiglie. Si tratta di più di mille vittime. Nuovamente dobbiamo piangere l’esistenza spezzata di tanti innocenti, e l’oltraggio della vita umana. Ma non basta purtroppo.
Al massacro Israele risponde con una reazione che chiamare vendetta o rappresaglia è abbastanza eufemistico, anche a prendere per buona la legge del taglione: “occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede” (Esodo 21, 24-27). Per mesi si bombarda la striscia di Gaza senza curarsi delle vittime civili. Migliaia di bambini sono sacrificati in nome di un vaghissimo concetto di diritto di difesa, che si manifesta nella maniera più sproporzionata possibile e senza più l’imminenza del pericolo, condizione necessaria per qualificare un atto violento come legittima difesa. Si rende forse così la popolazione d’Israele più sicura? Non è l’odio che in tal modo si produce una massa cieca e potente che per decenni minaccerà di spazzare via nuove vite e causare altri massacri? Ogni regola del diritto internazionale umanitario è violata, tanto più trattandosi nel caso di Israele di una potenza occupante che ha l’obbligo giuridico oltreché morale di proteggere la popolazione del territorio occupato. L’orrore è manifesto e rivendicato, l’intento di sbarazzarsi di una gente scomoda e ribelle, ed etnicamente altra, è esplicitato con toni che fanno riferimento ad episodi biblici di annientamento del nemico, degli Amaleciti (vedi Esodo 17, 8-16), come dice Netanyahu in una sua dichiarazione. Se non è genocidio, di certo è qualcosa che vi si approssima, e comunque si tratta di un crimine contro l’umanità. E l’Unione Europea tace dinanzi al massacro dell’inerme popolazione di Gaza; Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione esecutiva della Unione, si affretta a visitare Netanyahu per esprimergli solidarietà, senza però chiedere prudenza e umanità nella attesa reazione militare. L’epopea dell’integrazione europea, e dell’Unione Europea come momento clou del progresso liberale e civilizzatore (vedi T. Garton-Ash, Homelands: A Personal History of Europe, London 2023), inesorabilmente si scontra con l’afasia morale (e politica) dell’Unione Europea dinanzi al conflitto mediorientale. È il Sud del mondo, l’Africa del Sud, non l’Europa ad alzare la voce contro il massacro e ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia per chiederne conto ad Israele. Biden, il Presidente americano, il Cesare di questo inizio di secondo millennio, da parte sua blocca tutti i tentativi di chiedere formalmente, per il tramite del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite, un cessate il fuoco, e investe milioni di dollari in munizioni per l’esercito israeliano.
Ora, tutto questo, come la guerra d’invasione contro l’Iraq del 2003, c’impone necessariamente un ripensamento sul senso della storia di questi cinquanta e più anni in cui la politica europea ed occidentale si è proiettata come garante di legalità internazionale e di diritti umani; ci induce anche ad interrogarci sulla narrativa di Israele come paese democratico e patria delle vittime della storia terribile dell’Europa del Novecento. Non può ora negarsi che le vittime si facciano carnefici, che gli umili di ieri sono i prepotenti di oggi, che i senza terra di un tempo sono i coloni dell’oggi. Cosa resta allora dell’ideale d’Israele come Stato addirittura “anarchico”, come ci è stato presentato per esempio da Donatella Di Cesare in un suo saggio di qualche anno fa (Israele. Terra, ritorno, anarchia, Torino 2014)? L’immagine che di Israele ci dà Di Cesare è assai idealizzata, ma tale idealizzazione ora ci serve come cartina di tornasole per giudicare la qualità morale di uno Stato che invece di accogliere dei senza patria nelle ultime decadi ne ha prodotti a centinaia di migliaia, che invece di liberare opprime, che invece di salvare le Antigoni che non si sottomettono nuovamente le mura, secondo l’antico comandamento di Creonte. “Victime de l’injustice, le Juif est l’ennemi de ceux qui fondent leur justice sur l’injustice” – così dice Edmond Jabès nel suo libro Le Livre des Questions, Paris 1963, p. 77). Ma si può ancora affermarlo nell’Israele d’oggi?
Tutto ciò ci fa male nell’anima, perché ci dimostra che la sofferenza dell’oppressione sia pure estrema pare non avere la forza di educare alla empatia ed alla generosità ed al rigetto della violenza. Se Dio era stato silente ad Auschwitz, non pare che abbia voce a Gaza. Sul Dio della misericordia pare prevalere infine quello degli eserciti. E noi a guardare attoniti, increduli, abbastanza insensibili, l’orrore.
“Il arrive que les decors s’écroulent”, accade che lo scenario cada giù — così scrive Albert Camus, tematizzando l’improvvisa, sùbita rivelazione dell’assurdità della vita quotidiana che talvolta ci assale (Le mythe de Sisyphe, Paris 1942, p. 27). Qualcosa di simile ci accade ora per ciò che concerne la nostra percezione del mondo sociale, di ciò che è la sfera delle relazioni tra cittadini, popoli, Stati. Quanto credevamo fosse reale si rivela assurdo; gli stessi tanto celebrati diritti umani –avrà ragione Martti Koskenniemi (European Journal of International Law, 2005)? – ci appaiono ora quasi solo una manifestazione del kitsch politico della presuntuosa modernità liberale. L’assurdo ci assedia da ogni lato. Ma più che l’assurdo è la triste rivelazione della menzogna propria della narrativa di ciò che eravamo e siamo che da tante parti e prospettive ci è stato raccontato e inculcato.