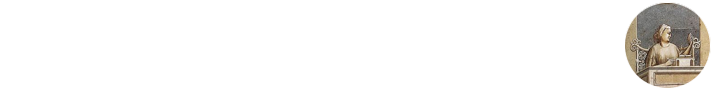Editoriale di Massimo La Torre
Uno spettro sembra aggirarsi per l’Europa: il populismo. E’ una frase di Ernst Gellner, il filosofo e sociologo oxoniense, pronunciata nel 1969, nel pieno della rivolta studentesca ed operaia in Francia e Italia. E per populismo allora s’intendeva la mobilitazione delle masse contro i partiti ed i governi conservatori, in quegli anni ancora saldamente in sella in molti paesi dell’Europa Occidentale: Rumor in Italia, De Gaulle in Francia, Kiesinger nella Germania Federale. Ma oggi quella frase risuona nuovamente, ed assume un significato diverso. In realtà non è chiaro cosa sia il “populismo”. Jan-Werner Müller, un politologo tedesco, in un libro recente, etichetta come populisti politici così diversi come l’ungherese Orban, il leader di Podemos in Spagna, i dirigenti dei Cinque Stelle in Italia, Trump negli Stati Uniti, Perón in Argentina, López Obrador in Messico, il “nostro” Berlusconi, Geert Wilders in Olanda, e ancora Bossi e Salvini, per non parlare poi di Marina Le Pen o di Nigel Farage.
La lista è già fonte di confusione, sono accomunati sotto la stessa etichetta, movimenti di destra e di sinistra, e anche di centro, fascisti ed antifascisti, nazionalisti ed internazionalisti. Müller individua due caratteristiche che a suo avviso definiscono il populismo. Deve trattarsi di un partito o movimento contro le élites, e deve poi essere anche antipluralista, cioè rivendicare lui la vera rappresentanza della volontà popolare, negando agli altri una tale capacità rappresentativa. In questo modo il populista non accetterebbe la normale alternanza e dialettica di maggioranza e opposizione, squalificando l’opposizione come estranea al “popolo”. Il populista inoltre non riuscirebbe a capire la qualità della democrazia rappresentativa, che non è basata sul mandato imperativo, ma sull’idea di una rappresentanza di interessi generali o universalizzanti che rendono inevitabilmente distante il rappresentante dal rappresentato (vedi Jan-Werner Müller, What is Populism?, Penguin, London 2016, capitolo primo).
Ora, se in questa immagine del “populista” si ritrovano delle intuizioni abbastanza corrette, nondimeno è la foto di gruppo, per così dire, che risulta falsata. Perché questa si dà su uno sfondo, una assunzione, che è distorta. Si assume cioè che le democrazie moderne funzionino correttamente, e che il loro vero solo nemico sia chi ne contesta il carattere elitario. Si dà così del “populista” troppo facilmente a tutti coloro che in qualche maniera sono delusi dallo status quo e si mobilitano contro questo. Ed invece di centrare l’attenzione su questo, lo status quo, e i suoi possibili, più o meno evidenti difetti, si rimprovera al “populista” di metterlo in discussione. Così pero quell’etichetta o categoria, o preteso “idealtipo”, perde di valore descrittivo. Si fa “prescrittivo”, termine ampiamente persuasivo, concetto polemico, che si affibbia per ragioni piuttosto di lotta politica, e non di analisi ragionata dei fenomeni politici in corso. Troppo rapidamente e nettamente tra l’altro in tale prospettiva si distingue tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, dove quest’ultima sarebbe quella “populista”, e la prima invece sarebbe la “vera” democrazia dei Moderni, un po’ alla maniera di Benjamin Constant, che contrapponeva la libertà degli Antichi, partecipativa ed onerosa, alla libertà dei Moderni, individualista o privatistica, e assai meno dispendiosa e impegnativa.
Qualche anno fa, recatomi all’Università di Klagenfurt in Austria, ebbi modo di visitare la biblioteca di Karl Popper, il grande filosofo austriaco, che da quell’università è stata acquistata intera dopo la morte del filosofo e che ora costituisce una parte della più amplia biblioteca d’ateneo. Aggirandomi tra gli scaffali ricolmi dei libri di Popper e curioso di sapere quali testi di filosofia del diritto e della politica possedesse Sir Karl, presi in mano la prima edizione della conferenza oxoniense di Isaiah Berlin su Two Concepts of Liberty. In questa, com’è noto, Berlin riprende e reinterpreta la distinzione di Constant tra una libertà positiva degli Antichi ed una libertà negativa dei Moderni come libertà “di” e libertà “da”. Ora, nel volumetto posseduto da Popper, sfogliandolo, mi imbatto in varie annotazioni a matita del filosofo viennese, ed infine in una sorta di commento conclusivo nelle pagine finali bianche.
Popper lì di suo pugno solleva due obiezioni. La prima è che non sarebbe possibile la libertà negativa senza la libertà positiva, vale a dire: perché ci sia autonomia privata ci deve prima essere cittadinanza, produzione di norme generali per tutti i consociati. La libertà negativa dunque presuppone quella positiva, la libertà “da” deve prima declinarsi come libertà “di”. E poi Popper contesta la plausibilità storica della tesi di Constant ripesa da Berlin. Non è vero, dice, che gli Antichi non conoscessero la libertà negativa. Ed in effetti basta leggere l’Epitaffio, la celebre orazione funebre, di Pericle riportata da Tucidide (II, 34-36) per rendersi conto quanto la libertà privata contasse nella concezione costituzionale e della buona vita della Atene antica. Fatto tra l’altro confermato dalla critica oligarchica alla democrazia ateniese, uno dei cui argomenti è per l’appunto la libertà e sfrenatezza dei costumi privati in democrazia e la troppo forte garanzia concessa qui ai diritti individuali contro le tradizioni della comunità e la sua morale positiva.
Ora, se questa contrapposizione di libertà positiva e negativa, almeno nei termini liberali ed elitisti di Constant e Berlin, è ingiustificata tanto teoricamente quanto storicamente, altrettanto può dirsi della contrapposizione di democrazia rappresentativa e democrazia diretta. La democrazia rappresentativa è rappresentativa di volontà soprattutto. Le teorie che democratiche non sono o che hanno in sospetto o in antipatia la democrazia per il suo carattere egualitario o turbolento (Ortega y Gasset per esempio, o l’ordoliberalismo, per non parlare di “rivoluzionari conservatori” come Carl Schmitt e Eric Voegelin) provano a reinterpretare la rappresentanza in termini di “rappresentazione” (vedi la dottrina di Leibholz negli anni veni del secolo scorso), “rappresentazione” sia di interessi (come vuole per esempio il corporativista Othmar Spann, l’avversario di Kelsen all’Università di Vienna, oppure meglio ancora o di “identità” (ed è la tesi di Thomas Mann espressa in Altezza reale, un romanzo giovanile).
Più recentemente, si è parlato di rappresentanza “argomentativa”, nel senso che rappresentante sarebbe colui che esprime regole e criteri normativi che in principio potrebbero essere accettabili dalla collettività. Si coniuga la rappresentanza politica dunque nei termini della razionalità giustificativa, in un certo senso realizzando l’antico sogno platonico di far “collassare” la politica nella filosofia, e di fare del filosofo il vero sovrano. Analogamente si è creduto di reinterpretare la vigenza della costituzione, che è un momento particolarmente pregnante di fondazione normativa, e che rinvia ad una precisa e diffusa determinazione di volontà, come validità di princìpi costituzionali, come “costituzionalismo”, che quindi potrebbe bastare a rendere operativo una conforme ed appropriata giurisprudenza.
Ovviamente tutte queste teorie segnalano un malessere del regime democratico “vivente”. Ché questo vive per l’appunto della partecipazione e del consenso attivo, partecipativo, del “popolo”, della gente comune, che vuole poter aver voce nella produzione delle politiche che direttamente la riguardano. Ma la tendenza generale va in altra direzione, verso il progressivo allontanamento della sovranità effettiva dai cittadini, che così si vedono nuovamente trasformati in “sudditi” o “clientes”. Ciò sta a significare che la democrazia rappresentativa deve avere un solido appiglio in forme di partecipazione diretta. La “rappresentazione” democratica per certi versi deve riprodurre, o “simulare”, la democrazia diretta e mantenere intatto il cordone ombelicale con questa.
Vale ricordare a questo proposito che la costituzione materiale della nostra repubblica, democrazia rappresentativa certamente, era quello di un esigente e pervasivo e assai potente regime dei partiti. Il partito politico, con le sue sezioni, le sue correnti, i suoi congressi cittadini, provinciali, regionali, nazionali, serviva da relais tra le istituzioni rappresentative e le volontà del “popolo”. Tale costituzione materiale è “saltata”; si è “estinta”. Non abbiamo più in parlamento nessuna delle formazioni politiche che sedevano nell’Assemblea costituente. Lo scollamento tra istituzioni, costituzione formale, e originaria costituzione materiale in Italia si è reso drammatico. In Germania i partiti che esprimono il governo sono ancora gli stessi che scrissero il Grundgesetz e sedevano nel Parlamentarischer Rat. Lo stesso vale per la Spagna e molti altri paesi europei. In Italia la memoria dei padri costituenti non è viva più in nessuna formazione politica, cosa che divarica la istanza tra rappresentanza e popolo, distanza che sembra essere colmata solo dalla televisione o dall’uso dei cosiddetti “social”, forme di comunicazione non discorsive e non responsive, non accountable; tutt’altro
E’ qui, in questa “liquidità” della società civile, e del suo rapporto con la politica, semmai la radice di quel fenomeno che si prova a definire come “populismo”. Più che “populisti” i partiti oggi, un po’ dappertutto nella società post-industriale, si sono fatti “liquidi”, “invertebrati”, senza fori istituzionalizzati e regolamentati di discussione, di deliberazione e di decisione. Il trionfo della cultura visiva, dell’immagine, reso inarrestabile grazie alla televisione ed all’uso di internet, fa sì che alle ragioni ed agli argomenti si contrappongano le immagini ed i simboli visivi, che fanno appello a passioni, sentimenti, reazioni immediate, non riflessive. Ciò trasforma il circuito rappresentativo, una volta grosso modo discorsivo, quello mediato dalle “sezioni” e “circoli” di partito, in cui ci si incontrava e si discuteva di persona, in meri eventi di fruizione di immagine e di parole. Il rapporto televisivo o dello schermo e unidimensionale, lo spettatore fruisce passivamente, riceve, s’imbeve, si esalta. E poi reaziona premendo un tasto o componendo un numero di telefono, o anche con una scheda elettorale, dietro la quale non c’è più un pensiero articolato ma la necessità di soddisfare un desiderio, un bisogno urgente, d’obbedire a un impulso. Né c’è più un momento collettivo d’incontro. Per questo le “primarie” non possono colmare il buco di rappresentanza, ed anzi esaltano la “liquidità”, specie là dove è chiamato a votare anche chi non ha un rapporto dichiarato e reso esplicito, mediante una “tessera” per esempio, col partito di cui si sceglie la “linea” e la leadership. Qui, in questo buco di rappresentanza, si conficca una delle radici della politica populista.
Si ricordi anche quanto scrive Baumann in Liquid Modernity (Polity, London 2000, p. 86): <<Spectacles take the place of surveillance>> — una tesi già articolata nella Société du Spectacle di Guy Debord. Si è soliti riportare il mondo del romanzo distopico di George Orwell, 1984, allo Stato totalitario dei regimi comunisti influenzati dal modello sovietico. Ma la distopia orwelliana si può leggere con altri occhiali, e offrire altre conclusioni che quelle ormai anacronistiche, e idiosincratiche, dell’anticomunismo. Nella società descritta in 1984 vi è dappertutto una televisione, uno schermo piatto attaccato nella parete d’ogni stanza. Questo schermo non solo offre uno spettacolo, ma registra tutto ciò che avviene nello spazio in cui è installato. E’ uno strumento di controllo.
Ora, oggi, anche le nostre televisioni sono piatte, e ce le troviamo in quasi ogni stanza in cui viviamo, in ogni spazio in cui ci incontriamo, al bar, in pizzeria, al ristorante, a casa della mamma e della nonna. Dallo schermo ancora non si può vedere ciò che noi facciamo (tranne che non sia uno schermo di un computer), ma da esso ci vengono instillati desideri, ambizioni, modelli di vita che plasmano la nostra condotta quotidiana e le nostre aspettative. Vediamo ormai il mondo con gli occhi della televisione. E’ come se ci avessero sottoposto ad un’operazione agli occhi, mettendo al posto dei bulbi oculari due microscopici apparati televisivi che proiettano le immagini che noi poi percepiamo come il mondo reale. Ma le televisioni sono ora in balia del cosiddetto mercato. Non è solo o più solo lo Stato il Grande Fratello, ma c’è anche, eccome, il capitalista, il venditore di merci, l’imbonitore, il seduttore, e con questo spesso fa coppia il demagogo.
Dice Bauman: << Obedience to standards […] tends to be achieved nowadays through enticement and seduction rather than through coercion>>(ibidem). Ci si controlla in maniera “soffice” mediante seduzione ed induzione a consumare, non più eminentemente mediante coercizione. Ma la coercizione la avvertiamo nettamente, e il diritto — dice Ronald Dworkin – è l’attività che decide sulla giustificabilità del suo uso, ed è il risultato a sua volta della politica. Ma se la coercizione si dissolve, eppure il controllo si mantiene, sotterraneo e soave, senza che ci sia la percezione d’esso, su cosa si eserciterà la politica? Al controllo “liquido” corrisponde la “liquidità” della politica.
Quanto più “liquida” si fa la politica, e quanto più distante è il rappresentante dalla espressione meditata della volontà del rappresentato, tanto maggiore s’impone alla governabilità una dieta, diciamo così, tecnocratica. Non entro qui nell’àmbito più specifico delle ragioni di politica economica europea che tale tendenza tecnocratica hanno esasperato. Mi limito alla registrazione di una dinamica generale, meramente istituzionale. La fine della costituzione materiale dei partiti in Italia ha portato al governo Berlusconi, che ha certamente tratti “populistici”, o meglio carismatici, se per questi s’intende per l’appunto l’assenza della mediazione rappresentativa discorsiva. In “Forza Italia” alla “sezione” di partito si sostituisce la qualità di tifoso del Milan, o di spettatore fedele di Canale Cinque, o anche di cliente dei grandi magazzini “La Standa”. Ma il “populismo” dell’era Berlusconi non ha indebolito, ha bensì rafforzato la tecnocratizzazione della repubblica, al di là dell’influenza più o meno nefasta dell’Unione Europea al riguardo. Lo Stato ha dismesso a favore di agenzie indipendenti e di “dirigenti” d’ogni tipo quelli che prima erano prerogative parlamentari o dell’esecutivo e della sua amministrazione. La giudicializzazione della vita politica (e cosa vi è di più elitario di un giudice?) ha accompagnato la crescente debolezza del parlamento e la decrescente legittimità della politica di partito.
Ed arriviamo infine a destinazione. Scrivono Zygmunt Bauman e Carlo Bordoni: «The compact of power and politics, the sine qua non condition of effective action and purposeful change, has in effect been split into a power freed from all but rudimentary political control, and politics suffering a permanent and growing deficit of power» (State of Crisis, Polity, London 2014, p. 20). L’unione di potere effettivo e politica, condizione sine qua non di ogni azione politica efficace e di ogni cambiamento sociale significativo, è stata in effetti dissolta, da una parte in un potere libero da ogni sia pure rudimentale controllo politico, e d’altra parte in una politica che soffre una cronica e crescente insufficienza di potere.
La “privatizzazione” di molta parte della sfera pubblica riduce la portata della dimensione pubblica della cittadinanza sul territorio sociale, riservandola a forme di controllo e revisione tecnocratica. Il mercato si impadronisce dei beni collettivi, ma non cessa d’aver bisogno di una mano pubblica, che però questa volta è del tutto dislocata dall’àmbito della cittadinanza. Ci vogliono regolatori, e agenzie di monitoraggio, e persino un’autorità antitrust ed una banca centrale, ma che queste siano indipendenti, cioè senza più condizionamenti politici e controlli o responsabilità dinanzi ad organi parlamentari, cioè rappresentativi. Il mercato non si regola da sé, anche se ha il compito di disciplinare e indirizzare la coscienza politica dei cittadini. Insegna loro come votare—come di recente ha detto, expressis verbis, un commissario europeo, ripetendo un assioma dell’ordoliberalismo. Il mercato continua ad avere bisogno di regolazione. Ma questa deve essere staccata da ogni rappresentanza politica e dal gioco democratico della lotta dei partiti e dei programmi politici. Vale qui la dottrina thatcheriana del “TINA”, “there is no alternative”.
Da una parte dunque tecnocrazia, che garantisce la governabilità, e d’altro lato “populismo” che gestisce il consenso (o il dissenso). L’una rimanda all’altro, in un circolo tutt’altro che virtuoso. La tecnocrazia produce impotenza, e l’impotenza risulta in sommovimenti “populisti”. Questa è la morsa entro la quale la democrazia oggi si trova a vivacchiare. E l’una o l’altra dei due bracci della morsa, quale che sia l’esito del conflitto e della lotta tra questi, può risultarle alla fine fatale.