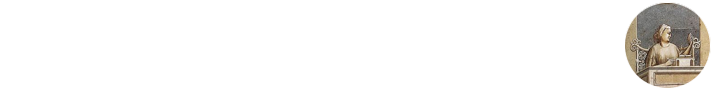Editoriale di Massimo La Torre
Il secolo scorso, il secolo “breve”, è stato un tempo nel quale la questione della cittadinanza, ridotta alla sua sostanza minima, il possesso di un passaporto, è stata questione di vita e di morte per milioni di persone. Eppure, il passaporto, come ricorda Stefan Zweig nel suo accorato Il mondo di ieri, Die Welt von gestern, non era ancora necessario per viaggiare a un paese all’altro nell’Europa della Belle Époque.
Fino al 1914 le frontiere potevano attraversarsi più facilmente, e spesso senza quel particolare e pomposo documento d’identità che è il passaporto. È l’Europa del primo dopoguerra che ne richiede l’introduzione forzata, come risposta del nazionalismo ossessivo alle masse di sfollati da una parte all’altra del vecchio continente. Si inventano i passaporti Nansen per i senza Stato, di cui fu portatore tra gli altri quella figura di intellettuale girovago e eretico che è Andrea Caffi. La cittadinanza sembra così fissarsi nel passaporto che la concede. Ovviamente si dà qui un importante slittamento di senso e pratica. La cittadinanza, originariamente status di partecipazione alla produzione democratica della legge, si rifugia tristemente nella “nazionalità”, lo status di appartenenza ad una entità statale, ed è questo status che è certificato dal passaporto. Che dietro questo vi sia anche una comunità democratica è cosa incerta e spesso pericolosa.
Della nazionalità si fanno così esperimenti vari, la si ritaglia in termini etnici, la si nega e la si riattribuisce, a seconda dei destini storici, geopolitici, militari di certe zone del mondo. Hermann Heller, il grande costituzionalista, alla caduta dell’Impero asburgico, pur avendo combattuto con l’uniforme k.u.k., imperial-reale, di Sua Maestà Apostolica Francesco Giuseppe, alla fine della guerra potrà scegliere di farsi cittadino del Reich repubblicano tedesco e dunque dismettere l’appartenenza e la cittadinanza austriaca, per il solo fatto di essere nato in una cittadina dei Sudeti prima asburgici, ora cechi, ai cui abitanti si offre la scelta tra la nazionalità ceca, o tedesca o austriaca.
Joseph Roth mai e poi avrebbe dismesso la fedeltà alla vecchia Austria; lo stesso potrebbe dirsi di Wittgenstein di cui si racconta che, ritornato dalla prigionia in Italia, per mesi non svestisse l’uniforme asburgica. Ma la patria imperial-reale si è volatilizzata, si è rimasti “senza qualità”, come l’Ulrich di Der Mann ohne Eigenschaften Musil, e i protagonisti di tanti romanzi di Roth resi superflui come Franz Tunda dalla storia che li ha privati di identità nazionale e soprattutto politica. Cosi Tunda siede desolato sulle scalinate della Madeleine di Parigi, e Roth conclude con parole definitive: “So überfluessig wie er, war niemand in der Welt”, così superfluo come lui non c’era nessuno al mondo.
E tuttavia il pensiero politico del Novecento e la sua pratica non si fissa sulla questione della cittadinanza. Non è questa al centro delle sue angosce. Non che su questa non vi sia attenzione o riflessione, ma la pratica politica si sviluppa come se il problema dell’appartenenza fosse stato risolto. Ché questo è piuttosto incentrato nell’identificazione ad una classe sociale, e questa si dà o si proietta ben oltre i confini statali.
Per Hans Kelsen la cittadinanza è vista come un ultimo privilegio particolaristico, che la sua teoria, come accade per la sovranità, vuole dissolvere con l’acido della critica analitica e della purezza della nozione di norma ed ordinamento. Il pangiuridismo è un’anticamera qui del cosmopolitismo. E nel suo testo sulla democrazia, Das Wesen und Wert der Demokratie, suggestivamente si tessono le lodi della costituzione sovietica che concede i diritti politici anche ai non-nazionali. Se si è soggetti alle norme, e lo sono tuti i residenti entro lo spazio dell’ordinamento, non si vede come da una prospettiva democratica possa negarsi a coloro cui si richiede di obbedire possa negarsi anche il diritto alla produzione della legge.
Come che sia, è la questione della giustizia sociale e dell’uguaglianza il tema novecentesco per eccellenza e la promessa di una società alternativa. Il rivoluzionario già per ciò è cittadino, e non ha bisogno di più. “Compagno” è qualità più calda ed intensa. La rivoluzione azzera o supera le frontiere e riconcilia ogni identità, anzi le fonde al calore, al fuoco della novità radicale della società senza classi. Così che il tema e il problema della cittadinanza, sia come nazionalità sia come partecipazione, non riappare che allorché quel grande fuoco si è spento, le speranze sono impallidite. La classe operaia non credendo più nella sua autodissoluzione paradossalmente non riesce più credere in se stessa. La “classe” esiste se e per quanto ha coscienza ed intenzione di annullarsi come classe nella società senza classi. Se questo orizzonte scompare, anche la classe si liquefa, giacché senza coscienza del proprio superamento il riconoscersi come tale non può che essere fonte di frustrazione ed umiliazione.
Verso la fine del “secolo breve” la classe si fa massa, e poi semplice moltitudine, ente numerico, di cui si ha notizia più che per la sua partecipazione alla audience di un certo programma televisivo. Non si raccoglie più che attorno ad uno schermo. Anche prima era un sogno a definirla, era il sogno dell’emancipazione che la rendeva unita e omogenea, per l’appunto “classe”. I sogni sempre permangono. Essi strutturano il desiderio e la volontà di vivere. Ma ora è il sogno di essere un “imprenditore”, o un “consumatore”, o un giocatore di calcio, o una stellina in televisione, una “velina”. Ed adeso l’identità, che prima si poteva trascurare, ché era data per scontata, e poi era anche disprezzata come cosa piccolo-borghese, o egocentrica ed egoistica, o persino inutile nel grande gioco della lotta per l’uguaglianza, si ripropone, o si propone forse per la prima volta come questione esistenziale di prima forza. Per questo qualcuno parla a quel tempo di “fine della storia”; è la fine del gruppo sociale che si costruisce sulla forza della solidarietà di un comune lavoro sociale.
La lotta per la ridistribuzione delle risorse e per l’uguaglianza si ristruttura al ribasso come lotta per il riconoscimento. Una volta che l’orizzonte della grande uguaglianza collassa e non riesce più ad operare come il motore di speranze e di movimenti sociali alla soggettività inclusiva, anzi super-inclusiva, dell’essere umano emancipato dall’alienazione del lavoro e del comando si sostituisce la frantumazione della soggettività in particolarità refrattarie ad un’unica narrativa. Ciò ha una doppia declinazione.
Da una parte riparte la giostra delle nazionalità e delle etnie. Di fronte ad una società che non può più alterarsi e trasformarsi nelle sue linee di frantumazione sociali ed economiche, la rivendicazione si sposta nell’affermazione di ciò che si è di già, o di ciò che si fu. Le gerarchie non sono negate, si richiede loro solo di giustificarsi in un continuo rapporto di riconoscimento di ciò che già si è. Se la rivoluzione non è possibile, ci si rivolge alla tradizione od alla propria dose di desideri e di buona vita. A ciascuno il suo, principio della giustizia distributiva, si ridefinisce nei termini di una ricomposizione di identità plurali e spesso tra loro esclusive e reciprocamente rivendicative. In questo contesto frantumato la cittadinanza sembra fornire un nuovo appiglio per pensare una società giusta. Ma nuovamente in questo terreno questa nozione può significare o attiva partecipazione o titolarità di benefici ed insomma di privilegi oppure mera appartenenza. Il groviglio qui è difficile da sciogliere.
Tanto più che la globalizzazione che risucchia l’emancipazione accompagna flussi migratori crescenti, ed una pluralità di stili di vita prima solo appena intuita o immaginata. La religione insieme alla nazione o al genere si affaccia prepotente come bussola per orientarsi in un mare di possibili forme di vita. E sono dunque idoli potenti che si ripresentano alla ribalta del discorso pubblico, che ora si vede minacciato dall’assolutezza dei princìpi messi in gioco: l’Assoluto, il Sangue, l’io nostro profondo come che esso emerga. O talvolta ci si accontenta di un marchio, di un simbolo, di una visibilità. Si contesta facendosi marchiare con un tatuaggio, al di qua del riprendersi una vita di alienazione. Alla vita nuda dell’esistenzialista che si sapeva accompagnato e protetto dalla “classe” o dal “partito” si sostituisce il corpo tatuato, e la propria immagine, la propria foto, moltiplicata per mille dai social media.
Ma la cittadinanza rimane ciò che essa sempre fu, una partecipazione che radica in un contesto sociale, o in una convivenza che pretende di farsi riflessiva ed attiva. Nazione, etnia, religione, e fors’anche il genere, come realtà radicate in un’essenza opaca all’esistenza, sembrano esserle ostili. Si ripropongono fantasmi identitari che mal si adattano alla pluralità degli stili di vita.
Sappiamo che della cittadinanza si offrono due grandi ricostruzioni, quella romantica, organicista, della mera appartenenza culturale ed etnica, per la quale il popolo è una entità completa, che non può rinnovarsi ma solo trascinarsi nel sempre uguale. Qui domina il principio dello jus sanguinis. Cittadino sarà il rampollo di cittadini. Cittadinanza come genealogia, e pedigree. Agli altri, a chi bennato non è, non resta che rassegnarsi alla sorte di soggetti di seconda classe, “meteci” nel miglior dei casi. Una tale ricostruzione però mal si adatta al pluralismo sociale e soprattutto alla ontologia stessa delle comunità politiche, che sono comunque percorse dalla differenza e sì anche dal conflitto. Lo jus sanguinis tale conflitto non lo attenua, ma occultandolo lo radicalizza, producendo sacche resistenti di esclusi. Si pensi per esempio a ciò che è accaduto nei paesi baltici all’indomani della ritrovata indipendenza nazionale. La paura del Russo, e in genere dell’Altro, ha fatto sì che la nazionalità fosse rigidamente ancorata a criteri strettamente identitari, con l’effetto di privare della nazionalità, e per certi versi della stessa soggettività giuridica, quasi la metà dei residenti nel paese. Si alimenta così il rancore, se non l’odio. Non si produce integrazione, bensì distanza, devianza e differenza radicale.
L’altra grande dottrina della cittadinanza è quella dello jus soli: si è cittadini solo in quanto nati e residenti nella città, nello Stato. È la soluzione liberale, democratica, quella adottata, com’è noto, dagli Stati Uniti d’America. Essa non esclude, bensì include. E si pone permanentemente la questione di un popolo che non è mai completo, perché la politica è essa stessa ricerca e costruzione di identità. Qui non valgono idoli inavvicinabili che non possano sfidarsi, o riconciliarsi con argomenti secolari e discorsivi. Il sangue qui – se si vuole — si è fatto acqua fresca di fonte, che scorre secondo la storia della convivenza tra i soggetti che ricercano un intendimento. Ciò travalica la teoria meramente convenzionale della cittadinanza, per la quale questa si dà solo in virtù dell’adesione a certe regole o princìpi. Abbisogna invece di una pratica, di un contesto di vicinanza, di interazione.
Del resto il discorso celebrativo della “nazione”, come ha sottolineato Hannah Arendt in tutta la sua opera, allorché si irrigidisce sulla ascendenza di sangue di quella, finisce per scivolare nella esaltazione della “razza”, e questa significativamente e paradossalmente assume un connato anti-nazionale. Non è un caso che la “nazione” sia l’arma concettuale adoperata dai democratici francesi che intendono ricomporre la frattura delle gerarchie feudali in una comunità di uguali, di contro alla “razza” di cui si fa forte l’aristocrazia la quale si inorgoglisce d’essere il frutto d’un albero genealogico che rimonta alla nobiltà franca, una genia di etnia germanica. La “razza” è tanto internazionalista forse quanto la “classe”, ma in senso contrario, nell’attivazione di un procedimento ad excludendum dei “mal nati”, dei “commoners”, degli umili e dei disgraziati. Mentre la nazione di questi vuole il riscatto e li innalza al rango di cittadini.
Potremmo parlare anche di una “terza teoria” della cittadinanza. Ubi bonum, ibi patria. Così anche la intendono la cittadinanza quei tanti dei nostri antenati ed ora dei nostri giovani che l’Italia abbandonano alla ricerca di una terra promessa, di un futuro migliore, oltre le clientele, e le chiusure di un sistema legato a caste di ogni tipo. E lo jus sanguinis, angustamente concepito, segna una cittadinanza castale per l’appunto. Ma alla città degli esseri umani che si riconoscono mutuamente il diritto alla ricerca della felicità quel criterio non può che risultare angusto, stretto, meschino, infine ingiusto. Joseph Roth, perennemente alla ricerca della cittadinanza real-imperiale perduta, rovesciava il detto ciceroniano dell’ubi bonum, ibi patria. “Wo es mir schlecht geht, dort ist mein Vaterland” – dice. Robert Neumann portava questa idea all’assurdo: Ubi Bombe, ibi patria, dove ci sono le bombe, dove mi si bombarda, lì è la patria. E lo diceva per suggellare il legame con l’Inghilterra dove spiovevano le bombe della Luftwaffe. Dove sto male, lì è la mia patria. Dove mi si attacca, lì è il mio posto. Ovvero: là dove condivido le sofferenze degli altri, nel luogo le cui cose mi fanno soffrire, perché esse mi concernono, mi interessano, soltanto lì si può parlare di patria.
La cittadinanza si guadagna, e si merita, se la cosa pubblica e i destini di chi ci sta accanto, o di chi si rivolge a noi, e ci chiede asilo, protezione, non ci sono indifferenti. Si è concittadini, se si condivide un luogo, una stessa strada, un “suolo”, una situazione ed un interesse di convivenza che ci sta a cuore e che ci impegna. Il resto è spesso solo zavorra.
SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE