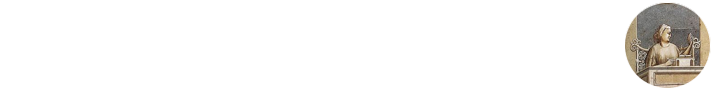Editoriale di Massimo La Torre
Il 2016 sarà probabilmente ricordato come l’annus horribilis dell’Unione Europea. Iniziatosi con gli echi della crisi greca del luglio 2015, che aveva visto il paese ellenico subire il diktat crudele dell’Eurogruppo, quale che fosse stato l’esito del referendum indetto dal partito di governo, Syriza, e con l’imposizione di nuove e più dure condizioni per ottenere i crediti necessari a mantenere il paese nella zona Euro, al di là del triste scenario greco si era quasi subito profilata un’altra crisi di carattere quasi epocale, la fuga di milioni di rifugiati dalla Siria verso i lidi più sicuri dei paesi europei. Centinaia di migliaia di persone in marcia per sfuggire alle bombe, agli orrori della guerra civile ed alla fame, riversatesi sui lidi di una Grecia esausta e demoralizzata a cui quella stessa Unione che l’aveva umiliata ora chiedeva di farsi carico di una siffatta migrazione biblica.
Le masse di rifugiati hanno innescato reazioni e processi che si credevano ormai resi impossibili dall’avanzato stato dell’integrazione europea e dalle conquiste del diritto delle genti. La reazione, fomentata da governi incapaci di assumersi le proprie responsabilità, e dalla mancanza di una politica europea di accoglienza e di regolazione dei flussi migratori, è sfociata in provvedimenti e toni e prese di posizione che ci hanno riportato indietro di molti decenni. Ci hanno riportato ai tempi delle frontiere invalicabili, e delle espulsioni di massa, a situazioni in cui il destino di bambini e famiglie è legato alla buona disposizione di un doganiere o di un poliziotto di frontiera, in cui la clandestinità è una strategia di sopravvivenza e un’occasione per il più forte di una ghiotta porzione di lavoro sottopagato.
E così, soprattutto nell’Europa dell’Est, e nei suoi staterelli frantumati da nazionalismi sempre meno inclusivi e sempre più ingenerosi, vi è stata una rincorsa all’egoismo, allo sciovinismo, la disseminazione della paura dell’altro, il gesto scomposto contro il pericolo dell’invasione barbarica. Tutto ciò poi aggravato dal ripetersi e dall’acuirsi di episodi di terrorismo islamista che facilmente si lasciano ricollegare al flusso migratorio in atto proveniente in gran misura dai paesi di quel Medio Oriente destabilizzato da un quindicennio di guerre preventive e di grandi manovre per il ridisegno del mondo arabo sotto il segno dell’egemonia della grande ed unica potenza imperiale superstite, quel medio Oriente che vede ora trionfare i tagliagola e i “martiri” del fanatismo pseudoreligioso .
Eppure dinanzi questo quadro di crisi, che si progetta quasi come fato permanente e, se non tale, certamente duraturo, l’Unione Europea e i suoi Stati membri sono rimasti impotenti, incapaci di progettare una risposta concordata e coerente. Ognuno si è rifugiato nel calduccio della propria politica nazionale, e nell’affermazione della sacralità delle proprie frontiere. Qualche muro è stato costruito, qualche passo di frontiera è stato chiuso o militarizzato, qualche cane è stato aizzato contro dei disgraziati in cerca di una nuova vita. Unica strategia vera quella tedesca di strizzare l’occhio alla Turchia neo-ottomana di Erdogan, essa però in gran parte corresponsabile dei disastri della Siria, grazie alla sua ambigua relazione col mondo islamista, ed al suo pervicace odio dei Kurdi, considerati il nemico esistenziale. La missione principale dello Stato turco pare proprio di evitare che si possa dare un’entità politica indipendente kurda, la quale minaccerebbe l’integrità del paese di Atatürk, per un buon terzo erettosi su territori abitati da popolazioni di lingua e cultura kurda. Ed è a questo paese, di forte tradizione autoritaria, che ci si propone di affidarsi per frenare l’esodo migratorio, concedendogli denari e privilegi di entità assai rilevante, ricostituendo una sorta di alleanza strategica memore di quella antica, ma sfortunata, degli Imperi centrali di un secolo fa.
Tutto dunque è in movimento, e in bilico, in questa Europa dell’estate 2016. L’economia non decolla, soprattutto quella dei paesi mediterranei oberati dai pesi imposti dal Fiscal Compact e schiacciati da una bilancia commerciale negativa che non ha un meccanismo di compenso nel sistema della moneta unica. La Germania, con un superavit commerciale formidabile, nondimeno si irrigidisce ancora di più sulla politica dell’austerità e non molla la presa dei vincoli di bilancio imposti ai parlamenti nazionali. Il Keynesismo è bandito una volta per tutte dall’orizzonte politico degli Stati membri, spettro che agita i sonni dei neoliberali e dei conservatori più di quanto forse un tempo avesse fatto il Comunismo. L’Europa è una nuova Hoover City che invano spera nel suo Roosevelt e in un “new deal”. La democrazia deve piegarsi ai dettami di quello che un tempo poteva ancora presentarsi come un dittatore benevolo, ma che non è più tale da quando parla per bocca di Dijsselbloem, presidente dell’Eurogruppo, o secondo la Weltanschauung ordoliberale di Schäuble.
Confidiamo nella Banca Centrale Europea, e nelle buone intenzioni di Draghi, ma non c’è qui sovranità popolare che tenga, né programma di partito che abbia qualche cosa da dire al riguardo. Chiusi nelle torri finanziarie di Francoforte i banchieri europei decidono del destino delle nostre economie, ma non solo di queste. Si tratta innanzitutto delle nostre vite, del futuro dei nostri giovani. La lettera firmata da Trichet e Draghi nell’agosto del 2011 ed inviata all’allora capo del governo italiano Berlusconi, indicava nel dettaglio un programma politico da realizzare (tra cui la riduzione degli stipendi dei pubblici impiegati e l’abolizione delle Province), e dalla cui pronta realizzazione si faceva dipendere l’indipendenza finanziaria del paese. E così arrivò il “governo tecnico”, e la riforma delle pensioni, che sembra condannare alla miseria la vecchiaia d’intere generazioni, e poi l’azzeramento del diritto sindacale, una volta vanto ed orgoglio della scienza giuridica italiana. Per non parlare dei memoranda of understanding per i paesi della zona euro che hanno dovuto ricorrere all’ausilio del Meccanismo di Stabilità Finanziaria, documenti che valgono assai più di qualunque programma di governo o di qualsiasi dettato costituzionale.
Ed è a questo punto che arriva il Brexit, il sì sonoro e rumoroso dei Britannici nel referendum sulla proposta d’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. La Gran Bretagna ha deciso per l’uscita, per l’abbandono dell’Unione. Una decisione questa per certi versi inattesa, soprattutto da molti di coloro che avevano ispirato e condotto la campagna per il Brexit. L’evento è epocale. Le “magnifiche sorti e progressive” dell’ever closer union subiscono un rovescio probabilmente definitivo. È il primo caso d’un paese membro che decide d’uscire dall’Unione, ed è un paese chiave, storicamente protagonista di tutta la storia europea, che compie questo passo. Un fatto anche in contraddizione con tutta la storia britannica che si contraddistingue, dai suoi inizi, per la caparbia volontà dell’Inghilterra di stare e contare in Europa, di non essere espulsa dai suoi territori, a partire dalla guerra dei Cent’anni fino alle due ultime guerre mondiali, nelle quali il Regno Unito afferma il suo diritto di decidere delle sorti del continente europeo. Il paese che è entrato in guerra per difendere la neutralità belga e l’indipendenza della Polonia, e in quelle due guerre si è dissanguato ed ha sacrificato la propria egemonia imperiale, si ritira ora da quel campo di battaglia, tra l’altro per non ricevere degli operai polacchi in casa. La nazione che affronta Napoleone a Waterloo per non lasciargli campo libero in Europa, e potersi sedere al congresso di Vienna insieme alle altre potenze europee e determinare il destino del continente, divorzia sdegnoso da quel rapporto che pure ha fatto la sua potenza e, anche se gli sciovinisti dell’UKIP lo ignorano, la sua stessa identità culturale.
Il Brexit così è un qualcosa di inedito, di esplosivo nella dinamica europea delle relazioni internazionali, di triste ed autodistruttivo per la stessa autostima e per la narrativa fondativa del Regno Unito. Tanto è così che gli stessi suoi ispiratori ora giocano al ribasso e dànno del Brexit una versione edulcorata, che se presentata nei termini in cui lo si fa ora probabilmente non avrebbe potuto produrre la maggioranza che lo ha reso un successo. Basta leggere l’articolo di Boris Johnson di domenica 26 giugno sul The Telegraph per rendersene conto. Si vuole mantenere il mercato unico, e con esso la libera circolazione delle persone (ma sottoposta ad un sistema di “punti”, così com’è in buona sostanza già ora). Ci si sbraccia in proclamazioni di europeísmo: “I cannot stress too much that Britain is part of Europe”. Unico grande trionfo rivendicato, il non dover essere più subordinati alle sentenze della Corte del Lussemburgo…, di cui però i votanti a favore del Brexit probabilmente in larghissima maggioranza non hanno alcuna nozione e comprensione. Lo stesso Nigel Farage, il leader dell’UKIP, nel suo discorso d’addio al Parlamento Europeo, al di là delle battute dispregiative dirette ai suoi colleghi, e le espressioni di un tronfio nazionalismo isolano, si appella alla buona volontà degli Europei, vuole anche lui continuare a fare buoni affari in Europa, vuole vendere e comprare a buon prezzo; al mercato unico non vuole rinunciare, e minaccia che altrimenti saranno dolori, ovviamente non per Albione che “rules the waves”, ma per la perfida e centralistica, Unione Europea.
Il voto britannico, voto inglese soprattutto, visto che Scozia e Irlanda del Nord si sono espresse con ampie maggioranze a favore del Remain, va spiegato innanzitutto in una prospettiva di politica tutta nazionale. In un certo senso questo voto è la rivolta finalmente dichiarata e libera contro ciò che è successo alla Gran Bretagna negli ultimi quarant’anni. È una rivolta contro il Thatcherismo, potrebbe sostenersi. Ed infatti il Brexit è massiciamente adottato dalle classi popolari e da quelle città e regioni che la Thatcher ha violentemente destrutturato ed impoverito a partire dai primi anni Ottanta dello scorso secolo. Ciò che è avvenuto in quel paese è stata un’operazione tesa all’eliminazione per certi versi fisica della classe operaia. In odio a questa, per cancellarla socialmente, le si è tolto il terreno sotto i piedi, la sua base economica, l’industria. In maniera sistematica la Gran Bretagna, e soprattutto l’Inghilterra, è sottoposta ad un processo di deindustrializzazione. Si chiudono le miniere, si chiudono i cantieri, si chiudono le acciaierie, si dismette la flotta della pesca. Intere città vengono trasformate da centri fiorenti di produzione industriale in ghetti dove si affollano masse, non più capaci di coscienza di gruppo mediante il lavoro, mantenute per decenni con sussidi di disoccupazione.
All’orgogliosa classe operaia britannica si sostituisce una massa di disgraziati cui è stata rubata l’identità ed il rispetto che un tempo gli proveniva dal lavoro. Il proletariato, compiendo una predizione di Marx, si trasforma in folla disordinata di coolies, di emarginati, di disperati, di soggetti privi ormai d’ogni prospettiva e nozione di solidarietà di classe. Il popolo si è fatto “popolazione”, “moltitudine”. E così le Unions, potentissime fino agli anni Settanta, spariscono o si fanno esigue; il Labour adotta, con Tony Blair, la stessa visione del mondo della Thatcher. È il mercato, il gioco di imprenditore e consumatore, ciò che produce ricchezza – così almeno si crede. Il lavoro non conta più, ché questo lo si si può ottenere per quattro soldi e senza rispetto. È il capitale che si crede capace di riprodursi per mezzo di se stesso, e che a tal fine rivendica assoluta libertà di circolazione e d’impiego. Ogni relazione sociale si ridisegna nel gioco crudele di offerta e domanda, e si fissa nella “folla” dei consumatori. Ma questa “folla” perde l’istinto comunitario, universalista, di popolo. E con questo gli viene a mancare l’empatia internazionalista per gli sfruttati, quale che sia il loro paese, o la loro razza. Si rifugia nei tratti identitari più primitivi, l’essere bianco, il bere birra, e ruttare rumorosamente contro i soggetti, i tanti stranieri, che la globalizzazione rovescia sulle coste inglesi. L’identità di classe evapora in quella d’una partigianeria sportiva, d’un club di calcio.
Il Brexit è il frutto di questa decadenza della società inglese e della sua progressiva mancanza di vertebrazione. L’Unione Europea viene identificata come cosa di ricchi, di chi ha successo, o cosa di emigranti, di chi viene da lontano per toglierci il lavoro (e forse anche le donne). In questa situazione ed in questo clima ha buon gioco il demagogo, e la Gran Bretagna ne è piena. Il Brexit è anche il prodotto della frivolezza della cultura che si produce e si autocelebra tra Oxford e Cambridge, dove l’argomento brillante, “astute”, vale più della tesi che si difende. Così come la filosofía anglosassone sempre più prende una deriva “giustificativa”, che in verità è pura “advocacy”, gusto avvocatesco di poter dire qualsiasi cosa, a condizione di trovare un argomento più o meno persuasivo che lo supporti, così Brexit o Remain si confrontano con strategie vuotamente retoriche, senza convinzione profonda per la bontà dell’uno e dell’altro esito, e senza impegnarsi nell’analisi delle conseguenze anche esistenziali dell’alternativa messa in gioco. Boris Johnson argomenta da brillante avvocato per il Brexit, lo stesso fa (con meno forza) Cameron per il Remain. E la “plebe” si infiamma per l’uno o per l’altro come se si trattasse di una partita di calcio, dove alla fine, quale che sia l’esito della partita, ci si trastulla con qualche pinta di birra e poi si va dormire un po’ brilli, ma senza troppa preoccupazione per ciò ch’è successo.
Ma c’è un’altra lettura possibile del Brexit. Ed è quella che deve interessarci di più. Una lettura in prospettiva europea. L’Unione Europea è un progetto di civilizzazione delle relazioni tra gli Stati europei che fino alla metà del secolo scorso si sono fatti guerre ed hanno causato immani sofferenze e disastri per l’intero pianeta. Ciò è certo, e non può essere ignorato. Lo è ancora più oggi, in un quadro geopolitico frantumato da troppi nazionalismi esclusivi. Non bisogna dimenticare che l’Europa orientale è in gran parte una frattaglia di staterelli prodotti dal crollo dell’Unione Sovietica e della sua egemonia. Non c’è più la Cecoslovacchia, ma solo la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Ci sono i paesi baltici, e quelli balcanici usciti dal crollo della Yugoslavia. A tutti questi l’Unione offre una struttura capace di dare qualche vertebrazione ed un certo equilibrio. Senza l’Unione Europea l’Europa di oggi sarebbe forse più instabile, perché più frammentata, dell’Europa uscita dal Trattato di Versailles. E poi nell’Unione c’è ancora la memoria dei “trenta gloriosi” anni del secondo dopoguerra che hanno visto pace e benessere assicurati mediante lo Stato sociale, sia pure in termini e con modalità diverse nei vari Stati membri.
L’Unione Europea è una creatura di Settembrini, non di Naphta (vedi la Montagna incantata di Thomas Mann). La sua originariamente è una struttura cosmopolita e pacificatrice, pluralista, non imperiale (con buona pace di Jan Zielonka). A partire dalla caduta del muro di Berlino, tale panorama nondimeno si è modificato. Ciò perché la Germania riunificata è uno Stato membro di dimensioni che eccedono assai quelle degli altri. Fino all’89 la Germania aveva un peso (una popolazione innanzitutto) grosso modo uguale alla Francia, all’Italia ed al Regno Unito. Ma dopo non è più così. La Germania è di nuovo un gigante assiso al centro dell’Europa. Un tale gigante avrebbe dovuto operare in maniera moderata, e prudente, per non rischiare di riattivare una memoria storica di sospetto e d’avversione. Ma la moneta comune, l’Euro, invece di vincolare il gigante, come avrebbe voluto Mitterrand, lo rende il soggetto padrone dell’Unione Monetaria. Ed ancora nella crisi dopo il 2008 la Germania si conduce in maniera intemperante. Umilia la Grecia e la sua democrazia, la spinge alla miseria, la mette in ginocchio con gusto vagamente sadico. Impone la “regola aurea” della parità di bilancio. Moralizza sulla condizione di Stato creditore e debitore. E l’Inglese anziano lo vede, e ricorda antiche storie. Il Brexit può allora plausibilmente interpretarsi anche nei termini d’una mossa di difesa contro una Germania nuovamente percepita come proiettata ad affermare la sua egemonia über alles.
Quello dell’Unione Europea è tendenzialmente un diritto mite. Ciò però si è modificato radicalmente a partire dagli anni Ottanta, con l’Atto Unico Europeo prima, e poi col Trattato di Maastricht, e poi con la legislazione di emergenza a partire dal 2009 (Trattato di Stabilità rivisto, Fiscal Compact, Six Pack, Two Pack, ecc.). Si afferma il progetto di cortocircuitare lo Stato sociale nazionale con una costituzione economica sovranazionale di segno liberista, neoliberale. Ciò si fa elevando a princìpi costituzionali fondamentali i dogmi del sistema economico del libero mercato contro la logica solidaristica delle costituzioni nazionali. E lo si porta a termine immunizzando la costituzione economica neoliberale mediante un diritto sovranazionale reso ora indisponibile alle democrazie degli Stati membri. Senza compensare tale deficit con nessun meccanismo di rappresentatività democratica efficace a livello nazionale. Ciò ha come effetto il progressivo smantellamento dello Stato sociale, e la perdita dei diritti sociali delle costituzioni nazionali, e maggiore disuguaglianza, e gerarchia, e da ormai troppi anni anche maggiore povertà, e non solo nei paesi più deboli, non solo in Grecia. Sono i diritti sociali le vittime sacrificali dell’ordine giuridico comunitario. Ma così facendo è la democrazia che viene smontata progressivamente, perché, ricordiamolo, “i diritti sociali sono – come dice Habermas – le stecche del busto della cittadinanza democratica”. Con queste si comprime e si contiene la pancia debordante d’un capitalismo sempre troppo ingordo.
Il Brexit allora è una risposta all’emergenza del liberalismo autoritario e rappresenta un tentativo di riappropriarsi del potere di cittadinanza. È la rivolta dei poveri contro i ricchi, delle periferie contro le capitali, di chi non ha più il controllo delle proprie vite e del proprio futuro contro coloro che di tale controllo si sono arrogati il monopolio. Se non si capisce questo, se non si legge il Brexit in prospettiva europea, come protesta democratica malgré tout, e non si rimedia, con più democrazia, e più cittadinanza, ricomponendo le ferite gravissime inflitte allo Stato sociale, allora non saranno solo i nostri conti in banca a traballare, ma è la stessa civilizzazione delle relazioni internazionali di cui si è fatta protagonista l’integrazione europea che si espone ad un rischio gravissimo. Il peggio che possa capitare all’Unione, ora, è che dal Brexit si tragga come lezione che la democrazia è pericolosa, che il popolo è inaffidabile, e che una volta di più vale confidare nella saggezza del tecnico, nell’“autorità indipendente”, nell’autocrate illuminato e benevolo.