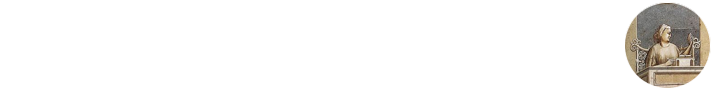EDITORIALE – Il grande smottamento
DI MASSIMO LA TORRE
I. Puntualmente in autunno arrivano ormai delle grandi piogge in Italia, ed ogni volta e sempre di più la terra si disfà. Smotta. Crolla. Crollano colline intere, pezzi di montagna, e il fango invade borghi, paesi, città. È il risultato di decenni di abbandono e di incuria di boschi, foreste, coltivazioni. Una volta le colline italiane erano ben tenute, scavate in terrazze a gradini, per permetterne l’utilizzo agricolo. Le si vedeva dalla Liguria alla Sicilia. Ma la grande migrazione dai campi, l’esodo di massa dalle campagne verso la città, dagli orti alle fabbriche, e la fine della cultura millenaria dei contadini, ha modificato il paesaggio e la strutturazione geologica di quello che fu il Bel Paese, e non solo di questo. In Spagna ci sono già centinaia di antichi paesini rimasti solo con qualche decina di abitanti, vecchi e vecchissimi in genere che resistono a staccarsi da quanto ha costituto il loro mondo vitale. Vari altri borghi sono niente più che mucchietti di case desolate, dove nessuno più abita, senza voci umane. Pietre su pietre, che cominciano a traballare ed a cedere. Ci ritroviamo dinanzi, insomma, ad un enorme smottamento, terra e pietre, una volta solidi corpi su cui vivere e marciare e costruire e produrre, che ora miserabilmente vengono giù.
C’è però un più generale fenomeno di scivolamento e smottamento, ed è quello che riguarda il sistema delle relazioni tra Stati e nazioni, così com’è si era costruito alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo invero è stato preceduto da uno smottamento interno agli Stati. Dopo la Guerra Mondiale, dopo le distruzioni e i massacri di questa, si mise mano ad una impresa di ricostituzione delle relazioni politiche ed economiche, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. A livello interno degli Stati si assiste ad una riaffermazione della politica d’intervento pubblico dandole un chiaro giro sociale. È lo Stato sociale che si propone, anche come alternativa ai programmi più radicali, quelli comunisti, di socializzazione dell’economia. Si impone l’economia mista, nella quale fondamentale è il ruolo dell’intervento pubblico. In Italia a questo proposito paradigmatica e l’azione dell’I.R.I., che si fa carico da una prospettiva statale, della politica energetica del paese. Lo Stato in prima persona si fa attore produttivo, gestendo per esempio in prima persona pezzi di settori economici, come quello alberghiero o quello dell’automobile e delle acciaierie. In Francia accade qualcosa di simile, con l’accoglimento dell’idea dei piani di sviluppo e di politica industriale pensati per un tempo pluriannuale.
Allo stesso tempo si dànno costituzioni di un’evidente ispirazione solidaristica. La figura centrale di riferimento, se si vuole il mito fondante qui è il lavoro, non l’impresa, come è esplicito nel dettato dell’articolo uno della costituzione repubblicana italiana. Ma la ricostituzione di una densa dimensione pubblica la si fa senza riproporre lo schema dell’anarchia delle relazioni internazionali, dettato da una idea assoluta di sovranità nazionale. Questa si apre, si confronta e si modera con rispetto al diritto internazionale. Si bandisce innanzitutto la guerra come strumento possibile di politica estera. Ciò trova una corrispondenza sovranazionale nell’ordine normativo della nuova organizzazione delle Nazioni Unite. Il progetto e l’opera insomma è quella di regolare relazioni e territori prima solo diretti dai rapporti di forza esistenti. Si dà fiducia al diritto, coniugato col pubblico, e con la solidarietà. Ciò vale anche e soprattutto per ciò che concerne l’ordine economico internazionale, il cui momento – diciamo – costituzionale è dato dagli accordi di Bretton Woods nel 1944. Gli scambi di merci e valuta tra i Paesi che vi aderiscono sono strutturati secondo regole precise, ed abbastanza rigide, non v’è prevista paradigmaticamente nessuna libertà di circolazione dei capitali, né normatività cui si accompagna perché questa sia osservata e risulti efficace, l’istituzione di organi come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, il cui compito è di intervenire là dove si creino forti squilibri nelle bilance dei pagamenti. A ciò si accompagna una nuova importante narrativa che permea il discorso egemone nella sfera pubblica.
La nuova narrativa si articola su due perni. Innanzitutto, si pone sotto sospetto il mercato concorrenziale del capitalismo senza regole. Ciò è tanto condiviso che la stessa iniziale contromossa capitalistica muove da una simile assunzione. Il capitalismo lasciato a se stesso è distruttivo ed autodistruttivo. Da qui si traggono tre lezioni tra loro confliggenti, quella radicale per cui il capitalismo va rimpiazzato con una economia socialista, quella neoconservatrice dell’ordoliberalismo e quella del neoliberalismo, per cui il capitalismo per sopravvivere deve darsi una forte cornice istituzionale.
Per la socialdemocrazia le istituzioni servono a moderare o domare, se non proprio a vincere, il capitalismo, per il neoliberalismo e l’ordoliberalismo le istituzioni hanno la funzione di rendere possibile e promuovere il capitalismo. Per certi versi la logica è la stessa, e il ruolo del diritto in entrambi i casi è strumentale, orientato all’efficienza e dettato da un imperativo ideologico di necessità. Da qui anche la preminenza dell’interpretazione ideologica delle disposizioni normative e dei diritti soggettivi, e dell’adozione indiscriminata del principio di proporzionalità, a partire della giurisprudenza costituzionale della Germania federale, come Grundnorm dell’ordine costituzionale. Anche se la centralità del diritto nel neoliberalismo è rimpiazzata dalla centralità della politica e dell’esecutivo, un tratto che paradossalmente lo accomuna al Welfare State più intervenzionista. In questo però è il burocrate a dettare la regola, mentre nel neoliberalismo – il modello statunitense insegna – è direttamente il politico ad assolvere questo ruolo. Tuttavia, la narrativa nei due modelli è contrapposta. La socialdemocrazia ci racconta il mercato come dimensione a rischio, pericolosa, da controllare e ridurre. Il neoliberalismo invece, pur essendo intervenzionista, ci rappresenta il mercato come la soluzione ad ogni problema economico, e anzi sociale; la panacea è allora la concorrenza accompagnata dalla trasformazione della figura del lavoratore in imprenditore. Non avremo più così sul terreno sociale che venditori e consumatori. Il legame di solidarietà viene reinterpretato in termini sinallagmatici, come rete di contratti, in regime di concorrenza.
La seconda narrativa diciamo così fondante dell’epoca del secondo dopoguerra è che vi è adesso un sistema organizzato pacificamente delle relazioni tra Stati. La guerra è in via di principio bandita, e dunque considerata una violazione del diritto internazionale. Ciò si riflette nel dettato di varie nuove costituzioni, vale innanzi tutto per l’Italia. Ciò si manifesta anche nell’ampia rete di organizzazioni internazionali che affiancano il sorgere dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Particolarmente importanti gli accordi di Bretton Woods, firmati già nel luglio del 1944, in piena guerra, con i quali si strutturava un sistema internazionale di relazioni di cambio tra monete agganciato al dollaro e questo ad una certa quantità d’oro. Cadde il sistema il 15 agosto del 1971, allorché il presidente Nixon volle avere le mani libere per stampare moneta senza dover dipendere dalle riserve d’oro dell’Unione. E da allora non abbiamo più un sistema regolato di cambi, ad eccezione all’area euro che ha irrigidito l’originaria idea di Bretton Woods, e reintrodotto un simulacro del gold standard, il sistema aureo.
Abbiamo avuto poi un sistema internazionale che regolava il commercio internazionale, coordinando le politiche protezionistiche dei vari Stati membri, il GATT prima e più di recente, e in modo radicale, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, la quale oggi però è in crisi, incapace di operare soprattutto nei rapporti commerciali tra Cina e Stati Uniti. Ma è il divieto o il tabù della guerra che è saltato. In maniera progressiva, a partire dalla caduta del muro di Berlino. Nemmeno un anno dopo questa c’è la prima guerra del golfo, il massiccio intervento americano In Iraq, celebrato come un efficace contributo alla pace del mondo. Ma ciò che dava a vedere al mondo era l’immensa capacità militare e la potenza di fuoco della macchina militare americana. Nel mentre l’Unione Sovietica si disfaceva e con questa la Jugoslavia, e da lì nuove terribili guerre, nel cuore dell’Europa a qualche centinaio di chilometri da Trieste. Massacri, pulizia etnica, nuovo olocausto.
Nel 1999 la NATO bombarda Belgrado, la capitale della Serbia, senza la copertura di una risoluzione del consiglio di sicurezza dell’ONU. Ed arriviamo all’11settembre 2001. È l’attacco alle torri gemelle di New York, cui si risponde con l’invasione dell’Afganistan, una guerra durata più di vent’anni per espellerne i Talebani ma poi riconsegnando loro tutto il paese in una ignominiosa ritirata. Ma l’evento decisivo doveva essere un altro. Fu quando nel marzo del 2003 gli stati Uniti attaccarono e invasero il pacifico Iraq. Pacifico sì, perché con un esercito scassato dalla prima guerra del Golfo, quella dell’autunno 1990, nella quale gli Stati Uniti e Gorbačëv, ancora regnante nella Unione Sovietica, dimostrarono al mondo che era finita la guerra fredda, cioè la bipolarità dei poteri egemonici mondiali, quello americano e quello russo, e che ora non v’era che unipolarità, solo un potere capace di intervenire liberamente e militarmente là dove si ritenesse necessario.
II. Con la seconda guerra del Golfo, quella del 2003, si dava legittimità definitiva alla guerra preventiva, che aveva scandalizzato Hans Kelsen e che invece aveva celebrato Michael Walzer. Lo jus ad bellum ritornava ad essere l’asse portante della sovranità statale, meglio imperiale, giacché in realtà lo si concedeva solo a poteri particolarmente forti e protetti. Vi è nel primo decennio del nuovo secolo un momento neo-imperiale nel quale l’Occidente anglo-americano si ripropone con le vesti dell’impero più o meno benigno capace di farsi governance globale. “Impero” e “governance” sono due termini che rimandano l’uno all’altro. Essi, infatti, comportano un certo ripudio della centralità dello Stato e della sua ideale aspirazione ad essere “Stato di diritto”, macchina sottoposta a norme giuridiche ed a procedure pubbliche ed istituzionali di deliberazione e di controllo. Un impero invece rinvia ad un potere i cui contorni e confini, e le cui regole d’ingaggio, non siano circoscritte e definite una volta per tutte. L’impero è una forma “liquida” di governo; e lo stesso la “governance” che si proietta come soft power e soft law, e la cui figura reale più definita sarebbe fornita dall’Unione Europa e dalla sua moneta unica, l’Euro. L’Eurogruppo, che decide dell’euro e della sua gestione finanziaria ed economica, è esemplarmente un organo di “governance”. Non ci sono regole interne di condotta, regole almeno formali. Non ci sono verbali delle riunioni. E decide del destino delle economie dei Paesi della zona euro. Il ministro greco Varoufakis ci ha ben illustrato le dinamiche opache del decision-making di un tale organo, in barba alla proclamata democraticità della costruzione istituzionale dell’Unione Europa.
E di “impero” sembrano ubriacarsi i politologi statunitensi attorno alla seconda guerra del golfo. Particolarmente eloquente al proposito è lo storico britannico Niall Ferguson. Questo è autore, tra l’altro, di una storia dell’impero britannico, Empire: How Britain Made the Modern World, 2003, e di un’altra ricostruzione del potere imperiale statunitense, Colossus: The Rise and Fall of the American Empire, 2004, e poi di una meditazione sulla civiltà occidentale, West, contrapposta al Rest: Civilization: The West and the Rest, 2011. Il problema dell’Occidente, e specialmente degli USA, sarebbe, a suo dire, di non avere il coraggio di rivendicare il proprio schiacciante potere di supremazia sul resto del mondo. «The United States is an empire, in short, that does not speak its name». Dovrebbe invece risolversi ad assumersi «the white man’s burden», come fece per due secoli la Gran Bretagna, e fiera di farlo. Ma gli Americani preferiscono lavorare a Wall Street per arricchirsi, invece di calcare l’elmetto e andare a civilizzare e pacificare l’Oriente. «America’s brightest and best aspire not to govern Mesopotamia but to manage MTV; not to rule the Hejaz but to run a hedge fund». Ciò che bisogna realizzare dunque è l’“Anglobalization”. Tutte tesi abbastanza in linea con un’altra opinionista angloamericana, ma assai meno erudita di Ferguson, Ann Coulter, la quale senza peli sulla lingua ci dice che: «We should invade their countries, kill their leaders and convert them to Christianity». Questo fervore imperialista trova poi una sponda latina nelle tesi difese da María Elvira Roca Barea nel suo volumone Imperiofobia y leyenda negra[1], dove si diagnostica la decadenza della Spagna innanzitutto e poi dell’Occidente in generale proprio a causa del loro rigetto costituzionale della figura dell’Impero, e l’affermarsi di un’alternativa istituzione politica, la repubblica.
Il neoimperialismo angloamericano così si mostra esplicitamente aggressivo e militarista, ed entra apparentemente in rotta di collisione con la tradizione del costituzionalismo democratico europeo, la cui fondamentale, esistenziale decisione è quella di ripudiare la guerra, dunque il pacifismo. E col pacifismo l’attenzione alla giustizia sociale, al welfarediffuso tra i cittadini. Ma ora è proprio ciò che da parte statunitense si rimprovera agli Europei. Si leggano le parole di Zbigniew Brzeziński, che era stato consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Carter e artefice della trappola afgana in cui venne attirata l’Unione sovietica nel 1979. Scrive l’autorevole studioso e diplomatico americano: «Europe’s economic recovery has obscured the longer-run costs of its seeming success. These costs are damaging economically as well as politically. The crisis of political legitimacy and economic vitality that Western Europe increasingly confronts – but is unable to overcome – is deeply rooted in the pervasive expansion of the state-sponsored social structure that favors paternalism, protectionism, and parochialism»[2].
Il successo economico dell’Europa del dopoguerra legato al suo Stato sociale avrebbe reso gli Europei un popolo di edonisti. E di soggetti abituati ad essere protetti. Mancano loro le virtù virili e militari. Stato sociale e pacifismo rimandano l’uno all’altro in un circolo che Brzeziński considera vizioso. Bisognerà allora rinvigorire questa gente decadente di effeminati “socialisti”, e ciò dovrà farsi drasticamente riducendo le dimensioni dell’intervento pubblico e del welfare. Va introdotto nuovamente il mercato concorrenziale e l’egemonia dell’azienda privata. Ci vuole una buona, potente iniezione di neoliberalismo. Che avrà come effetto collaterale di far cadere, oltre le fisime socialisteggianti, anche le illusioni pacifiste e rimedierà all’incapacità d’assumersi responsabilità militari e possibilmente imperiali.
Neoimperialismo e neoliberalismo si ricollegano dunque strettamente e si proiettano come un nuovo robusto modello d’ordine politico interno ed esterno. Qualcosa del genere ritroveremo in quel saggio di Robert Kagan, Of Paradise and Power, pubblicato non a caso nel 2003, l’anno della seconda guerra del Golfo. E Kagan è il marito di Victoria Nuland, oggi sottosegretario di stato responsabile per la politica americana in Ucraina e ben presente ed attiva già nel 2014 nei fatti della Piazza di Maiden a Kiev. Potrebbe anche dirsi, col senno di poi, che la guerra di questi mesi ebbe inizio allora in quella piazza. L’acuta attenzione americana per l’Ucraina emerge anche nettamente nel libro citato di Brzeziński, la cui prima edizione è del 1996.
È in buona sostanza l’imperialismo più o meno liberale, l’imperialismo “light”, che predica Michel Ignatieff, rettore dell’Università centroeuropea prima con sede a Budapest e ora a Vienna. Un principio di questo traboccante imperialismo “liberale” è la guerra preventiva, già giustificata da Michael Walzer nel suo libro Just and Unjust Wars dei primi anni Settanta, e con questa guerra preventiva, per Kelsen un crimine di diritto internazionale, si legittimava di riflesso e a cascata anche la pena preventiva, il tormento preventivo, la tortura, le “dirty hands”, rompendo i sigilli d’un tabù che duecento anni prima era stato imposto dall’opera civilizzatrice dell’Illuminismo. E di questa rottura del tabù della guerra preventiva oggi si appropria la Russia nella sua aggressiva avventura in Ucraina. Ma un altro tabù è ora messo in discussione, l’antifascismo.
La narrativa attorno alla quale si costruisce il nuovo ordine mondiale dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale è che quest’ordine è alternativo a quello che si è appena sconfitto, il fascismo. Il male da vincere è il nazismo e il fascismo e il militarismo aggressivo di cui il Giappone rappresentava il modello asiatico, e Stati Uniti e Unione Sovietica sono uniti in questa lotta antiautoritaria e civilizzatrice. Gli internati ad Auschwitz sono liberati dalle truppe a cavallo dell’Armata Rossa, come è ben raccontato da Primo Levi. Il fascismo è il nemico per ciò che è, regime della violenza per la violenza, gusto della violenza e dell’aggressione, esaltazione della disuguaglianza, razzismo estremo, odio dell’altro e del diverso, arbitrio elevato all’ennesima potenza, culto del forte e del crudele, disprezzo del debole e del compassionevole.
Attorno a questo rifiuto del fascismo si costruiscono le costituzioni del dopoguerra, prima fra tutte quella italiana, ma anche in maniera eminente quella tedesca. Il costituzionalismo è antifascista. Lo Stato sociale che di queste costituzioni è un effetto è antifascista, perché si indirizza alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale, ed alla protezione del più debole. Qui il diritto si umanizza, e si fa garanzia del più debole e fragile, non del più forte e robusto. Alla volontà di potenza nietzschiana si contrappone, da parte di Konrad Hesse, grande giurista tedesco, la Wille zur Verfassung, la “volontà di costituzione”. Stessa cosa dice Wilhelm Kägi, un docente svizzero, che contrappone il costituzionalismo al decisionismo schmittiano. Lo Stato non è precedente alla costituzione in questo modello, ma ne è il prodotto, e la costituzione permea tutto l’ordine giuridico, anche quello privato, anche le relazioni di mercato. Si impone la Drittwirkung, l’effetto orizzontale delle norme costituzionali e dei suoi diritti fondamentali. La dignità umana è intoccabile, inderogabile, “untastbar”, come recita l’articolo 1 del Grundgesetz, la Legge Fondamentale di Bonn. E ciò si fonda – va sottolineato – nel rigetto del fascismo.
III. Ma ora, dopo l’89 e il crollo dell’Unione Sovietica, è come se si sollevasse una pietra sotto la quale brulicavano vermi e scarafaggi. Vecchi rancori risorgono, vecchi e sopiti nazionalismi diventano nuovamente cruenti e chiassosi. L’internazionalismo, sia pure autoritario, di cui corpi politici come l’Unione Sovietica e la Jugoslavia erano bene o male, e più male che bene, portatore, crolla miseramente. Il cemento civilizzatore dell’unità, per quanto tutta ideologica, dei lavoratori viene deriso e rifiutato in nome prima del mercato capitalista ed accanto a questo della comunità di sangue, e di destino, dell’etnia, sì anche nuovamente della razza. E la storia viene raccontata ora in modo diverso.
In alcuni paesi dell’Europa orientale, per odio al Russo, si rivaluta l’occupazione del Tedesco e del Nazista nella Seconda guerra mondiale. Si dimenticano i massacri degli Ebrei, cui anche avevano partecipato i nazionalisti locali, Lettoni, Lituani, Estoni, soprattutto Ucraini, gli uomini di Stepan Bandera, capo antisemita e fascista che si ripropone ora come grande eroe nazionale. Le sue bandiere rossonere sventolano di nuovo a Kiev e ad Odessa, proprio lì dove quelle stesse bandiere si erano impugnate per i massacri d’Ebrei.
Babij Jar, l’olocausto ebreo di Kiev, su cui va letta la dolorosa testimonianza di Anatolij Kuznecov[3], viene di fatto cancellato dalla memoria collettiva. «Nudi, erano allineati in brevi file e portati in una fenditura scavata in fretta e furia nella scoscesa parete sabbiosa. Non si vedeva cosa ci fosse oltre, ma da lì arrivavano gli spari, e ne tornavano solo tedeschi e polizei, a prendere nuove file»[4]. Si dimentica l’oscena schiavitù imposta agli stessi ucraini dal nazismo: «Gli ucraini venivano portati a un mercato speciale, dove i contadini tedeschi, i Bauern, passavano lungo le file, sceglievano, guardavano i denti, tastavano i muscoli e compravano, pagando da cinque a venti marchi a persona»[5].
Tutto ciò, in odio al Russo e al comunista, si dimentica. E così è la stessa nostra stessa storia e identità morale, e politica, a venir riscritta, ed il genio maligno del fascismo, che il costituzionalismo democratico aveva inteso imprigionare, ricompare, fuggendo precipitosamente e allegramente dalla vecchia lampada di Aladino rappresentata dalla dottrina giuridica e costituzionale europea. Hostis ante
SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE
[1] M.E. Roca Barea, Imperiofobia y leyenda. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, Siruela, Madrid, 2016.
[2] Z. Brzeziński, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, Basic Books, New York, 1997, II ed. 2016, 73.
[3] A. Kuznecov, Babij Jar, trad. it. di E. Guercetti, Adelphi, Milano, 2019.
[4] Ivi, 107-108
[5] Ivi, 246.