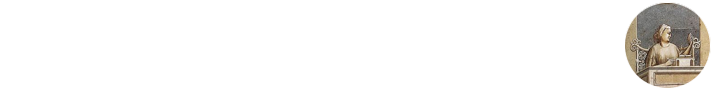EDITORIALE – Il lavoro “liquido”, l’algoritmo, e la società delle mascherine
DI MASSIMO LA TORRE
Siamo ancora dentro il tunnel della pandemia, anche se pare di intravvedere ora uno sprazzo di luce che ci segnala l’uscita. Le vaccinazioni proseguono, e le infezioni altalenanti risultano meno letali, almeno in questa nostra bene o male privilegiata parte del mondo occidentale. E tuttavia è difficile riuscire a pensare che tutto tornerà come prima, come prima che il COVID-19 facesse la sua tragica apparizione sulla scena delle nostre esistenze. Mi pare possa ora dirsi che il Novecento è finito proprio qui, nel 2020, con la pandemia, e non nel 1989, con la caduta del muro di Berlino. Invece di un “secolo breve” – come lo etichettava Eric Hobsbawm, lo storico britannico[1] – allora si dovrebbe piuttosto parlare del “secolo lungo”, un secolo che si prolunga oltre il Novecento[2].
La fine di un’epoca e l’arrivo di una nuova è segnalato da novità nella vita quotidiana, e da differenze di immagine e di condotta sociale. Il Novecento si caratterizza per esempio per l’imporsi dell’uniforme militare di campagna, verde in genere, funzionale, rispetto a quelle colorate, e sempre cerimoniali, dell’Ottocento. Accadde subito dopo l’agosto del 1914 allorché le truppe francesi dai pantaloni rossi sgargianti si rivelarono un bersaglio perfetto per le armi dei soldati tedeschi. Dal rosso si passò rapidamente all’uniforme grigio-azzurra del poilu, il soldato semplice francese che sarà macellato in massa sul fronte occidentale. E dopo la Grande Guerra le lunghe trecce delle donne si tagliarono e le acconciature si fecero più agili, capelli corti, e con la chioma si tagliò anche la gonna, e questa non strascicò più per terra. Gonne corte, ed anche giacche corte per gli uomini; niente più redingote che arrivava fin quasi al ginocchio. E poi l’imporsi almeno nelle città più importanti del traffico di automobili. Le carrozze pian piano sparivano dal paesaggio urbano. Le barbe e i favoriti venivano dismessi dai visi dei giovani europei ed americani. E così al walzer si contrapponevano altre danze e musiche, il jazz, il ritmo, il movimento sincopato. Tutto ciò sanciva una nuova modernità, un diverso stile, rispetto al romantico e serioso Ottocento. E dopo il secondo conflitto mondiale il rock’n roll è uno sviluppo della rivoluzione musicale introdotta dal jazz, una sua rielaborazione. L’arte e la musica si dànno come “avanguardia”, rottura della regola, e la ricerca del “nuovo” diventa quasi ossessiva in ogni forma artistica.
Il passaggio del capo del 1989 non comporta modifiche sostanziali a questo paesaggio culturale. Vi sono, certo, grandi capovolgimenti politici. Socialismo e Stato sociale sembrano ora non essere più supportati dallo spirito del tempo, ma la vita quotidiana, almeno nell’Europa occidentale, non subisce troppi soprassalti. Se non fosse per la presenza di migranti, di stranieri, degli “extracomunitari”, sempre crescente. Ma insomma c’era stata qualche anno prima la grande ondata migratoria dei contadini del Meridione italiano verso il più prospero Settentrione industriale. L’emigrazione è tutt’altro che un fatto nuovo. Dal secondo dopoguerra però si alimenta l’idea che col 2000, anzi forse già con gli anni Ottanta, si entrerà in una nuova società dai tratti avveniristici, forse inquietanti come nel 1984 di Orwell. Il nuovo millennio è la soglia per un nuovo mondo. E c’è la promessa delle macchine volanti, delle automobili che volano, com’è il futuro raffigurato per esempio in un film che nutre l’immaginario del nuovo millennio, Blade Runner: replicanti e macchine che volano. Ma la promessa delle automobili con le ali non è stata finora mantenuta.
Varcato il nuovo millennio il nostro paesaggio urbano rimane inalterato; così anche la nostra vita quotidiana. Se non fosse per computers e smartphones. Questi ultimi soprattutto, che ci accompagnano costantemente, e che sempre abbiamo in mano, e guardiamo, e digitiamo, fanno la differenza. Di maniera che, se arrivasse un Lillipuziano e dovesse rispondere alla domanda che cosa è quello strano oggetto su cui siamo sempre chini, e su di esso dovesse scrivere un rapporto al suo monarca, probabilmente direbbe che si tratta di un idolo, della immagine di un dio. Stessa risposta che si dette riguardo all’orologio da tasca di Gulliver. E sì perché quell’oggetto era sempre fissato, in adorazione sembrava all’osservatore lillipuziano, prima di compiere una qualche azione importante. E stessa cosa oggi accade a noi col telefonino, permanentemente tenuto in mano e compulsato.
Ma la grande novità oggi, quella ancora più evidente, è data dalla mascherina. Una foto delle nostre strade e della nostra vita adesso ci ridà indietro la presenza di visi celate da maschere, anzi mascherine. È la protezione contro il virus che ci è stata raccomandata e prescritta, e noi l’accogliamo di buon grado. È una prescrizione che seguiamo, più o meno volentieri. Non ci guardiamo più gli uni agli altri in faccia. La mascherina sul nostro volto ci fa grosso modo tutti uguali. Alla socialità si impone una ulteriore distanza, e questa ha ora un modo essenziale di “sciogliersi” per un verso (dandoci uno spazio senza mascherina) e di densificarsi per altro verso (aumentando e certificando la distanza), ed è la rete, la comunicazione mediante lo schermo, fornita da varie piattaforme informatiche, zoom, meet-google, ecc. Si lavora in tanti da casa, davanti al computer e ci si parla e ci si guarda dinanzi al telefonino. Interminabilmente rinchiusi dentro quello che una volta era il nostro spazio più privato e che ora è divenuto l’unica nostra efficiente sfera pubblica. Il privato si è fatto d’un colpo tutto pubblico. Ma non sembra possa dirsi che valga anche il contrario.
Lenin pare dicesse che il comunismo era equivalente ai soviet più l’elettrificazione del paese. Noi potremmo ora affermare che il futuro che è presente, il nuovo secolo, il ventunesimo, è la mascherina più il computer, o lo smartphone, una congiunzione di oggetti che fanno asettica la nostra vita di relazione, in cui siamo separati doppiamente, da uno schermo luminoso e da un cencio su bocca e naso. Ci si vede ma non ci si vede veramente, elettronicamente e igienicamente, secondo una cifra che pare annunciare l’avvento di un ordine “immunitario”, nel quale tra l’altro la mancanza di contatto è l’unico modo di salvarsi e di proteggersi. L’autonomia si trasforma in assoluta privatezza, ed anzi addirittura solitudine, confinamento, persino abbandono. In questa nuova congiuntura la condizione umana si altera in quella che la modernità ha portato al centro della sua esperienza: il lavoro.
In un libro debordante di intelligenza David Graeber[3] ci presenta il fenomeno dei bullshit jobs, i “lavori inutili”, “assurdi”, o “lavori spazzatura”, occupazioni di cui si fa fatica a cogliere il senso e l’utilità, come ormai proliferano nella nostra organizzazione dell’economia e della vita sociale. I bullshit jobs possono dividersi in almeno due categorie, lavori che vendono una merce o una prestazione di cui si sa l’inutilità o la ridondanza, o addirittura la nocività. E questi non sono una vera novità nel paesaggio capitalistico. Vi sono poi i lavori che mancano di senso proprio, collocandosi nella serie sempre più lunga e farraginosa e “insensibile” e immateriale dei passaggi burocratici che si sono ora moltiplicati nell’organizzazione dell’azienda e delle amministrazioni, già che tutto, dal settore privato a quello pubblico, è ora concepito come gestione razionale di informazioni, secondo logiche di direzione manageriale e in vista di risultati numericamente catalogabili. Il bullshit job è per esempio tipico di quelle agenzie che affibbiano bollini di “qualità” a tutto ciò che si muove nella società e che in questa intraprende azioni, e che ora “monitorano” la produzione di documenti e il passaggio di questi e la loro elaborazione all’interno di una struttura di lavoro, il cui risultato non viene però valutato secondo le conseguenze pratiche di questa, bensì a partire solo dalla documentazione che attesta il lavoro e il suo corretto formato. Il lavoro “immateriale”, il cui prodotto non né un artefatto concreto né un vero e proprio “servizio”, dispiegandosi in gran parte nelle nuvole del mondo digitale, ed incrociandosi con la ricaduta burocratica di questo mondo algoritmizzato, dunque inflessibilmente regolato, finisce per farsi insensato.
Si tratta invero dell’introduzione di una nuova specifica forma di governabilità, o di governance, parola ora tanto alla moda che sostituisce l’obsoleto termine di “governo” o quello anch’esso diventato antico di “amministrazione”, o quell’altro, per certi versi dal suono più umano, di “gestione”. Per ottenere un qualsiasi risultato bisogna riempire di formulari, mettere una x su caselle varie, attaccare degli allegati, apporre firme. E del pari per essere valutati si passa nuovamente da questa trafila. E con l’affermarsi dell’informatica, o di pari passo con lo sviluppo di questa, una tale minuta burocratizzazione della vita si diffonde per ogni dove e si fa più rigida, meno interpellabile, inflessibile. Si passa ora dall’algoritmo. Bisogna inserire un identity name, inserire ancora una password, si riceve sul telefonino un codice, va inserito il codice, e poi ancora altre informazioni riservate, la propria data di nascita, il codice fiscale, poi è necessario l’IBAN, e se ci si sbaglia una volta tutto ricomincia daccapo, e ci si sbaglia il PIN o il codice tutto si blocca. Salta e bisognerà passare da un centralino di telefono, che è un computer e che ti risponde mediante una voce metallica dettata da un algoritmo. E questo per quasi ogni contatto con la banca, l’agenzia delle entrate, per una borsa di studio, per comprare una cosina per internet. O per avere un biglietto aereo, uno ferroviario, per fissare una visita medica. E poi per ottenere un riconoscimento del lavoro fatto e del proprio merito, oppure per insegnare un corso, per stabilire un orario di lezioni, per gestire una sessione di esami laurea, per dare voti agli studenti. Per non parlare poi di un concorso.
Il bullshit job è quello che si produce e si universalizza negli interstizi di questo sistema burocratico ed anonimo, rispetto al quale la “gabbia d’acciaio”, preannunciata da Max Weber agli inizi del secolo scorso, sembra cosa da ragazzini. In particolare, questo, il bullshit job, è una specie di meta-lavoro, si presenta spesso nella forma di un “servizio”, non di una forma di produzione di qualche bene. Ma si tratta di un servizio mediato, indiretto, la cui utilità risulta distante dall’esperienza dell’operatore che la compie la prestazione. È una prestazione che serve altre prestazioni, in quanto le riorganizza, le rivaluta, le rappresenta e le calcola, e le proietta in qualche documento più o meno ufficiale. Alla fine, allora, il meta-lavoro diventa più importante del lavoro. Valutare e organizzare l’insegnamento diventa più importante dell’insegnamento stesso. Quest’ultimo quasi scompare dal panorama, e invece si ha a che fare con l’agenzia e gli agenti ella valutazione, i consulenti, i vari passacarte, i centralinisti, i gestori della rete, i programmatori dell’algoritmo. Lo stesso vale per altre aree di lavoro pubblico e privato, per la salute per esempio, dove la prestazione sanitaria effettiva è accompagnata da una massa sempre più pesante di meta-prestazioni di controllo e gestione e revisione burocratica. Ovviamente sempre in nome della efficienza della prestazione, la quale però è calcolata secondo criteri meramente aziendali. Ma anche la ragioneria, disciplina, se si vuole, solida, antica, cede al sopravvento del marketing o del planning, o di tante altre “operazioni” ricoperte di magnifici e rimasticati vocaboli inglesi dietro i quali si cela però nuovamente il bullshit job.
Marx aveva anticipato qualcosa di simile allorché parla della merce come feticcio. La “merce”, il prodotto della forma capitalistica di produzione, una volta entrata in circolo nel mercato altamente concorrenziale, assume un valore proprio al di là del suo valore d’uso. Il valore d’uso, mercificato, e poi feticizzato, si impone innanzitutto sul valore-lavoro. Ciò tra l’altro, questa feticizzazione che passa nelle relazioni mercato, dove il prodotto assurge alla dignità incontestabile di feticcio, si accompagna ad un elevato e radicale processo di burocratizzazione. A riprova, se mai ce ne fosse bisogno, e confermando le tesi di Karl Polanyi, che il mercato non è un fungo che si produce spontaneamente nell’evoluzione dell’economia, bensì è il risultato di un processo di disciplinamento del mondo sociale. La proprietà e il mercato delle terre, e il lavoro salariato vendibile come merce, si dà tra l’altro in Inghilterra, perché ci sono le enclosures, le espropriazioni, o diremmo oggi le “privatizzazioni” dei commons, le terre un tempo di proprietà comune, dove i contadini potevano liberamente e collettivamente coltivare e portare le bestie a pascolare. Il Circumlocution Office di cui parla Dickens nel romanzo Little Dorrit, un enorme ufficio della burocrazia britannica del primo Ottocento, è un anfiteatro labirintico in cui si accumulano le carte e queste passano da una stanza all’altra, ma nulla avviene veramente nel mondo esterno, se non ostacoli e divieti. Ed è il tempo glorioso del capitalismo manchesteriano, del libero mercato nascente e selvaggio, della cosiddetta “accumulazione primitiva” del capitale.
Il mercato altamente concorrenziale e le privatizzazioni mai finite ed instancabilmente perseguite nell’Unione Europea hanno come contraltare una massa di decisioni delle corti di Lussemburgo e una miriade di direttive ed altre prescrizioni, regolamenti, ecc., della Commissione europea. Non c’è mercato libero senza una potente burocrazia – questo è l’insegnamento di Karl Polanyi[4] ripreso a suo modo dall’ordoliberalismo, il quale ultimo punta tutto su questa santa alleanza di due fenomeni che sembrerebbero a prima vista tra loro in conflitto. E la più o meno gentile supervisione legalistica del mercato ha un effetto rilevante, ed a suo modo rivoluzionario, sulla natura del lavoro che ora ci tocca. Trionfa il meta-lavoro, che è quello che si fa per soddisfare la governabilità della supervisione burocratica. E questo è un lavoro “liquido”, poiché ad esso non corrisponde infine un prodotto capace d’avere valore d’uso. Si passerà più tempo a programmare e disegnare e normare e riempire dei registri d’una qualsiasi attività che a portare a termine e curarsi dell’attività medesima. Allora, come dice David Graeber, «one ends up spending so much more time picking, assessing, monitoring, and arguing about what one does than one spends actually doing it»[5].
La pandemia radicalizza tutto ciò. Il lavoro a distanza, mediante la intermediazione dello schermo e del computer, si fa ancora più lontano dalla “realtà effettuale”. Si dematerializza in senso quasi assoluto. La sua natura di meta-lavoro si dà già nella sua mancanza di riferimento materiale ad una socialità condivisa con gli altri su un medesimo spazio fisico. Il valore del lavoro diviene così ancora più astratto ed incerto, ed è consegnato esclusivamente alla valutazione della eventuale operazione di auditing, o all’impatto che esso ha su un ulteriore passaggio astratto, nel vedersi riflesso ed inserito in un tabulato o in un a tavola numerica di Excel.
Com’è noto, Hannah Arendt considera il lavoro all’interno di una più generale visione di ciò che è l’azione umana. Nel suo importante saggio On Human Condition[6] la studiosa tedesca ci presenta una tripartizione, ormai famosa, dell’azione umana, della vita activa dell’uomo comune impegnato nel mondo, contrapposta tradizionalmente alla vita contemplativa del sapiente astratto dal mondo. La vita activa si darebbe essenzialmente nella forma del lavoro, labour, dell’opera, work, e dell’azione, action. Lavoro e opera sarebbero retti da una razionalità strumentale. La condotta lì realizzata avrebbe un fine esterno alla condotta medesima, la quale risulterebbe essere così solo un mezzo per conseguire un risultato concreto. Nel “lavoro” il risultato è il mantenersi in vita; mentre nell’ “opera” si tratterebbe di uno specifico oggetto. L’“azione” in senso stretto, l’action, l’azione, sarebbe invece retta da una razionalità non-strumentale, giacché qui il fine dell’azione in senso lato sarebbe il compimento della stessa azione. In un certo senso, l’“azione” della Arendt sarebbe l’unico tipo di condotta umana collettiva a soddisfare l’esigenza della seconda formulazione dell’imperativo categorico di Kant, per cui l’essere umano va sempre trattato come fine e mai solo come mezzo.
Ora, il “lavoro” sarebbe l’azione che consiste nella messa a punto della riproduzione del ciclo vitale degli esseri umani, il lavoro agricolo come esempio preminente. L’opera sarebbe la produzione di un artefatto, che è anche il risultato di un “disegno”, di una forma ideata, per esempio il piano di una casa, o il design di un oggetto. L’azione in senso stretto, l’“azione”, sarebbe per esempio ed essenzialmente la politica, od anche, se si vuole, una rappresentazione teatrale, o l’esecuzione di un brano musicale da parte di un’orchestra. Il diritto in questa tripartizione si collocherebbe nella dimensione dell’“azione”; è infatti eminentemente una pratica, non un oggetto.
Il lavoro salariato si darebbe allora qui o nella forma del lavoro in senso stretto, “labour”, o in quello dell’opera, del “work”. Si tratterebbe di un’azione penosa, faticosa, che avrebbe come fine in genere un certo oggetto o una cosa. Si tratterebbe di un travaglio, di una esperienza dolorosa, che si pensa per certi versi prossima al travaglio di un parto, il quale pure ha poi come esito un “prodotto”, l’espulsione – se si vuole – del feto che è ora qui il nuovo nato. Il lavoro sembra così avere come modello il parto, o una certa idea di questo. Ce lo dice ancora una volta David Graeber: «The word production comes from a Latin verb meaning “to push out”: so the image seems to be that just as women push out babies fully formed, factories are a kind of male imitation of childbirth»[7].
In questa concezione del lavoro, comunque contrapposto alla “vita activa”, che si sostanzia solo nell’azione, non rientra una parte essenziale di ciò che è pur tuttavia attività lavorativa, la cura, il servizio prestato agli altri. Così che alla concezione del lavoro, work essenzialmente, ritagliata sul parto sfugge paradossalmente ciò che finora è stato considerato il lavoro tipico della donna, il prendersi cura della casa, del figlio, del vecchio, del marito. Il lavoro come espulsione di oggetti si presta alla quantificazione. Non calcolabile numericamente è invece la cura, che più che alla quantità di un prodotto, si commisura alla qualità del servizio fornito. Invero, si potrebbe riconcettualizzare l’insieme dell’esperienza del lavoro come esperienza della cura. L’operaio in fabbrica allora sarebbe un soggetto che si prende cura della macchina, così come il contadino servirebbe e curerebbe la terra. Ma questa riconcettualizzazione urta contro un’attribuzione di valori che si vuole monetizzabile, ovvero quantificabile numericamente, per “prodotti”, “pezzi”, e “prezzi”, unità di conto e di valore messe a disposizione di colui che le vuole registrare, contabilizzare, e acquisire e consumare. Si ricordi che l’unità di riferimento (e la giustificazione finale) del mercato è per l’appunto il “prezzo”, che si sostituisce al valore d’uso ed a quello lavoro, mediante un più o meno misterioso rinvio alla soddisfazione di una preferenza egocentrica. E così, significativamente, in sintonia con questa vera e propria Weltanschauung, l’agenzia nazionale che valuta la ricerca dell’università in Italia, elabora la cosiddetta VQR, la Valutazione della Qualità della Ricerca del singolo docente, a partire di una serie di “prodotti” di questo. È come allora se ad ogni docente venisse attaccato un “prezzo”.
Nondimeno, nonostante l’astrattezza del “prezzo”, il labour e il work operano nel mondo empirico; l’operaio e il contadino toccano e plasmano le cose. Si sporcano, si bagnano di sudore, si macchiano di liquami e liquidi di vario tipo, si impregnano di vari odori. Talvolta dunque puzzano, e le loro mani finiscono per farsi ruvide, callose; il loro visi bruciati dal sole, o dall’altoforno. Questo qualche volta pure li uccide. Ma la società industriale matura, dove alla fabbrica si sovrappone la borsa, ed ancor più quella post-industriale, rifuggono dalla fisicità. Il valore economico non è fornito dal lavoro, come rozzamente credevano Lincoln e Marx, e forse più Lincoln che Marx, e ancora in parte può leggersi nell’articolo 1 della Costituzione repubblicana italiana. Il valore nello scambio del mercato, che sopravviene al fatto della produzione, è reso astratto, e lo si lega e misura alle preferenze marginali che si dànno nell’incontro di domanda ed offerta. La dottrina “marginalista” più che scienza invero è ideologia, espellendo il lavoratore dallo spazio economico, e facendo come figura fondativa e giustificatrice di questo spazio l’acquirente, il consumatore. Valore economico di una cosa non è più l’uso, come sembrava essere nella società contadina, ma nemmeno il lavoro, come si illude sia la società operaia. È il valore di un consumatore dentro un gioco di mercato, e si sostanzia nella scommessa che un certo profitto potrà farsi nel futuro. Il lavoro scompare dalla determinazione del valore, così anche la materialità della cosa, che si fa merce-feticcio. Sopravvenienza superiore è poi il danaro a sua volta “lavorato”, trasformato in una merce ancora più astratta e distante. Ciò mediante la triturazione, la “macellazione”, e dei debiti e delle ipoteche e la loro ricomposizione in titoli di borsa, in una specie di salsicce finanziarie, “derivati”, il cui valore è tutto ipotetico e fondato in buona sostanza su una scommessa, una fantasia ed un’immagine di ricchezza.
In un’altra sua ricerca[8] David Graeber definisce il “valore”, «the false coin of our dreams», la moneta falsa dei nostri stessi sogni. Il valore, e il valore economico non pare fare eccezione, è dunque la proiezione di un nostro “fantasma”, una cosa desiderata, un “sogno” per l’appunto, nella società neoliberale d’oggi una certa idea di “ricchezza” che si fa permanentemente (ora soprattutto con lo schermo del computer o dello smartphone) baluginare davanti ai nostri occhi. Il lavoro è retrocesso come produttore di lavoro, rispetto invece alla capacità d’essere una merce, un oggetto delle nostre brame (l’incremento di soddisfazioni dei “marginalisti”), brame lanciate nel tavolo di gioco d’una arrischiata partita di poker dove le fiches sono in buona sostanza le ore della nostra esistenza.
Tutto ciò si sospinge verso una meta-realtà che infine trova nello “spettacolo” il suo suggello. Si ricordi a questo proposito l’incipit de La Sociétè du spectacle (Paris 1967) di Guy Debord: «Toute la vie des sociétés dans lesquelles régnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles». E lo spettacolo “precipita” e si condensa nello schermo e nella resa elettronica dei rapporti sociali. In tale contesto il lavoro diventa “liquido”, perde la sua solidità, l’aggancio alla materialità del mondo che ci circonda ed alla socialità che lo tiene insieme, e si scioglie al fuoco del desiderio del consumatore e delle leggi del mercato. Questo quadro si radicalizza nella situazione presente, nella quale l’astrattezza del valore del lavoro e del suo prodotto, trova l’ulteriore giustificazione dello schermo e della mascherina. L’anonimità del lavoro, la sua “digitalità”, ne esalta la liquidità, l’immaterialità e l’asocialità, ma anche ce lo rende opaco ad una operazione di empatia. Mentre ci si può ancora identificare col contadino o con l’operaio della fabbrica, pur non essendolo noi, assai più difficile risulta collegarsi simpaticamente ad un soggetto che ci si presenta con la voce metallica di un centralino telefonico, con una lettera accompagnata a un formulario da riempire, o vestito di uno scafandro e con mascherina che non ci fa vedere il viso e la fatica. Si fa fatica a riconoscere umanità ad una firma digitale.
Tutto è schermato. Di maniera che l’universo pandemico, che questo schermo accentua e rende più rigido, ed onnipresente, invece di indurci all’empatia dell’altro, del lavoro, e della fatica, alla fratellanza verso il prossimo, sembra poter avere l’effetto contrario, distanziandoci ulteriormente dall’umanità tutt’altro che virtuale di chi ci aiuta e lavora per noi. Lo schermo digitale pare non poter darci contezza e riflettere il valore della cura. E la solidarietà, se filtrata dall’algoritmo, si fa mero adempimento burocratico.
[1] E. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, traduzione di B. Lotti, Collana Storica, Rizzoli, Milano, 1995 (ed. orig: The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991, Michael Joseph ed., London, 1994).
[2] Cfr. anche G. Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Time, Verso Books, London, 1994.
[3] D. Graeber, Bullshit Jobs, Simon and Schuster, New York- London, 2018.
[4] K. Polanyi, The Great Transformation, Farrar & Rinehart, New York, 1944.
[5] D. Graeber, Bullshit Jobs, cit., p. 183.
[6] H. Arendt, On Human Condition, University of Chicago Press, Chicago, 1958.
[7] D. Graeber, Anarchy-In a Manner of Speaking: Conversations with Mehdi Belhaj Kacem and Assia Turquier-Zauberman, Diaphanes Anarchies, Zurich, 2020, p. 19.
[8] D. Graeber, Toward an Anthropological Theory of Value. The false coin of our own dreams, Palgrave, New York, 2002.