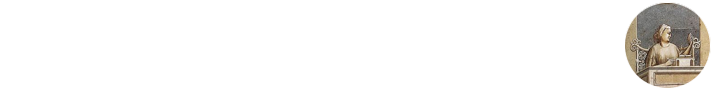EDITORIALE – La fine della fine della storia
DI MASSIMO LA TORRE
I.
Vale ancora una volta tornare al novembre 1989, il giorno 9, un giovedì. Una massa di cittadini della parte orientale di Berlino si raccoglie dinanzi al Checkpoint Charlie, in Friedrichsstrasse, che separa la parte comunista dal settore occidentale. Vogliono finalmente avere la libertà di vedere la città dall’altro lato del muro che era stata loro vietata dall’agosto 1961 con la costruzione del muro. La Germania Orientale cede alla pressione cittadina ed apre i cancelli[1]. La massa così attraversa il confine finora proibito e si riversa in Berlino Ovest. Il muro è caduto, e da quella sera inizia un processo che conduce rapidamente alla caduta del blocco comunista. La Germania si riunifica, nonostante qualche sospetto e resistenza da parte di Stati europei come il Regno Unito e l’Italia. Ma il processo è inarrestabile. Il gigante sovietico si rivela presto avere dei piedi d’argilla. E due anni dopo, nel dicembre 1991 al Cremlino si ammaina la bandiera rossa. Questi avvenimenti furono vissuti da protagonisti ed osservatori come miracolosi, e soprattutto come l’inizio di una nuova era per le relazioni internazionali, e soprattutto per l’Europa.
Le reazioni a tali avvenimenti furono di diverso tenore, ma tutte in genere ottimistiche, soprattutto dalla parte occidentale. Si parlò inopinatamente di “fine della storia”, come se ormai solo mercato ed economia dovessero diventare i motori delle società umane, riproducendosi perpetuamente uguali a se stessi. Ciò faceva eco alla tesi di Margaret Thatcher, protagonista degli anni Ottanta della controrivoluzione neoliberale, che si diceva avesse condotto alla caduta del comunismo. “There is no alternative” – ripeteva la premier britannica, riferendosi ad una possibile alternativa al capitalismo, aggiungendo che non c’è nessuna cosa che possa chiamarsi “società”. Ci sarebbero solo individui, consumatori e attori economici all’interno di un regime di mercato altamente concorrenziale. L’unico ente collettivo, ed olistico, se c’è, sarebbe il mercato – tesi tra l’altro condivisa da Friedrich von Hayek, in quegli anni in vetta alle classifiche dei best sellers economici. Il mercato si dà per natura, ente catallattico, a differenza dello Stato, entità tutta artificiale. Hayek è economista gettonatissimo, dopo i decenni gloriosi, i trenta anni gloriosi, di imperante keynesismo e di quella “grande trasformazione” di cui aveva scritto Karl Polanyi[2], vale a dire, il grande imbrigliamento del capitalismo, finalmente “bound”, legato, “embedded”, incastrato nelle strutture delle relazioni sociali di ridistribuzione della ricchezza, strutture statali veicolate dalla politica dei partiti e dall’azione collettiva dei sindacati. Ma ora tutto questo, definito “storia”, si dice essere finito. È la nota dottrina di Francis Fukuyama[3], che utilizza Hegel[4] ad usum delphini, dove il “delfino” non è che il capitalismo mondiale delle multinazionali, in buona sostanza rappresentato dalla borsa di Wall Street.
Una volta caduta l’Unione Sovietica si apriva il campo alla ridefinizione dell’ordine mondiale delle relazioni internazionali, e soprattutto urgeva la rideterminazione dell’ordine europeo. Questo era stato fissato alla Conferenza di Yalta nel 1945, diviso in due grandi campi, due sfere di influenza, quella occidentale sotto la protezione economica e militare degli Stati Uniti, e un’altra orientale sotto la tutela vigile e occhiuta dell’Unione Sovietica. Frontiere di molti paesi erano state mosse, spostate, ridisegnate. L’Italia, paese vinto in guerra, aveva dovuto cedere l’Istria alla Jugoslavia, e Trieste era divisa in due zone, la A e la B, rispettivamente sotto il controllo degli alleati angloamericani e degli Jugoslavi di Tito. Una piccola striscia al Fréjus era stata ceduta alla Francia. La Germania è ritagliata in maniera notevole, perdendo un terzo del suo territorio. Città storicamente tedesche come Stettino e Breslau divenivano centri polacchi. Königsberg, la città di Kant, si trasforma in Kaliningrad ed è data all’Unione Sovietica. Le frontiere della Polonia si muovevano verso Occidente, prendendosi parti della Germania, e cedendo ad Est territori all’Ucraina. Lwóv, in polacco, L’viv in ucraino, Lemberg in tedesco, o Leopoli in italiano[5], veniva aggregata in una nuova grande Ucraina, repubblica dell’URSS. I paesi baltici tornavano ad essere provincie del grande Impero sovietico. La Finlandia cedeva anch’essa dei territori alla Russia. Dunque, un terremoto, che sospingeva milioni di esseri umani a riparare ad Ovest o anche a Est, come fu il caso dei Polacchi che in maggioranza costituivano la popolazione dei centri ora annessi all’Ucraina. Ma una volta più o meno assestatosi questo movimento tellurico, coll’enorme dolore umano che provocava, l’Europa si ritrovava divisa in due grandi spezzoni, secondo una linea divisoria che partiva da Stettino ed arrivava a Trieste.
È in questo quadro che si dà la novità della Comunità economica europea. Secondo Joseph Weiler, tre sono i principali motivi che animano il processo di integrazione europea[6]. Innanzitutto, vi è il desiderio di pace, di far dell’Europa un’area non più permanentemente minacciata dalla guerra, poi la voglia di benessere, l’uscita dalla miseria e dalla scarsità inaugurata con la Prima guerra mondiale, infine il sospetto verso il nazionalismo e le distinzioni e le discriminazioni che questo comporta. Si può essere d’accordo con lo studioso angloamericano. Ma quei tre motivi vanno ulteriormente analizzati e specificati. La motivazione della pace si articola in maniera abbastanza complessa. A prima vista si tratta di ricomporre il rapporto tra Francia e Germania, che, guastato o distrutto con la guerra franco-prussiana del 1870 e l’annessione tedesca dell’Alsazia e di parte della Lorena, aveva avvelenato e sconvolto il sistema di relazioni tra Stati stabilito col Congresso di Vienna del 1814-1815. Nel sistema ideato e realizzato da Metternich, il politico che di quel congresso è massimamente l’artefice, la Germania, non c’è. Il mondo tedesco è piuttosto assemblato sotto l’egida dell’Impero asburgico. È Vienna, non Berlino, la grande capitale tedesca per buona parte dell’Ottocento. L’unità della Germania, Kleindeutschland col baricentro nella Prussia militarista, altera questo sistema. La Francia e l’Austria (anch’essa sconfitta da Bismark sul campo di battaglia) finiscono d’essere le potenze preponderanti dell’Europa continentale. Ma anche la Russia viene a vedersi modificata la sua posizione. Fino al 1870 è la Russia che fa da garante al sistema neo-westfaliano del Congresso di Vienna. È la Russia che ha occupato Parigi dopo la sconfitta di napoleone a Waterloo nel 1815. È ancora la Russia, che per conto dell’Impero asburgico soffoca la rivoluzione ungherese del 1848. La Russia poi dà luce verde a Bismarck nella sua guerra contro la Francia, mantenendosi neutrale sul fianco orientale dello Stato germanico. Ma una volta creatasi la Germania come Stato unitario, la Russia si ritrova alle frontiere una creatura militare ed economica formidabile, di grande forza e capacità di manovra. Si sfilaccia così prima, e poi si rompe, il legame storico tra Germania (Prussia) e Russia che era stato determinante per la sconfitta dei disegni imperiali di Napoleone. D’altra parte, il nazionalismo insorgente nei Balcani, afferrandosi ad una ideologia panslavista, chiama la Russia come sua garante. Ma il nazionalismo slavo è il primo nemico dell’Impero Austriaco. Austria e Russia entrano così in rotta di collisione, in un percorso che porterà al primo agosto 1914 ed alla Grande Guerra[7]. Con questa l’Europa è come se si suicidasse, distruggendo la sua centralità nel sistema delle relazioni internazionali. «Con la guerra mondiale» – scrive Otto Hintze nel 1925 – «il concetto politico di “Europa” […] è stato in buona sostanza dismesso»[8]. Nella Seconda guerra mondiale la tragedia si ripete ed assume proporzioni apocalittiche.
Nel secondo dopoguerra, dunque, ciò cui si vuole rimediare è la feroce e storica inimicizia tra Francia e Germania, esiziale per la pace e il “concetto politico” dell’Europa. La Germania è stata fortemente ridimensionata territorialmente, ed è ora divisa in due zone, una occidentale, sotto protezione americana, l’altra orientale, sotto egemonia sovietica. Rimane comunque una possibile potenza economica. Si tratta allora di integrarla in uno schema permanente di cooperazione con la Francia, nel quale eventualmente entrino a far parte altri Stati dell’area europea occidentale. Ma come fare? Una federazione politica è un salto inaccettabile per le opinioni pubbliche dei due paesi ancora tra loro ostili. L’idea allora è quella di una struttura che crei una solidarietà funzionale che possa poi produrre maggiori interdipendenze le quali infine eventualmente sfoceranno in qualcosa di più istituzionalmente denso, possibilmente in una vera e propria unione politica. Questo progetto è in già per certi versi in nuce nel Piano Marshall che si concretizza nel Trattato di Parigi del 1949 che istituisce la OECE. Ma soprattutto trova una prima e vera realizzazione con la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio che mette insieme produzione e distribuzione di risorse industriali fondamentali, sottraendo alla Germania la gestione del proprio carbone e acciaio, due risorse sulle quali fino ad allora si è fondata la possibilità della guerra. Il secondo passaggio di questo disegno funzionalista si dà nel Trattato di Roma del 1957, che istituisce il Mercato Comune e la CEE. Tutti questi passaggi sono incoraggiati e supportati dagli Stati Uniti, che vedono con grande favore un’organizzazione sovranazionale regionale degli Stati europei occidentali[9].
Ora, che Tedeschi e Francesi si incontrino, e mettano in comune risorse e decisioni, è un momento epocale di pacificazione del continente. Ciò però è anche in gran parte consentito dalla nuova situazione geopolitica e dalle sue dinamiche. La comunità europea è anche un prodotto proprio della guerra fredda. Al blocco “socialista” si vuole contrapporre un blocco di capitalismo sociale, vagamente socialdemocratico, che sia capace di dimostrare che è possibile coniugare mercato, proprietà privata, impresa con benessere diffuso e diritti sociali. Si dà allora come alternativa al modello economico fortemente centralizzato rappresentato dall’Unione Sovietica. Ma vi è una ulteriore ragione che veicola nella progettualità dell’integrazione europea. Ed è quella di vincolare dall’esterno un eventuale maggioranza comunista nei paesi dell’Europa occidentale. Il Partito comunista italiano e quello francese sono organizzazioni di massa con grande seguito e capacità di mobilitazione. Seppure entrambi estromessi dal potere a partire dal 1947 non è affatto escluso che possano riconquistare posti di governo. I partiti socialisti, d’altra parte, soprattutto in Italia e in Francia, sono assai vicini, almeno in politica economica, ai cugini comunisti. Lo Stato sociale comunque è un modello ampiamente condiviso anche negli ambienti democristiani. E il Mercato Comune serve non solo come “vincolo esterno”, ma anche come “facilitatore esterno”, ciò almeno nella sua fase iniziale, allorché il mercato comune è inteso essenzialmente come unione doganale, e non come mercato deregolato, e l’unione doganale realizza una pratica protezionista, fondamentalmente diretta a facilitare le esportazioni intrasistemiche ed a ridurre quelle extrasistemiche, in particolare quelle degli Stati Uniti. In questo senso si può anche parlare di un “salvataggio europeo” dello Stato nazionale[10].
In Europa il capitalismo è dunque imbrigliato ed in pericolo di subire ulteriori limitazioni e sorpassi. Per alcuni Stati europei si parla di “economia mista”, cioè per metà in mano privata ma per l’altra metà in mano pubblica. Ora, spostare ad un livello sovranazionale il baricentro della politica economica, almeno in alcuni settori chiave come quelli della circolazione dei beni e della concorrenza, fa sì che i partiti e i sindacati nazionali possano influire meno su quelle politiche. La “mano pubblica” si rende così meno pesante. La strategia è ben delineata in un noto articolo di Friedrich von Hayek scritto durante la guerra, che si dichiara favorevole a forme di federalismo sovranazionale proprio per depoliticizzare la politica economica degli Stati, sottraendola al conflitto sociale necessariamente incistato nello Stato nazionale[11]. C’è poi l’ordoliberalismo, scuola economica e giuridica che teorizza un mercato concorrenziale come costituzione materiale ed un diritto a questa collegata, tale da cortocircuitare la sovranità politica. Dunque, le origini della comunità europea risultano essere meno nobili di quanto una narrativa tradizionale ha voluto presentarci. Walter Hallstein, il primo Presidente della Commissione Europa, è molto vicino agli ambienti ordoliberali e ne condivide l’orientamento ideologico. Il primo grande Trattato di diritto comunitario europeo, un testo voluminoso di Hans Peter Ipsen[12], indica come figura soggettiva centrale della costruzione sovranazionale europea il Marktbürger, il “cittadino del mercato”, che ad Aristotele invero parrebbe non più che un ossimoro[13].
II.
Ora, allorché nel 1989 viene a cadere il “nemico” cui si doveva dimostrare la compatibilità del capitalismo con una qualche misura di giustizia sociale, quest’esigenza moderatrice cade rovinosamente e si afferma un’altra idea. Ha vinto il capitalismo ed il campo occidentale, e la moderazione tanto geopolitica che economica può darsi per obsoleta. Invece della riconciliazione e della integrazione, si sceglie la narrativa della vittoria, e un’operazione d’annessione. Ciò che accade in Germania è assai indicativo. Il Grundgesetz già nella su denominazione, “legge fondamentale” non “costituzione”, si proietta come carta provvisoria, e prevede che una volta riunificato il paese si dia un nuovo processo costituente, il quale sfoci in una vera e propria costituzione tedesca, Verfassung, e così lo indica il suo ultimo articolo. Ma quello che ora si fa rispetto alla Germania orientale, la DDR, ex-comunista, è semplicemente annetterla e smontarne il sistema industriale, provvedendo ad un colossale processo di privatizzazione e desocializzazione. Sarà questo il blueprintper ciò che si preannuncia negli altri Paesi dell’Europa orientale.
Sparito il Patto di Varsavia, l’alleanza militare di stampo sovietico, la NATO non solo si mantiene intatta, ma comincia ad espandersi a macchia d’olio sul territorio europeo verso Oriente. Ora, la NATO è un’alleanza militare, ma di un tipo speciale, nella quale la forza di uno degli Stati membri sorpassa quella di tutti gli altri anche se collettivamente considerati[14]. Lo stesso valeva per il Patto di Varsavia.
Invece di mantenere i pezzi di federalismo presenti nell’esperienza comunista, questi vengono smantellati, creando una “macedonia” di staterelli al confine orientale della Germania. Si dissolve la Cecoslovacchia, che pure aveva una storia nobile di unico paese democratico dell’Europa orientale tra le due guerre mondiali. E si accelera l’implosione della Jugoslavia. Qui l’Europa occidentale gioca una delle sue partite più irresponsabili. Il paese balcanico è spinto a spezzarsi in pezzetti nazionali animati di spirito autoritario e etnicista, se non proprio razzista. Regno Unito, Francia, Germania, Italia, è come se giocassero a risiko, e si riproducono i vecchi fronti della Prima Guerra Mondiale. La Germania ovviamente è con la Croazia, Inghilterra e Francia con la Serbia. Come nel 1914. Il risultato è catastrofico, e infine c’è l’olocausto di Szebrenica, tra l’altro coadiuvato da un gruppo sparuto di tremanti e imbelli soldati olandesi dell’ONU. Come atto finale, nel 1999, c’è l’attacco contro la Serbia da parte della NATO, il bombardamento di Belgrado, un intervento “umanitario” mai autorizzato dalle Nazioni Unite. Ma nell’agosto del 1990, a meno di un anno dalla caduta del muro, gli Stati Uniti attaccando l’Iraq e Saddam, con la prima guerra del golfo avevano voluto mostrare chi fosse il nuovo padrone del mondo.
L’Occidente e con questo l’Unione Europea, che si forma proprio in quegli anni, nel 1992, col Trattato di Maastricht, invece di pensare a costruire la “casa comune” europea, un’espressione ed un desiderio sincero di Gorbacëv, il leader dell’URSS ancora nel 1990, si lanciano in un progetto di radicale allargamento dei confini, e di deregolamentazione dello Stato sociale. Neoliberalismo e sovranazionalismo, o più crudamente imperialismo, vanno così di pari passo[15]. È quella che Bruce Ackermann chiama, in un libro rigonfio d’ottimismo, la “rivoluzione liberale”[16]. La finalitédell’integrazione europea rimane così strutturalmente indeterminata ed è messianicamente sempre spostata in avanti[17]. Vi è una permanente ambiguità dei confini territoriali dell’Unione Europea, che crea instabilità e insicurezza ed alimenta il nazionalismo riemergente da un passato tutt’altro che nobile[18]. Anche sull’assetto istituzionale e politico-economico dell’Unione non c’è chiarezza. Non importa il fine ma solo il movimento – potrebbe essere allora il motto di questa Unione Europea che fa propria la parola d’ordine del vecchio revisionismo socialdemocratico: «Das Endziel ist nichts, die Bewegung ist mir alles» – come si dice nel capitolo conclusivo del libro programmatico di Eduard Bernstein, I presupposti del socialismo[19].
Dall’altro lato, nei Paesi dell’antico blocco sovietico, si soffre la “great transformation” all’incontrario. Viene reintrodotta a tappe forzate la proprietà privata, e con questa un mercato fondamentalmente senza controlli, il tutto accompagnato da una forte ideologia nazionalista. Ciò è anche opera dei Chicago Boys, seguaci di Milton Friedman, che a frotte si riversano in questi paesi come consiglieri ed operatori del cambiamento e della “rivoluzione di velluto”. L’impatto sociale è tremendo, la disuguaglianza si moltiplica, senza che immediatamente arrivi il benessere. Alla miseria supplisce la narrativa, l’entusiasmo dii una libertà nuovamente ritrovata, la felicità di poter entrare in un MacDonald e sentirsi come a New York, la televisione dei canali privati rigurgitante di pubblicità e di ballerine. Nella Piazza Rossa, accanto alla mummia di Lenin, una fila immensa di ex-compagni, i tavaritsch di un tempo, aspetta pazientemente di entrare a gustare un Mac Burger, di bere una Coca Cola, e così assaporare il gusto dell’agognato Occidente. L’Unione Sovietica aveva già perso, allorché i desideri dei “compagni” si erano riversati sulle merci e i gadgets dell’Occidente. Ciò ovviamente è il risultato dell’enorme vuoto di idee e narrativa di cui era responsabile l’Unione Sovietica. Cornelius Castoriadis in un libro del 1981, Devant la guerre, parlava del disastro estetico di questa realtà politica, della bruttezza che vi regnava incontrastata[20]. Quando io negli anni Ottanta per la prima volta visitai la Polonia allora comunista e, diretto a Wroclaw, l’antica Breslau[21], scesi dal treno a Katowice, la prima cosa che mi colpì come una frustata fu l’odore che mi investi alla stazione e che poi ritrovavo ovunque nella città, e nelle altre città, una puzza di miseria, che mi ricordava le baracche dei disperati della città siciliana in cui ero nato. La sensazione di miseria e d’abbandono era devastante. Se questo era il socialismo realizzato, ebbene allora non c’era questione: il capitalismo aveva già vinto.
Il disastro dopo l’Ottantanove è ancora maggiore nell’antica Unione Sovietica. A questa l’Occidente, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, non offrono aiuti, che invece sono generosi per gli altri paesi ex-comunisti. La miseria dopo l’ammainamento della Bandiera Rossa[22] al Cremlino nel dicembre del 1991 non diminuisce, ma aumenta in maniera esponenziale. Le frange più deboli sono sconvolte dalla povertà e dall’abbandono, i vecchi pensionati soprattutto. Tra il 1990 e il 1995 l’aspettativa di vita cala dai 65 ai 58 anni. Il disorientamento è generale. Eltsin arriva al potere prendendo a cannonate il parlamento eletto democraticamente, ed è subito celebrato dall’Occidente come il grande leader democratico della nuova Russia. La proprietà privata si ricrea a marce forzate, come del resto negli altri paesi ex-comunisti, a partire dal ceto dirigente, dalla nomenklatura di partito. Da questa hanno origine gli odierni “oligarchi”, ricchissimi nuovi capitalisti cresciuti all’ombra del potere statale e in qualche modo protagonisti della modificazione e della ristrutturazione di questo.
Negli anni Novanta la Russia la si vende, non sempre al migliore offerente. Eltsin introduce un capitalismo selvaggio e la società si decompone. Al fallimento dell’ideologia stalinista si crede rimediare riportando in vita la vecchia mitologia nazionalista e zarista. La bandiera è quella nuovamente della Russia imperiale, il suo simbolo pure, l’aquila bicipite. Leningrado si ribattezza San Pietroburgo, come ai tempi dello zar Nicola primo. La famiglia dello zar Nicola II viene dichiarata santa. La chiesa ortodossa è nuovamente messa in campo per rimpiazzare il vuoto ideologico e il deserto provocato dallo stalinismo. Per dare identità è l’Idea dell’Impero che si rievoca e quella di una Chiesa antica e tradizionale. Il marxismo-leninismo è sostituito da una rozza teologia politica. Ciò ha delle conseguenze importanti sulla maniera della società di pensare se stessa. Mentre questa ambisce a farsi capitalistica e consumistica, e languisce per il desiderio di vestiti di marca e di lusso occidentale, questo movimento individualistico estremo viene riequilibrato e controllato dall’introduzione di riferimenti culturali ancestrali, la Madonna di Kazan, la messa ortodossa, con folle di fedeli che si gettano al suolo per pregare, dinanzi ad un pope nascosto e che canta non visto. Gli ori zaristi riluccicano nuovamente e con essi il mito del “piccolo padre”, come si amava chiamare lo zar, l’autocrate che sovrasta e accompagna la vita dell’umile e lo protegge: Russkij Mir, “mondo russo”. È ritornare a una Russia per certi versi pre-tolstoijana. Lo stesso Dostojevskij ne rimarrebbe sorpreso ed addolorato, ché la ritualità ora è di cartapesta, la socialità sottile, in buona sostanza immaginaria e ridotta nuovamente alla privatezza della consumazione d’un presente senza futuro o all’odio verso l’altro, il diverso, l’omosessuale per esempio.
Caduta la cortina di ferro pareva dovesse celebrarsi il trionfo del diritto internazionale e della costituzione cosmopolita. Ed in effetti l’integrazione europea si accelerava e si fissava nell’Euro, la moneta unica. E l’Organizzazione Mondiale del Commercio si metteva in marcia istituendo efficacemente uno spazio giusprivatistico mondiale. Delocalizzazione globalizzazione si presentano come fenomeni inarrestabili. La Cina, senza diritti sociali, e salari infimi, diventa la manifattura del mondo intero. La globalizzazione riorganizza non soltanto la logistica e la filiera dell’offerta di merci, ma anche aree finora importanti del diritto positivo e della dottrina giuridica. Il diritto del lavoro, fino ad allora disciplina orientata alla garanzia dei diritti e degli interessi dei lavoratori si trasforma in una specie di scienza manageriale o consulenza aziendale, dove la figura determinante è ora l’imprenditore, in una messe di trucchi e cavilli per ridurre diritti e garanzie del prestatore di lavoro.
La globalizzazione sembrerebbe favorire un rafforzamento del diritto internazionale, ed in effetti diventa quasi una moda evocare il “costituzionalismo globale”, come nuovo paradigma sovranazionale di governance, altro termine posto alla ribalta in questa nuova era e molto amato dalla Commissione Europea. Ma invece con la caduta dell’Unione Sovietica e l’unipolarità aggressivamente affermata dagli Stati Uniti è la costituzione materiale del diritto internazionale del dopoguerra a venire a mancare. E così l’ordine giuridico internazionale e i suoi princìpi cominciano a traballare. Pian piano sono smantellati. Si assiste ad una deformalizzazione della norma internazionale. Spesso anche in nome dei diritti umani[23]. In nome di questi si bombarda Belgrado nel 1999. Nel 2001, dopo l’attentato alle Twin Towers di New York, è l’ora dell’Afganistan, invaso per cacciarne i Talebani e instaurare la democrazia. Stessa cosa nel 2003 dove si attacca l’Iraq di Saddam perché possessore di armi di distruzione di massa, in realtà esistenti solo nella fervida fantasia dei neoconservatori statunitensi. Bush figlio, Commander-in-Chief, minaccia le Nazioni Unite, e dà un ultimatum, per appoggiare la guerra d’invasione nel marzo del 2003.
John Bolton, che sarà poi Consigliere per la Sicurezza Nazionale con Trump, si domanda, ma è una domanda tutta retorica: “C’è veramente diritto nelle relazioni internazionali?”.[24] La risposta giusta sarebbe un no secco. A Bolton fa eco Eric Posner, che vede nel diritto internazionale niente altro che un marasma normativo e ideologico che ha fondamentalmente la funzione di tenere legate le mani del gigante americano. Ed ecco perché si fa portatore della reintroduzione della tortura nell’arsenale giuridico statunitense[25]. Ovviamente contra legem internationalem. Del pari per John Yoo, altro giurista conservatore statunitense, e il firmatario (con Jay Bybee) del parere che autorizza l’uso della tortura[26], il presidente può ricorrere alla guerra senza passare dal congresso[27]. Del resto negli Stati Uniti l’ultima dichiarazione di guerra è del 1941. Dopo le guerre sono tutte state iniziate eminentemente mediante atti presidenziali. Robert Kagan dileggia gli Europei molto cauti sull’Iraq contrapponendo il loro stile di vita come venusiano, molle, troppo comodo e facile, mentre gli Stati Uniti sarebbero come Marte, guerrieri, coraggiosi, robusti[28].
III.
La crisi ucraina è l’ultimo capitolo di una storia iniziata allora nel novembre 1989. E del progressivo smantellamento dell’ordine normativo e materiale di diritto internazionale che ne consegue. Un anno dopo, nel novembre 1990, a Parigi si firma una Carta per la Sicurezza Europea. Tra i firmanti c’è l’Unione Sovietica. Si afferma che ormai nel Continente Europeo non c’è più ragione di confronto armato. Ma un anno dopo alla riunione della NATO questa decide di continuare ad esistere e di rafforzarsi[29]. La coincidenza con la conferenza intergovernativa che sfocerà nel Trattato di Maastricht è suggestiva.
Il rafforzamento della NATO e la sua espansione serve a compensare la nascita di una forte struttura sovranazionale europea e mantenerla dipendente dal patto atlantico. Questa mossa è ciò che muove la politica estera americana in Europa fino ai giorni nostri. Ed in questi mesi si è resa ancora più efficace là dove di fronte alla crisi ucraina l’Unione Europea non è stata capace di operare indipendentemente dalla NATO[30]. La crisi ucraina esplode nel 2014, qualche anno dopo che Barroso, il Presidente della Commissione Europea, nel Consiglio Europeo di Bucarest del 2008 aveva offerto all’Ucraina la candidatura a Stato membro dell’Unione.
Nel 1990 il Presidente americano, Bush padre, e il suo Segretario di Stato, Jim Baker, in presenza del cancelliere Kohl, avevano promesso che la NATO non si sarebbe allargata di nemmeno “one inch more”, e che comunque mai e poi mai si sarebbe dato un paese membro della Nato confinante con la Russia[31]. Quella promessa nel corso del tempo è stata una ed un’altra volta violata. Rispetto alla Russia l’espansione della NATO aveva anche come effetto quello di alimentare il separatismo e il nazionalismo estremista dei territori delle vecchie repubbliche integrate nell’Unione Sovietica. È il caso della Georgia, o della Moldavia, e tristemente e drammaticamente dell’Ucraina. Nel 1997 George Kennan, il diplomatico statunitense autore della dottrina del contenimento dell’Unione Sovietica e dunque della “guerra fredda”, pubblica nel New York Times un articolo in cui si parla di «fateful error” a proposito della decisione d’espandere l’alleanza Atlantica: «Such a decision may be expected to inflame the nationalistic, anti-Western and militaristic tendencies in Russian opinion; to have an adverse effect on the development of Russian democracy; to restore the atmosphere of the cold war to East-West relations, and to impel Russian foreign policy in directions decidedly not to our liking»[32].
Nel mentre, la Russia non riesce a far altro che rievocare un passato imperiale ed autocratico, presentandosi anche come modello ai partiti di estrema destra di mezza Europa che vedono in Mosca un nuovo faro, fonte di ispirazione e possibilmente di finanziamenti. Per Fukuyama nel 1989 era finita la storia; il ventesimo secolo si liberava del suo destino di non essere che una prosecuzione dell’Ottocento e delle sue utopie. Si saltava così, cancellando il secolo ventesimo, direttamente nel ventunesimo[33], quello in cui la storia è terminata, e non, come credeva Marx, con la società senza classi, bensì all’incontrario, con società divise perennemente ed eternamente per classi, poveri sempre più poveri, ricchi sempre più ricchi. Oligarchi al potere dappertutto. Tra questi due mondi però ora c’è la guerra, ed in mezzo ci sta l’Europa, dove risorge lo spettro terribile del conflitto armato.
Nel 2014, una volta scoppiato il conflitto, e destituito di forza il presidente filorusso, Putin, il nuovo presidente della Federazione russa dopo Eltsin, decide di riannettersi la Crimea, che nel 1956 da Chruščëv, successore di Stalin a capo dell’URSS, era stata ceduta all’Ucraina, allora a pieno titolo repubblica sovietica. È un passo grave, una violazione del diritto internazionale. Gli accordi di Minsk, che intendono risolvere il conflitto tra Ucraina nazionalista, e separatisti filorussi, siglati nel 2015 rimangono lettera morta. Garanti sono solo Germania e Francia. E il governo ucraino nazionalista non modifica la costituzione in senso federalista, come accordato. I separatisti del Doneck e del Lugansk dal canto loro non disarmano. Hanno la meglio il sentimento revanscista, da un lato, e la paura dell’assimilazione e dell’integrazione del paese nella NATO, dall’altro.
Nella pianura ucraina c’è di nuovo tanto dolore e troppa morte, e si ammassano vittime innocenti. Dell’imperialismo russo, innanzitutto, ma pure tragicamente dell’espansionismo americano e dell’imbelle politica estera dell’Unione Europea. Invece di operare per una tregua, per un cessate il fuoco, per evitare altre vittime, ci si affida alla retorica più bellicista. Si vuole la vittoria, non la pace. Se la massima giustificazione che si è data all’Unione Europea ed alla sua esistenza è il mantenimento della pace, ebbene ciò ora sembrerebbe esser falsificato dalla realtà. Che sancisce la fine della fine della storia. Gruppi sociali, nazioni, e soprattutto Imperi sono nuovamente in rotta di collisione. La storia si riaffaccia e ricattura le nostre vite col suo profilo più tradizionale ed antico. Quello della forza e della violenza, che credevamo aver bandito, e poter aver dimenticato. L’incubo della bomba atomica sembra non preoccupare più tanto. Per molti osservatori, e forse anche qualche partecipante, è come assistere ad un gigantesco videogioco. Tenute militari dappertutto. L’estetica militarista si impone. E trionfa la pornografia della guerra, il “reality show” dei suoi orrori, che ci è servito quotidianamente ed ossessivamente nei media e specialmente in televisione.
È come un movimento di placche tettoniche che urtano le une contro le altre. E l’Europa si trova al centro del movimento, è nell’epicentro del terremoto che si annuncia. Qui si gioca il futuro dell’integrazione europea e della stessa capacità dell’Europa di mantenere il suo elevato standard di benessere e di civiltà. Affidarsi alla guerra in un terremoto non è di certo la migliore soluzione. Credevamo che la pandemia ci avesse insegnato la centralità della cura e della solidarietà necessaria per la fragile condizione umana, e invece abbiamo a che fare con carri armati che sparano ed esplodono, con navi affondate, con città martoriate dalle bombe, pacifici civili ammazzati. È quasi da non crederci. Cos’è che è andato storto?[34]
«Europe is not entering its troubled wartime past – on the contrary, it is leaving it», l’Europa non sta rientrando nel suo turbolento passato fatto di guerra, lo sta lasciando – così concludeva la Prefazione di Postwar, la narrativa del secondo dopoguerra in Europa proposta da Tony Judt[35]. È un pensiero ottimista, aperto speranzosamente ad un permanente futuro di pace. Ma ora sembra che la storia gli dia torto, e ritornino i fantasmi del passato più buio. Dunque, non è la fine della storia, semmai è “la fine della fine” di questa, oppure “la fine dei tempi”, “the end of times” – come ci annuncia apocalitticamente Slavoj Žižek [36].
[1] Cfr. M.E. Sarotte, The Collapse. The Accidental Opening of the Berlin Wall, Basic Books, New York, 2014.
[2] Vedi K. Polanyi, The Great Transformation, Farrar & Rinehart, New York 1944, al quale si contrappone F.A. von Hayek col suo The Road to Serfdom, Routledge, London, 1944.
[3] Vedi F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 1992.
[4] Vedi, paradigmaticamente, G.W.F. Hegel, Einleitung in die Geschichte der Philosophie, a cura di J. Hoffmeister, Felix Meiner, Hamburg, 1959, 111, ove si dà una definizione di “fine della storia” come «eine Rückkehr in sich», ritorno in se stessa.
[5] Su questa città c’è un magnifico libretto di Josef Wittlin, My Lviv as City of Lions, traduzione inglese dell’originale polacco del 1946, a cura di Ph. Sands, Pushkin Press, London 2016; di questo scritto c’è anche una traduzione spagnola, Mi Lvov, Editorial Pre-textos, Valencia 2012. E cfr. A. Döblin, Reise in Polen, Fischer, Frankfurt am Main, 2016 (I ed. 1923), 169 ss. Più di recente su Lwov, cfr. Ph. Sands, East-West Street, Weidenfeld & Nicolson, London, 2017.
[6] Vedi J.H.H. Weiler, Fin-de Siècle Europe, in Id., The Constitution of Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
[7] Cfr. H. Kissinger, World Order, Penguin, London 2015, capitolo secondo.
[8] O. Hintze, Nationale und europäische Orientierung in der heutigen politischen Welt, in Id., Soziologie und Geschichte. Gesammelte Abhandlungen zur Soziologie, Politik und Theorie der Geschichte, a cura di G. oestreich, II ed., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1964,195.
[9] Cfr. M. Gilbert, European Integration. A Political History, II ed., Rowman & Littlefield, London, 2020.
[10] È questa, com’è noto, la tesi difesa da Alan Milward: vedi A.S. Milward, The European Rescue of the Nation-State, Routledge, London, 1992.
[11] Vedi F.A. von Hayek, The Economic Conditions of Interstate Federalism, in Id., Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, Chicago, 1948, 255 ss. Si legga anche F. A. von Hayek, Denationalisation of Money – The Argument Refined, III ed., The Institute of Economic Affairs, London, 1990.
[12] H.P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Mohr, Tübingen, 1972.
[13] Per un panorama d’insieme dell’ordoliberalismo, cfr. A. Zanini, Ordoliberalismo. Costituzione e critica sei concetti, Il Mulino, Bologna, 2022. Per la concezione della cittadinanza elaborata da Aristotele, rimando a M. La Torre, Cittadinanza. Teorie e ideologie, Carocci, Roma, 2022.
[14] Lo vede bene Hans Morgenthau: «The cement that kept the alliance together was the paramount power of the United States. In the past there had been alliances in which power was unequally distributed and one ally was predominant; but rarely had there been such a concentration of paramount power in one ally, with all other allies, even collectively, being in a subordinate position» (H. J. Morgenthau, The Purpose of American Politics, Vintage Books, New York, 1964, 182).
[15] Per questa connessione, cfr. Q. Slobodan, Globalists. The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 2020.
[16] Vedi B. Ackerman, The Future of Liberal Revolution, Yale University Press, New Haven, Conn., 1993.
[17] Cfr. J.H.H. Weiler, Europe in Crisis—On ‘Political Messianism”, ‘Legitimacy’ and ‘Rule of Law’, in Singapore Journal of Legal Studies, 34/2012, 248 ss.
[18] Cfr. P. Hassner, Ni sang ni sol? Crise de l’Europe e dialectique de la territorialité, in Id., La terreur et l’empire—La violence et la paix II, Seuil, Paris 2003, 333 ss.
[19] E. Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. J. H. W. Dietz, Stuttgart, 1899.
[20] C. Castoriadis, Devant la guerre, II ed., Fayard, Paris, 1983, 263 ss.
[21] Su cui si leggano le pagine di N. Davies, R. Moorhouse, Microcosmos: A Portrait of a Central European City, Jonathan Cape, London, 2002.
[22] Cfr. E. Brainerd, Mortality in Russia Since the Fall of the Soviet Union, in Comparative Economic Studies, 63/2021, 557 ss.
[23] Si legga ora S. Moyn, Humane. How the United States Abandoned Peace and Reinvented War, Farrar, Straus & Giroux, New York, 2021.
[24] J. Bolton, Is There Really “Law” in International Affairs?, in Transnational Law and Contemporary Problems, 10/2000, 1 ss.
[25] Vedi R. Posner, J. Goldsmith, The Limits of International Law, Oxford University Press, Oxford, 2005, e R. Posner, The Twilight of Human Rights Law, Oxford University Press, Oxford, 2014.
[26] Vedi R. Posner, A. Vermeule, Terror in the Balance: Security, Liberty, and the Courts, Oxford University Press, Oxford, 2007.
[27] Vedi J. Yoo, The Power of War and Peace. The Constitution and Foreign Affairs after 9/11, University of Chicago Press, Chicago, 2005.
[28] Vedi R. Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order, Vintage Books, New York, 2004.
[29] Cfr. R. Poch-de-Feliu, La invasión de Ucraina, Revista contextos, Madrid 2022.
[30] Cfr. W. Streeck, The EU after Ukraine, in American Affairs, 6/2022.
[31] Cfr. M.E. Sarotte, Not One Inch. America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate, Yale University Pres, New Haven, Conn., 2022.
[32] G.F. Kennan, A Fateful Error, in “New York Times”, 5 febbraio 1997.
[33] Cfr. J. Rancière, Aux bords du politique, Gallimard, Paris 2007, 25. Cfr. altresì A. Badiou, Le siècle, Seuil, Paris 2005, 54.
[34] Cfr. R. Müllerson, What Went Wrong?, in Russia in Global Affairs, 20/2022, 30 ss.
[35] T. Judt, Postwar. A History of Europe Since 1945, The Penguin Press, New York, 2005, 10.
[36] S. Žižek, Living in the End of Times, II ed., Verso Books, London, 2017.
SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE