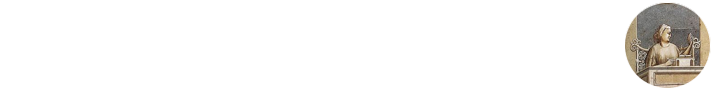EDITORIALE – Sovranità e diritti tragici – Migrazione e cittadinanza
DI MASSIMO LA TORRE
Nonostante la pandemia non sembra che il movimento epocale delle migrazioni dal sud al nord della terra, tanto in Europa come in America, si sia arrestato significativamente. La Spagna sta vivendo una rinnovata pressione migratoria, soprattutto sulle isole Canarie, e nel Mediterraneo i barconi non si fermano, e con essi non si arresta lo stillicidio di morti in mare. La migrazione dai paesi poveri ai paesi ricchi è nella nostra epoca, nella quale la speranza del cambiamento sociale globale, si è assai attenuata, in un tempo in cui l’utopia non sembra più scaldare i cuori, una specie di surrogato della rivolta sociale. La rivoluzione sociale, la sovversione della gerarchia di classe, la lotta per l’uguaglianza e la ridistribuzione delle risorse, sembra prendere le fattezze per l’appunto della migrazione. Il giovane sub-sahariano o algerino che non crede più che le cose possano cambiare nel suo paese tenta la strada, tutta individuale, privata, della rotta verso la ricca e libera Europa.
Vi è in questo fascino dell’Europa anche molto dovuto alla sua socialità vissuta in buona sostanza come un grande spettacolo proiettato sugli schermi dei televisori, computer e telefonini di tutto il mondo. Le antenne paraboliche, insieme ai telefoni portatili, non mancano certo nelle bidonvilles del Senegal o della Nigeria, o nei quartieri distrutti dalla guerra dell’Iraq e ella Siria. E lì si manifesta la radicale alterità tra il mondo devastato dalla penuria e all’incuria, dalla fame e dalla guerra, e dalla disperazione della inesistenza di una prospettiva felice di vita, e i lustrini che si agitano nei nostri programmi televisivi. Avvenne già trent’anni fa, all’indomani della caduta del muro di Berlino, allorché nella costa pugliese arrivò dall’Albania una nave scassata stracarica di migliaia di disperati. La televisione aveva riempito gli occhi dei nostri vicini della visione paradisiaca di “Quelli della notte”, lustrini e “paillettes” di attori e ballerine, così come in maniera abbastanza simile era avvenuto nella Germania orientale grazie alla televisione ed alla pubblicità martellante del vicino Stato occidentale.
Il 9 novembre 1989 i Berlinesi dell’Est si riversarono all’Ovest in cerca sì di libertà e di dignità, ma questa spesso ravvisando o volendo almeno in prima battuta godersi nella sigaretta americana. Ricordo allora una marca tedesca “Go West”, che era significativa di un atteggiamento e di un desiderio collettivamente urgente. Si desideravano le sigarette americane e anche le banane. E sì perché a Berlino Est non si era vista troppo da vicino una banana, e tanto meno provata, assaggiata. Ricordo che nei supermercati della Germania Orientale la frutta era quasi inesistente, ed era offerta soprattutto in vasetti sotto spirito.
Ci muoviamo e agiamo per i desideri che ci agitano e quello di frutta è tanto legittimo come quello della rivoluzione sessuale che agitava masse di giovani tra Berkeley e Francoforte negli anni Sessanta. E il desiderio nasce dalla mancanza di qualcosa, e dalla comparazione. La mancanza ora nei paesi poveri del mondo è evidente, drammatica, aggravata ulteriormente da decenni di neoliberalismo. E la comparazione adesso è immediata ed onnipresente, immediatamente attiva, attraverso la rete, che opera soprattutto per immagini. E queste son ben più efficaci e motivanti di ragioni e argomenti. Il disastro ecologico, ambientale, sociale, e sì anche estetico, di quelle aree del mondo e di quella convivenza e sopravvivenza produce dolore. E voglia, urgenza di rimediare. Di riprendersi la vita. E la sua bellezza.
La bruttezza si è impadronita della povertà come mai prima era accaduto al mondo. Fino a qualche decennio fa il villaggio africano sulla costa atlantica era sì miserabile, ma ancora possedeva una accettabile bellezza. Il mare vi era incontaminato, la spiaggia vasta e vergine, la natura rigogliosa, ancora intatta. Oggi questo quadro vagamente idillico è stato modificato in maniera radicale. Alla paglia della capanna si è sostituito il metallo e il cemento, slabbrato e sbrecciato però. La spiaggia è piena di rifiuti di plastica e di residui chimici, la natura è bruciata dal petrolio e dall’inquinamento. Lo stesso abbigliamento, una volta vivace e tradizionale, ma per certi versi grazioso, è stato rimpiazzato da t-shirts, pantaloncini, tute, scarpe di gomma, jeans da quattro soldi ecc., che rendono quella massa ancora più povera, ricoperta una paccottiglia ricalcata sullo stile occidentale di vestire. Lo squallore predomina il paesaggio corrotto dall’ingordigia capitalista delle multinazionali e dal neocolonialismo depredatore. Agli occhi si presenta un panorama che non offre loro riposo né appiglio. Ci si rifugia allora nello schermo del computer e dl telefonino, e nella terra del bengodi che i nostri show permanentemente ci rappresentano. La sabbia dorata delle nostre pubblicità si sovrappone alla spiaggia corrosa di residui tossici che ci si trova dinanzi. Ed allora si produce il desiderio imperioso di fuggire, di emigrare, costi quel che costi, anche la vita.
La figura del viandante, e l’esperienza della migrazione, ci sono familiari. Fanno parte tanto della nostra tradizione culturale come della nostra esperienza di vita. Ciò è acuto per un Italiano del Sud. Se parlo della mia personale esperienza, mi viene innanzitutto alla memoria che una parte della famiglia paterna, quella della nonna paterna emigrò negli Stati Uniti alla fine dell’Ottocento. Mia nonna ancora aveva contatti con quei parenti, ma il filo si è spezzato con la sua morte, e chissà cosa ne è stato di quei Siciliani partiti per l’America in cerca di un destino migliore. Dei ragazzi della mia classe di liceo, una buona parte è sparpagliata per l’Italia del Nord e qualcuno ha persino trovato il suo posto di lavoro all’estero. Nella mia città molti dei migliori tra i giovani di quel tempo, gli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo, sono andati via, e non credo che nelle successive generazioni le cose si siano sviluppate in maniera molto diversa. La città, la patria, allora si è impoverita, perdendo tanti dei suoi figli più intraprendenti ed intelligenti. “Cu nesci arrinesci”, “chi esce riesce” – dice un vecchio detto siciliano. Terribile da pronunciarsi ad un giovane, ed ai padri di quel giovane.
Dunque, l’emigrazione è un fatto quasi costitutivo dell’esperienza di vita del Meridione d’Italia. E credo che lo stesso valga per altri paesi dell’Europa del Sud, per gli Spagnoli, per i Greci, per i Portoghesi. Ricordo che una delle cose che più mi colpì del Lussemburgo, oltre che la sua opulenza, fu che un settore importante della sua popolazione è composto di Portoghesi, emigranti arrivati nel paese ricco dell’Europa occidentale a partire dagli anni Cinquanta. Dopo il francese, e più del lussemburghese, è il portoghese la lingua che risuona nelle vie linde del Granducato. Non mi arrischio poi a dettagliare i movimenti migratori, in gran parte forzati, che hanno afflitto il continente europeo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Masse di rifugiati e di cacciati dalle loro case che hanno percorso e riempito le strade allora ancora piene di macerie delle strade d’Europa. Tedeschi, Polacchi, Ungheresi, per non dire degli Ebrei, spinti di qua e di là dalle vicende imprevedibili e crudeli della grande storia.
Dove che ci si rivolga in Europa dunque il fatto della migrazione, del movimento di masse d’esseri umani da un paese ad un altro paese, è qualcosa di ricorrente e addirittura di fondante la realtà della convivenza. E poi una grande migrazione è alle origini della nostra religione, del cristianesimo. Che si sia credenti o no, si celebra il Natale con pari allegria e con la stessa attesa. Ma il Natale è l’evento di un vagabondare perché migranti, o meglio rifugiati, esuli, fuggendo l’olocausto degli innocenti voluto da Erode. San Giuseppe, la Vergine Maria, e lo stesso Gesù sono degli esuli, siriani in cerca di salvezza in un paese che non è il loro. Ulisse, l’altra figura mitica della nostra tradizione culturale, colui che ci ricorda che “fatti non fummo “a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”, anche lui è un viandante, anzi un migrante, ancora meglio un esule, e un rifugiato. Sì, è vero riesce a tornare avventurosamente a casa, ma lì trova i nemici installati a casa. E ci ha messo dieci anni di vicissitudini per quel ritorno. Perdendo i compagni, infine affogati nel Mare Nostrum, come accade ancora oggi, anche in questi giorni, ad altri che tentano la via del mare. Così che il migrante in un certo senso siamo noi stessi. Le sue peripezie sono le nostre stesse rimandate di qualche decennio, e chissà anticipate rispetto ad un futuro che potrà vederci nuovamente salire in barca ed affidarci alle onde.
Ora, tutto questo proviamo a dimenticarlo. Non ci fa piacere ricordare quella nostra origine. La sopprimiamo nell’inconscio. E ci sono movimenti politici che ingrassano di questa nostra soppressione, del rigetto di quella perdita di sicurezza e patria che ha dovuto precedere quel po’ di identità che oggi ci ritroviamo addosso e di cui ci fregiamo. Al desiderio di migrare succede, o così ci è successo, il rigetto di quella esperienza e l’affermazione della sua insostenibilità ed illegittimità. E proiettiamo questo sull’altro che è ora in mare e si riversa sulla nostra costa, ripercorrendo in una direzione e nell’inversa il nostro stesso tragitto.
Ma – si domandano i filosofi e i cittadini con loro – c’è un diritto di migrare? E posto che ci sia tale diritto, possiamo affermare un equivalente diritto di accoglienza che si sostanzi e istituzionalizzi nella concessione della residenza e della cittadinanza del paese che accoglie? Ora, queste domande sono allo stesso tempo facili e difficili da rispondere in maniera sensata, e sensibile.
Forse Kant ci può essere d’aiuto. Sappiamo che per lui nell’umanità, tra le varie nazioni, vale un jus communicationis, un diritto di comunicare e di conoscersi, che rende lecito il movimento di persone da un paese all’altro, ad anzi auspicabile. Ed a questo diritto, per renderlo operante, si accompagna corrispondendolo un dovere di ospitalità da parte di quella nazione verso la quale ci si sposta. Altra cosa però è che questo dovere di ospitalità comporti necessariamente od automaticamente un obbligo di concessione della residenza e poi della cittadinanza. D’altra parte, non sembra che per Kant le frontiere siano delle linee di divisione tra comunità prive di legittimità morale. Sappiamo che per il filosofo tedesco il diritto cosmopolitico, che sorregge la libera circolazione di persone, non comporta che le frontiere si aboliscano. Ciò perché quella abolizione presupporrebbe una comunità politica universale che, comportando inevitabilmente un eccesso di centralizzazione rispetto alla attuale divisione per nazioni, renderebbe il governo mondiale pericolosamente potente e monopolizzatore, un inaccettabile rischio per la libertà politica.
La divisione dei poteri per Kant non va stabilita solo all’interno degli Stati tra le sue diverse funzioni di governo. Una divisione di poteri è auspicabile tanto dentro quanto fuori dallo Stato. E fuori da questo essa si presenta innanzitutto nella forma della pluralità degli Stati. La comunità internazionale così, per essere repubblicana, nel senso di Kant, non deve essere formata solo da Stati di forma repubblicana, cioè strutturati secondo la divisione dei tre poteri, legislativo, esecutivo, e giudiziario, ma deve essere anche una comunità di distinti centri di potere statale, una comunità di Stati dunque, senza che nessuno di questi abbia il sopravvento sugli altri, e senza che la comunità sia incorsettata e resa omogenea entro una sola forma statale. Il cosmopolitismo di Kant risulta dunque “debole”, perché controbilanciato da una forte idea di cittadinanza. E la garanzia di pace perpetua in questa prospettiva non risiede nella unificazione politica del mondo, bensì nella qualità “repubblicana”, vale a dire democratica e pluralista, degli Stati che la comunità internazionale compongono.
Ciò ci rimanda alla questione della legittimità delle frontiere. Da un lato queste ci appaiono spesso come dei confini tracciati in maniera arbitraria e fortuita, prodotto di guerre, di alleanze, di decisioni imperiali, o di casi della storia, o ancora di fatti meramente geografici, un fiume, una catena di montagne, uno stretto di mare. E non vi è dubbio che sia così. Però la frontiera d’altra parte ci appare nella storia un presidio che ci offre sicurezza, una protezione rispetto a pericoli esterni, un’invasione, la perdita delle nostre libertà, e della nostra identità, un baluardo contro il nemico. E purtroppo di nemici nella storia le varie comunità umane ne hanno avuti, e di irriducibili e implacabili. La frontiera svolge la funzione delle mura di casa, che ci rinchiudono sì, ma allo stesso tempo ci proteggono, e ci offrono un rifugio. Tornare a case, nelle mura di casa, dopo una giornata di fatica e di confronto (e talvolta anche di lotta) con gli altri, spesso è un sollievo. E poi abbiamo bisogno di essere “da noi”, con noi stessi. Non ci piacerebbe vivere sempre per strada, sempre in mezzo gli altri. Abbiamo bisogno anche di solitudine, di raccoglimento, di intimità.
Mutatis mutandis, un paese svolge la stessa funzione di una casa, e le frontiere ne delimitano lo spazio. Lo spazio per essere significativo, e svolgere una funzione rappresentativa, deve essere limitato. Com’è limitato un quadro dalla cornice, o uno scritto dalla pagina. O il tempo entro delle coordinate specifiche che lo scandiscono.
C’è una fine ed un principio. La limitazione fa parte della stessa condizione umana, che ha a disposizione tempo e risorse irrimediabilmente circoscritte. Kant in un breve scritto, Das Ende aller Dinge, “Il fine di tutte le cose”, ci offre quattro modelli di convivenza a suo parere negativi. Questi sono il carcere, il manicomio, la cloaca, ed infine il caravanserraglio. Questo è il posto dove si incontrano dei viaggiatori in continuo movimento, e per un po’ di riposo, una sosta nel loro viaggio, per rinfrescarsi e cambiare i cavalli e il postiglione. Il caravanserraglio del presente potrebbe essere offerto dall’aeroporto. Questo è un luogo dove si incrociano in ogni momento migliaia di esseri umani in viaggio, partono ed arrivano, perpetuamente, si fermano qualche ora o pochi minuti, si incontrano, forse scambiano qualche parola, ma non vi è tra loro vera conversazione, discorso articolato, né interessi comuni, e tanto meno senso di comunità. Una società dalle frontiere completamente aperte, o senza frontiere, assomiglierebbe assai ad un tale luogo, ad una tale situazione del tutto contingente e provvisoria; si ridurrebbe probabilmente ad una specie di caravanserraglio. E i caravanserragli sono tutti uguali, e il pluralismo delle forme di vita in tal modo si ridurrebbe invece dia aumentare. Tranne che le frontiere non si aprissero a intervalli regolari, a distanza di un certo numero di anni. Ma allora nuovamente la legittimità delle frontiere non sarebbe negata, anzi riaffermata. Ché la loro apertura dovrebbe poi concludersi con la loro rinnovata chiusura.
La delimitazione delle frontiere rimanda anche alla questione della sovranità. Questa significa capacità di decisione delle norme e dei provvedimenti che regolano la vita associata. Ciò però presuppone che quelle norme e quei provvedimenti possano essere efficaci, che la vita associata in un certo spazio e tempo sia effettivamente prodotto di quelle norme e decisioni. Dunque, non vi è sovranità possibile senza un controllo del territorio, della terra e forse anche del cielo. Si racconta che Mao-tse-Tung ad una delegazione del Partito comunista italiano in visita in Cina specificasse la concezione cinese della sovranità nazionale sollevando il braccio ed indicando anche il cielo. Sovranità anche di questo allora, a voler dir che anche gli dei e la religione sono inclusi entro il potere di disposizione del sovrano. La religione fa parte del dispositivo della sovranità—ricorda Mao, ed ecco perché la separazione Stato e Chiesa risulta invero sempre particolarmente problematica e controversa.
Ora, la democrazia non sfugge alla presa della sovranità. Certo, a seconda di come la si intenda, si puà articolare la sovranità popolare democratica, in modi diversi, e fors’anche contrapposti. Si può avere una concezione, diciamo così, “giacobina” della sovranità democratica, accentratrice e priva di controlli esterni, senza troppi diritti fondamentali azionabili. Oppure si può avere una sovranità di carattere – diciamo così – “girondino”, tendenzialmente federalista, pluralista, con esigenti diritti fondamentali che la limitino dal basso e mediante procedure giudiziali. Resta però la necessità dell’efficacia della norma sovrana, come che questa sia prodotta e sia garantita, della sua presa sul territorio e su coloro che alla sovranità rispondono. La cittadinanza è l’altra faccia della sovranità, soprattutto di quella democratica. Cittadino è colui che prende parte alla decisione sovrana e la implementa con l’esercizio dei suoi diritti, che sono come frammenti di sovranità, che si ricompongono in un mosaico coerente, là dove per l’appunto della cittadinanza si offra un quadro determinato, delimitato.
Il circolo virtuoso tra sovrano e cittadino, per cui colui che deve obbedire alla norma deve poter anche avere acceso alla produzione di questa, richiede che sia possibile identificare e delimitare i destinatari della norma. E ciò si fa in maniera efficace delimitando un territorio entro il quale i soggetti che vi operano siano sottomessi alle norme e pertanto anche protagonisti di questa. Ciò ovviamente in via di principio, e come direbbe Aristotele “per lo più”. Altrimenti avverrebbe che un sovrano sarebbe operativo su soggetti che però non possono influire su di esso o partecipare alle sue funzioni. Tutto questo richiede una delimitazione di coloro che sono soggetti alle sue norme, uno spazio di delimitazione della validità e dell’efficacia di tali norme, dunque un territorio politicamente qualificato, in conclusione frontiere che diano evidenza e sicurezza a tale delimitazione. Da ciò purtroppo non si sfugge.
Così come la sovranità e sovranità sulla sovranità, competenza-competenza, potere sulla definizione e l’uso del potere in questione, del pari la cittadinanza consiste o necessita di una competenza-competenza, meta-competenza, di analogo tenore. Essa si deve dare come potere del cittadino di stabilire chi è il cittadino. La cittadinanza anch’essa è dunque soggetta ad una delimitazione, secondo criteri deliberati, discussi, e posti dagli stessi cittadini. In un certo senso, una cittadinanza che fosse concessa a tutti gli esseri umani automaticamente, entrerebbe in conflitto con questa sua natura riflessiva e di meta-competenza. Non vi è essenza della norma qui. Non vi è nella cittadinanza automatismo che non possa essere rivisto: altrimenti la meta-competenza sarebbe contraddetta e negata. Ciò però ha come esito che la cittadinanza ha una natura essenzialmente esclusiva.
Per quanto siano i generosi i criteri di concessione ed ammissione alla cittadinanza, per quanto la si renda porosa, essa sempre si dà secondo la logica binaria di cittadino e non cittadino. Una cittadinanza cosmopolita pertanto cesserebbe di essere cittadinanza, giacché necessariamente avrebbe perso il carattere di meta-competenza. Non potrebbe più restringere o ampliare la sua classe di appartenenza. Questa facoltà ora le sarebbe interdetta. Ma in tal modo la cittadinanza si ridurrebbe a qualcosa d’altro, ad uno statuto non più convenzionale, artificiale, plasmato riplasmato secondo deliberazioni collettive, ma in una essenza normativa cui la norma dovrebbe solo copiare o riflettere.
Tale irriducibile artificialità o convenzionalità della cittadinanza ne fa però una qualità tutta accidentale, dunque uno statuto giuridico particolarmente delicato e controverso. Rimane in essa –deve constatarsi –un elemento anti-universale, e persino antiegualitario, che la spinge sul crinale dell’ingiustizia. Ed allora vi sono studiosi, come per esempio il Professor Thomas Gutmann dell’Università di Münster, che ne parlano come dell’ultimo privilegio feudale e per certi versi pre-moderno residuo nella modernità giuridica. La modernità giuridica si riappropria e rimette all’ordine del giorno la figura del cittadino, per opporsi alla gerarchia ed alla inuguaglianza fissata nella figura del suddito feudale, ma coì facendo riproduce uguaglianza ed anche sì gerarchia, quella tra cittadino e non-cittadino. E tuttavia, se vogliamo pensare alla cittadinanza come ad una situazione normativa democratica, non possiamo sfuggire a quell’esito escludente.
Tutto ciò non può non avere delle immediate ripercussioni sulla questione della migrazione. Questa è un diritto, fondato nella libertà di movimento che è insita nella stessa fenomenologia dell’essere umani. Ed è fondata inoltre nel diritto alla felicità, nel diritto a cercare ed ottenere una forma di vita che ci risulti soddisfacente e nel quale si possa dispiegare al massimo la nostra dignità. Il nostro “fiorire” è cosa del nostro autonomo progetto di vita, e questo può potersi realizzare solo emigrando, alla ricerca di una vita migliore. Qui emerge un diritto morale forte che nessuno può negare. Ma dall’altro lato si contrappone un diritto politico, quello di darsi la comunità insieme ad altri secondo regole comunemente ed autonomamente scelte. E vi è il diritto, questo morale, di restare “tra di noi”, il diritto alla “casa”, ad una certa solitudine ed intimità, che non sia interrotta o disturbata o distrutta dagli altri. Migrazione e cittadinanza confliggono. In questa situazione scorgo un’occorrenza nella quale la “unica risposta corretta”, che pure ritengo sia azionabile nella gran parte del territorio normativo, sia difficilmente ottenibile, anche in via di principio. In filosofia morale una delle contrapposizioni fondamentali, una delle “grandi divisioni”, è tra coloro che sostengono l’incommensurabilità di valori, princìpi e diritti, e dunque parlano di “scelte tragiche”, sempre inevitabilmente più o meno ingiuste, che si consumano e devono consumarsi nella solitudine della decisione non compiutamente giustificabile. E poi vi sono coloro che credono che le scelte siano tutte compiutamente giustificabili, e che vi sia sempre un criterio tale da ricomporre il conflitto tra valori e diritti, e che possa ricondurli alla “sola risposta giusta”. Io credo che sia questa seconda la soluzione più appropriata al campo della deliberazione morale, e giuridica.
E tuttavia rispetto allo scontro tra diritto di migrare e diritto di cittadinanza mi sembra di dover alzare le braccia. Non che qui si debba decidere in maniera irrazionale, ricorrendo al mero decisionismo o tirando a sorte. Ma mi pare che la risposta corretta, che pure potrà rinvenirsi dipendendo dalle circostanze di fatto, lascerà sempre uno strascico di ingiustizia.
Ciò che di certo va detto però è questo: la cittadinanza si applica e presuppone il circolo virtuoso tra obbedienza alla regola della forma di vita e sua produzione. Non si vede allora come chi obbedisce alla regola possa essere democraticamente escluso dalla produzione di questo. Può solo accadere e giustificarsi in via provvisoria e prodromica; ma il circolo virtuoso deve essere prontamente ristabilito e riaffermato. Del pari una frontiera assolutamente escludente non può giustificarsi. Il diritto di migrazione può darsi come un’esigenza esistenziale basica e come diritto morale fondamentale, e questo tra l’altro è ricompreso nella autocomprensione della democrazia, la quale deve prevedere il diritto di esodo, il diritto all’abbandono della comunità. La democrazia si dà come articolazione sì della “voce”, voice, ma anche dell’”uscita”, dell’exit.
Allora, se la sovranità si dà anche necessariamente nei termini di una rinunzia volontaria alla partecipazione a questa ed all’entità ch’essa comporta (l’exit, per l’appunto), la reciprocità insita nella normatività delle pretese soggettive richiede che il diritto all’abbandono si rovesci nel diritto all’accesso alla comunità e all’ingresso in questa. Ci ritroviamo qui su un terreno esistenzialmente sensibilissimo, nel quale reciprocità e consapevolezza dell’ingiustizia dell’agire sovrano devono andare di pari passo. E con quella irrimediabile ingiustizia dobbiamo fare i conti, riducendola al massimo, e poi mai potendoci gloriare della situazione di cittadinanza. La fratellanza è una bella cosa, ma che si sappia e si ricordi sempre che questa ha dei limiti (ché non si estende naturalmente a tutti, nemmeno al “prossimo”), e che tali limiti rimangono ingiusti e fonte di umiliazione e di dolore per molti. Di questo dolore e di questa umiliazione non si potrà evitare di assumersi la responsabilità e, direi anche, la “colpa”, specialmente là dove si tratti della istituzionalizzazione e dell’irrigidimento giuridico di quel legame ed affetto collettivo.
SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE