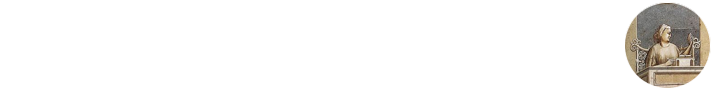EDITORIALE – Stato di Diritto e Democrazia populista
DI MASSIMO LA TORRE
I.
La pandemia che non finisce e continua ad affliggerci e ad impaurirci pare non spegnere la ventata irrazionalista che da tempo attraversa Europa e buona parte del mondo. Gli Stati liberal-democratici si sono vieppiù appassiti e nella loro crisi di identità si spingono verso territori nei quali le mediazioni istituzionali e il principio di legalità agiscono con ridotta efficacia. Questa trasformazione o almeno tendenza è stata etichettata come “populismo”, anche se il termine è abbastanza vago, invero una specie di etichetta che si attacca secondo le esigenze della lotta politica, più che col rigore dovuto ad una meditata analisi scientifica. È come una coperta troppo stretta che si tira da un lato e dall’altro, per ricoprire spiegandola o criticandola o anche elogiandola, una certa realtà politica, ma una parte di quel corpo rimane sempre scoperta, non spiegata cioè, esposta al dubbio e all’incomprensione.
Sappiamo che di populismo ci sono due usi principali, uno più normativo, o prescrittivo, l’altro più analitico, o descrittivo. Per l’uso normativo, reso in voga da saggi di Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, populismo è un regime nel quale la democrazia si fa “popolare”, di massa, e per certi versi rivoluzionaria, sconvolgendo l’assetto sociale di classe, e dunque puntando all’uguaglianza sociale, e ciò fa mediante l’agitazione di miti comunitari e anche cesaristici. Dietro quest’uso si può intravedere la figura e l’esperienza del peronismo argentino, giudicato qui con molta benevolenza e forse ammirazione. Si tratterebbe di una democrazia maggioritaria, di “descamisados”, di emarginati e proletari, ma democrazia però diretta con energia e capacità propagandistica da un leader o un gruppo di leader che riescono a catturare la fantasia del popolo e farlo sentire cosa unita e totale. Si dà un transfer psicanalitico tra leader e popolo.
È questo un modello alternativo a quello freddo e razionale proposto da John Rawls nel suo saggio Political Liberalism, dove si propone un regime di regole di convivenza grosso modo neutrali, tali da poter ricomprendere varie concezioni generali della buona vita. In questo regime Rawls si affida ad una costituzione di regole in buona sostanza resa efficace da un corpo di giudici supremi, una Corte costituzionale, che il filosofo americano identifica come il foro principale della ragione pubblica. A questo modello già rispondeva criticamente Jürgen Habermas, che ne sottolineava il rischio elitista ed oligarchico. Se sottraiamo la ragione pubblica alla sfera deliberativa della generale cittadinanza ci potremmo avviare verso la china scivolosa di uno Stato di filosofi-re, ovvero di quel “governo dei giudici” che per decenni è stato l’incubo dei democratici francesi, ostili per principio ad un controllo giudiziale troppo stringente sulla legge. Ora, il populismo normativo radicalizza la critica democratica al liberalismo politico rawlsiano, accusandolo di mancanza di sostanza e di virtù, e di visione, oltreché di capacità d’integrazione cittadina.
Il liberalismo politico rawlsiano così è considerato un regime di protezione dello status quo, e della subordinazione di classe. L’uguaglianza vi resta formale, superficiale. Perché si abbia vera democrazia bisogna che le masse si agitino, si mobilitino, si sentano compartecipi, e ciò può avvenire solo mediante l’evocazione di miti comuni e di figure carismatiche. Al partito politico tradizionale così Laclau e Mouffe sembrano sostituire la figura del leader e il suo corpo. La fantasia o l’immagine assumono un ruolo centrale nella operazionalizzazione dell’ideologia. Questa passa attraverso la diffusione del mito e dell’immagine. È questo però – paradossalmente – il momento in cui il populismo normativo si collega e si lega al populismo analitico e descrittivo. Qui studi come quelli di Yves Mény, John Keane, Jan-Werner Müller, ecc., puntano a spiegare il passaggio di cui si diceva sopra dallo Stato liberaldemocratico tradizionale, legato al principio di legalità e ad un regime parlamentare di partiti, ad uno Stato nel quale il carisma del leader diventa la forza centrale del sistema politico.
Si pensi a ciò che è accaduto in Italia, dove almeno fino al 1991, a “mani pulite”, la politica e la gestione dello Stato erano saldamente nelle mani dei partiti politici, e questi erano macchine grosso modo collettive mai veramente risucchiate da figure carismatiche, anche in presenza di grandi figure di direzione, come per esempio nel caso di Togliatti, di De Gasperi o di Craxi. Nessuno di questi poteva dirsi tutto il partito. Bene o male, continuavano ad esistere le correnti, i congressi del partito discutevano e decidevano. Se c’è stato un partito tutto personalisticamente risolto in una figura singola, nell’esperienza della prima repubblica italiana questa situazione è stata offerta dalla pratica del Partito Radicale, piccola formazione risucchiata completamente nel corpo e dalla parola di Marco Pannella. Tutto però cambia con quella tracimazione della politica che in Italia è rappresentata dalla “discesa in campo” di Silvio Berlusconi. Qui corpo, immagine, mito si condensano nel leader. Programma, ideologia, confronto, discussione, impallidiscono e si annullano dinanzi alla sola cravatta a pallini e al doppiopetto indossato dal leader. E ciò si ottiene mediante proprio quegli strumenti e l’operare nei terreni che per Laclau e Mouffe rappresentano la politica, il mito, nel caso di Berlusconi l’uomo che si è fatto da sé, il coinvolgimento emotivo, qui ancora la tifoseria di una squadra di calcio, il Milan, amatissima dagli Italiani, e poi la fantasia, l’immagine, che è quella che ci trasmette la televisione privata tutta in buona sostanza nelle mani del nuovo emergente leader.
I nostri occhi sono stati sostituiti da quelli di Berlusconi. L’Italiano dopo più d’un ventennio di televisione privata monopolizzata vede la realtà con gli occhi stessi di quel grande uomo. Lustrini, nani, ballerine, pagliacci, ricchezza profusa, “veline”, brillo di denari e arricchimenti immediati e inarrestabili, sono le nuove fantasie degli Italiani, agitate e inoculate dalla televisione e più tardi dagli schermi che ci ritroviamo intorno dappertutto nella nostra giornata, computer, telefonino, una vita “schermata” dove tutto passa per la mediazione di un brillo, e questo brillo ha un valore politico perché implicitamente o esplicitamente ci trasmette un valore ed una raccomandazione di buona vita. Potremmo anche dire che il populismo della teoria analitica e descrittiva è quello stesso evocato dalla dottrina normativa e prescrittiva, ma senza l’ambizione della trasformazione dell’uguaglianza sociale. Il “populismo reale” è una fotografia abbellita e truccata dello status quo e della realtà della disuguaglianza sociale. Ciò però non vuol ancora dire che sia un’esperienza meramente conservatrice. Tutt’altro, anch’esso ha un segno rivoluzionario. Ma qui è la rivoluzione dei ricchi, e non dei poveri che si manifesta con forza e vince.
L’altro punto che il “populismo reale” ha in comune con quello “ideale” è l’ostilità verso il principio di legalità e lo Stato di diritto. In Italia si provò l’assalto alla legalità con le leggi “ad personam”, ma il nostro sistema giudiziario bene o male resistette all’assalto e mantenne le garanzie al principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. L’indipendenza del potere giudiziario non fu alterata. La separazione di poteri si conservò, seppure sottoposta a vari stress, e le istituzioni di garanzia, prima tra tutte la Presidenza della Repubblica, continuarono a svolgere il loro ruolo di raffreddamento delle ambizioni carismatiche e delle tentazioni populistiche. Ma non si è mantenuta altrettanto la razionalità della sfera politica, quella della lotta di partiti, risucchiata nelle televisioni e nei desideri e nelle fantasie non più mediate dalla discussione di programmi e di princìpi. Talvolta questa deriva è stata giustificata agitando il vessillo della democrazia diretta e della deliberazione assembleare operata mediate strumenti elettronici. I risultati e i paradossi di una tale evocazione mi paiono essere sotto gli occhi di tutti nella loro evidenza farsesca.
La teatrocrazia si è realizzata al contrario, nel senso che non si dà catarsi del pubblico e suo governo sul palcoscenico, bensì accade l’autocelebrazione del palcoscenico mediante mera acclamazione e anzi produzione scenica del pubblico. La situazione è divenuta ancora più grave in quei paesi dove una meno forte tradizione democratica, o un più recente accesso a istituzioni rappresentative e liberaldemocratiche, rende la sfera pubblica più facile preda di sirene carismatiche ed autoritarie. Per esempio, in alcuni paesi dell’Europa orientale, che un troppo affrettato allargamento dell’Unione Europea nel 2004 ha reso Stati membri di pieno diritto. Qui un ceto dirigente post-sovietico ha creduto di poter imporre la propria egemonia riproponendo il mito della comunità omogenea ed etnicamente compatta, e in diretto contatto col grande leader, con l’uomo della provvidenza, o in obbedienza ad una religione salvifica. La condizione postmoderna, che si riassume nella “società dello spettacolo”, ha reso tutto questo più facile. E così si agita un modello di democrazia maggioritaria e lo si contrappone allo Stato di diritto liberale, riducendo i diritti delle minoranze, e rimettendo in circolo vecchi pregiudizi e vecchia fede, ed addirittura talvolta un osceno antisemitismo.
II.
Nella torsione autoritaria data alla democrazia maggioritaria dal “populismo reale”, questa, la democrazia maggioritaria, si presenta con un profilo che la contrappone allo Stato di diritto. Certo, questo anche è un termine abusato e vago. Stato di diritto può essere tanto il Rechtsstaat del cancelliere Bismarck come la rule of law anglosassone, tanto il modello evocato dalla dottrina di diritto amministrativo tedesca del XIX secolo o da quella italiana di Silvio Spaventa quanto il modello di Dicey nell’Inghilterra vittoriana. I modelli sono differenti, sebbene entrambi centrati sull’attività di controllo e di garanzia del potere giudiziario, là dove nell’un caso, in quello del Rechtsstaat si tratta di garantire l’ordinata e imparziale attività amministrativa, ferma restando la centralità e per certi versi l’incontrollabilità della pratica legislativa, mentre nel secondo, nel modello di Dicey, si tratta di garantire la vigenza di diritti privati anche nello spazio dell’applicazione della legge. In entrambi i casi dall’altro lato non c’è una democrazia liberale, ma un governo parlamentare nel caso inglese, che ha ancora ben saldo il dominio di certe prerogative non giurisdizionalmente sindacabili, e nell’altro, nel caso germanico, una macchina burocratica di amministrazione pubblica fondamentalmente sganciata dal controllo parlamentare. In tutti e due i casi lo Stato di diritto è comunque uno spiraglio, nel caso inglese invero più che uno spiraglio, in un contesto di governo oligarchico.
Ma lo Stato di diritto si trasforma e si potenzia una volta che si ritenga che anche la legge sia sindacabile e che la separazione dei poteri sia riferibile alla centralità del controllo parlamentare. Stato di diritto fa così riferimento non solo a procedure ma anche a princìpi sostanziali di ragionevolezza e di integrità del sistema. Il diritto dello Stato di diritto diventa fondamentalmente il diritto dei diritti dei cittadini, e dunque potenzia la cittadinanza e le dà significanza giuridica piena. Tuttavia, resta una tensione più o meno sotterranea tra Stato di diritto e democrazia, che potrebbe anche definirsi come la tensione tra la forma e la sostanza della democrazia, o se si vuole tra diritto e potere.
Il diritto è prodotto del potere del popolo, e solo a questo deve la sua legittimità. Ma lo Stato di diritto sembra non potersi accompagnare al potere del popolo nelle sue complesse e molteplici e permanenti vicissitudini. La certezza del diritto ha bisogno di continuità e permanenza e di coerenza. Non può piegarsi alla singola decisione. Ha uno sguardo lungo. Mentre la decisione popolare spesso è solo puntuale, opportunistica. A questo proposito il primo Dworkin distingue tra “diritti”, rights, e “politiche”, policies. E i diritti per la rule of law devono essere “trumps”, posizioni normative non derogabili, che hanno sempre la meglio sulle politiche puntuali, sulle “policies”. E i “diritti”, dice anche Dworkin, a differenza della più tarda teoria di Robert Alexy, non sono principles, princìpi. Sono rules, regole, deontologicamente sovraordinate ad ogni disposizione teleologica o possibile precetto di ottimizzazione. Ma i “diritti”, e dunque la “rule of law”, sono anche fondativi della democrazia. Questa non è la mera decisione a maggioranza. Lo afferma già Kelsen. È una decisione a maggioranza, che potrà poi successivamente essere modificata da quella che ora è la maggioranza. Ciò necessita di un quadro normativo previo, di una “precomprensione” dello spazio deliberativo democratico, e ciò è offerto da un ricco patrimonio di diritti e procedure messi a disposizione dei cittadini e dei loro rappresentanti, primo tra tutti il principio archimedeo dell’equal concern, dell’uguale dignità dei soggetti. Senza questo principio, e senza diritti, non c’è democrazia vera.
Lo dice e lo spiega accuratamente Habermas nel suo Fatti e norme, allorché riformula la “tesi dei diritti” di Dworkin in termini funzionalistici. Per Habermas la forma della legge, ovvero il diritto, si dà mediante la struttura concettuale e procedurale dei diritti soggettivi. Così egli afferma la “co-originalità” di diritti soggettivi e democrazia. Ma se questo vale per la teoria, nella pratica le cose – lo sappiamo – sono meno evidenti. Va ricordato che anche nella teoria la primazia dei diritti o meglio la loro presupposizione nella deliberazione democratica, e la conseguente revisione giudiziale della legge, è talvolta messa in discussione. Lo fa in maniera intelligente e radicale Jeremy Waldron, uno dei giusfilosofi contemporanei più accreditati. Ma la sua difesa del regime democratico maggioritario che vorrebbe sbarazzarsi della vigenza e azionabilità dei diritti fondamentali ci sembra troppo forte e poco plausibile. La realtà comunque è ostica e sappiamo che le democrazie populiste “reali” del tempo presente hanno poca simpatia per controlli giudiziali e per stringenti diritti fondamentali. Preferiscono evocare ed azionare compatte e mitiche comunità organiche. E queste, inesistenti, rinviano necessariamente, per l’azione, al decisionismo di qualche sovrano o leader, grande o piccolo che sia.
Ma non tutto è oro ciò che luccica. E non tutto è difesa della cittadinanza nella evocazione e nella pretesa dello Stato di diritto. A questo proposito può essere utile ricordare un vecchio dibattito tra i filosofi del diritto italiano. Nel 196o grazie al contributo della Fondazione Rockefeller si tenne a Bellagio sul lago di Como un incontro sul positivismo giuridico tra studiosi italiani, inglesi e statunitensi. L’incontro organizzato da Alessandro Passerin d’Entrèves, professore a Oxford, contò sulla presenza di personaggi quali Alf Ross, John Rawls, Herbert Hart, Norberto Bobbio, Renato Treves. Si raccolse dunque lì il fior fiore della filosofia del diritto mondiale, e con questa molti giovani che di lì a poco sarebbero diventati famosi. Tra gli Italiani si possono ricordare Giovanni Tarello, Uberto Scarpelli, Antonio Negri; tra gli Americani Ronald Dworkin. Da quell’incontro ebbe poi origine una feconda stagione di discussione sul concetto di diritto e sul giuspositivismo che trovò espressione in libri importanti quali Giusnaturalismo e positivismo giuridico di Norberto Bobbio e Cos’è il positivismo giuridico di Uberto Scarpelli, entrambi pubblicati nel 1965. Entrambi i libri difendevano il positivismo giuridico da diverse prospettive, da una prospettiva più metodologia Bobbio, da una prospettiva decisamente politica Scarpelli. Nel frattempo, in questo dibattito si erano inserite delle voci fuori dal coro, quanto meno dissonanti, se non proprio discordanti. La prima fu quella di un altro studioso italiano, ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Pavia, Bruno Leoni. L’altra voce dissonante era quella di Nicola Matteucci, studioso di filosofia politica attivo all’Università di Bologna, allievo di Felice Battaglia, rettore di quella Università.
Entrambi questi studiosi, Leoni e Matteucci, si contrapponevano al positivismo giuridico, e per certi versi rivendicavano una sorta di giusnaturalismo. Entrambi soprattutto contrapponevano la rule of law (per il cui genere femminile seguo Guido Fassò), una legalità determinata ed amministrata dal giudice, alla democrazia istituzionalizzata nei parlamenti eletti mediante suffragio universale ed attivi mediante la mediazione dei partiti politici di massa. Per la democrazia il diritto era quello prodotto con la legge parlamentare e dunque la sua teoria si presentava nelle vesti di un robusto positivismo giuridico. Questo, dunque, veniva attaccato non tanto perché frutto di una concezione della norma come comando o imperativo, o perché diritto concepito come concettualmente separato dalla morale. Il punto di dissenso era piuttosto l’aggancio del concetto di diritto alla deliberazione democratica necessariamente convenzionale e contingente, oltreché eventualmente sovversiva rispetto all’assetto tradizionale della società. La democrazia veniva vista à la Tocqueville come regime dell’uguaglianza di massa, la “rivolta delle masse” di Ortega y Gasset, e pertanto come regime incapace di limiti alla riformulazione dei diritti privati, in particolare di quelli economici, patrimoniali, eminentemente del diritto di proprietà, e della logica di mercato. Si ripeteva in questi due autori l’interpretazione della democrazia come tendenzialmente “totalitaria”, secondo una lettura che in quegli anni era stata resa popolare dal saggio di Jacob Talmon La democrazia totalitaria. Rousseau ancora una volta era l’avversario da affrontare. Si ripeteva sottovoce qua il vecchio ritornello di Gavroche: “La faute est àRousseau”. La democrazia veniva percepita come minaccia, perché ormai regime di massa, regime di partiti e di sindacati, le cui pretese insaziabili, metterebbero a repentaglio l’ordine economico proprietario e liberista.
Ora, qualcosa di simile, innanzitutto dal punto di vista della teoria, si era visto negli ultimi anni della Repubblica di Weimar. Dinanzi all’affermazione, fatta dallo studioso socialdemocratico Hugo Sinzheimer, il fondatore del diritto del lavoro, di una “costituzione economica” sancita nella Repubblica di Weimar da un ordinamento di gestione consiliare e corporativa della produzione e delle fabbriche, si ribatteva sostenendo che nella Costituzione di Weimar ci sarebbe impiantata una ben altra costituzione economica, tutto un capitolo di disposizioni a garanzia del diritto di proprietà, che costituirebbe la vera essenza del nuovo ordinamento costituzionale, il suo Wesensgehalt. Lo dice Carl Schmitt nella sua Verfassungslehre del 1928, per la quale i principi intoccabili della nuova costituzione sono il primato della proprietà e dell’alta cultura. Si afferma cioè l’intangibilità di una ben diversa “costituzione economica”, quella del regime di mercato e di proprietà, la quale va garantita sottraendola alla disposizione dei partiti di massa. Ciò dovrà avvenire mediante l’azione di un esecutivo che non abbia più bisogno di fiducia parlamentare ma che possa invece contare sulla protezione del Reichspräsident, vero custode della costituzione, e sull’attività del potere giudiziario. Questo viene vincolato, da studiosi come Erich Kaufmann, ad un principio di uguaglianza sostanziale dinanzi alla legge, dunque ad un’idea di Stato di diritto, che dovrebbe proteggere il proprietario da eventuali riduzioni del suo livello di disposizione dei beni e dei mezzi di produzione e di distribuzione. Questa prospettiva è poi assai intelligentemente etichettata, da Hermann Heller in un articolo famoso, come “liberalismo autoritario”.
Ed è proprio di quegli anni, e di quella stagione politica oltreché di quella cultura giuridica, la tedesca, una nuova strategia e torsione dell’operatività della “costituzione economica”. Si tratta dell’avvento di una nuova scuola di pensiero, ad un tempo giuridica ed economica, l’ordoliberalismo. Per questo il mercato come regime di inalterata ed elevata concorrenza tra attori economici è un regime ideale di formazione dei prezzi e di comunicazione di informazioni che per essere mantenuto ha bisogno di un corrispondente regime giuridico. Questo si sostanzia essenzialmente in un ordine di libero mercato e di protezione della libertà di impresa e di protezione della concorrenza. A questo regime ideale di mercato deve adattarsi e deve orientarsi l’intero sistema istituzionale. Ora, per fare in modo che quell’ordine ideale non risulti corrotto dall’intervento statale e dalla politica, è necessario disconnettere questa, la politica, da quello, il mercato, e lo si fa innanzando a valore di principio di legalità la costituzione economica del mercato concorrenziale assegnandone la difesa a un potere giudiziario indipendente e ad agenzie statali anch’esse indipendenti, vale a dire non responsabili rispetto alla logica della rappresentazione parlamentare ed al gioco politico dei partiti. L’economia viene affermata essenzialmente come cosa troppo seria e fenomenologicamente essenziale per consegnarla nelle mani della politica. La legge allora, quanto meno nella forma di una legalità economica essenziale, deve poter essere attiva in uno spazio non disturbato dalla sovranità politica, in ispecie democratica. In questa prospettiva la cosiddetta costituzione economica è resa equivalente allo Stato di diritto, e questo viene ora presentato come una specie di vincolo esterno rispetto al gioco democratico ed alla sua progettualità. Qualcosa di simile dirà qualche decennio dopo il giudice Scalia della Corte Suprema americana allorché presenta la costituzione come baluardo contro la repentina e radicale trasformazione sociale.
A tutto ciò, in quest’ottica neoliberale, si accompagna un concetto di diritto paragiusnaturalistico, per il quale i diritti fondamentali economici, quello di proprietà, quello di libera attività economica, e quello di competere egualmente e liberamente, assurgono al rango di diritti storici quasi naturali (che è anche, si ricorderà, la tesi Robert Nozick). Si rivendica un giusnaturalismo fenomenologico o funzionalistico per difendere un certo assetto sociale. Il compito del diritto e dello Stato, in gran parte monopolizzato dal ruolo del giudice, sarà quello di fare in modo che quei diritti naturali non siano reinterpretati e derogati dalla deliberazione politica e dalle vicissitudini della deliberazione democratica. In questa prospettiva lo Stato di diritto assume di nuovo i contorni di un liberalismo autoritario al quale la democrazia come sovranità anche delle classi meno abbienti è di peso, anzi è il pericolo da scongiurare. Una tale prospettiva è quella che ispira parte del processo di integrazione europea e di costruzione dell’Unione Europea, almeno a partire dall’Atto Unico Europeo del 1986 e in maniera più coerente e completa col Trattato di Maastricht del 1992. Ora, in questo quadro rivendicare lo Stato di diritto, laddove questo sia un altro nome della costituzione economica neoliberale, ed pretenda la forza di “vincolo esterno” rispetto alla politica, rivendicare ciò contro una democrazia maggioritaria, per quanto questa possa eventualmente darsi come illiberale, potrebbe avere l’effetto perverso d’offrire legittimità all’avventurismo ed all’autoritarismo del “populismo reale”.