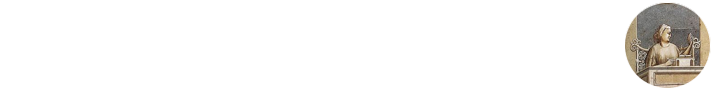EDITORIALE – La fine della storia: trent’anni dopo
DI MASSIMO LA TORRE
Nell’estate del 1989 ebbi concessa una borsa di studio da parte dell’Accademia delle Scienze della Germania Orientale, l’Akademie der Wissenschaften der DDR, per un soggiorno a Berlino Est. Ciò al fine di completare la mia ricerca sulla dottrina giuridica nazista. In Germania orientale arrivai così dopo un viaggio in treno via Vienna e Praga ai primi di agosto di quell’anno. Ricordo un‘estate abbastanza clemente, luminosa, non calda, ma nemmeno piovosa, o fredda, come quelle che mi era capitato di conoscere anni prima nella Germania del Nord. Cominciai dunque a percorrere la Berlino comunista in lungo e largo, soprattutto lungo l’asse formato tra Unter den Linden e Friedrichstrasse, la quale si interrompeva bruscamente al Checkpoint Charlie, il posto di controllo tra le due parti della città divisa.
La città era linda, anche se ancora qui e la qualche segno delle rovine della guerra faceva capolino, rivelando un passato di totale distruzione. Non vi erano segni di povertà né di estrema scarsità. Nei supermercati si trovavano beni alimentari e di consumo senza troppe restrizioni. Non c’erano troppe marche ovviamente. E scarseggiava la frutta fresca. Niente banane, oggetto di un intenso desiderio e di fantasia dei Berlinesi orientali. Ma latte, uova, caffè, zucchero eccetera erano ampiamente disponibili. Diversamente da quanto avevo potuto constatare in Polonia lo stesso anno, dove avevo trovato miseria e degrado, e l’odore acre, il tanfo, delle città che mi ricordava quello tipico delle baracche della mia città siciliana. Ristoranti e caffetterie offrivano pasti e cibo di ottima qualità. Le strade erano vivaci, e col tempo si scopriva, la sera soprattutto, una città parallela e sotterranea, fatta di cambiavalute clandestini, di locali nascosti affollati di gente, di macchinine private (il più delle volte Trabant) che facevano da taxi, di file per strada per infilarsi in una sala da ballo con i telefoni ai tavoli. Ma anche fatta di lunghe code alla libreria di Alexanderplatz, il centro della città, dove una buona metà dei libri in vendita erano in Russo, oltre ovviamente alla MEW, l’opera completa di Marx e Engels in più di venti volumi che avrei potuto comprare, ma non lo feci, e ora me ne pento, per qualche migliaio di lire. Il traffico appena fuori dal centro era regolato agl’incroci dai paracadutisti dell’Armata Rossa, sovietici, col parabellum a tracollo, e il berretto a punta con la stella rossa. La domenica la città pullulava di soldati russi in libera uscita. In Unter den Linden, non lontano dalla Università Von Humboldt, alla Neue Wache il cambio della guardia si compiva quotidianamente con rigido formalismo prussiano, passo dell’oca compreso. L’uniforme e gli elmetti dei militari della DDR ricordavano assai quelli della Wehrmacht, proiettandone un’ombra inquietante. L’impressione generale era quella d’un mondo molto ordinato, almeno in superficie, e isolato, e sotto costante occulta osservazione, tenuto insieme da paratie stagne, lento ma come una pentola a pressione sul fuoco. La sensazione di controllo e di subordinazione era permanente, e qui e là qualche commento poco prudente di uno sconosciuto, oppure un gesto sgarbato e autoritario d’un impiegato, te lo faceva percepire crudamente. Dire Ost-Berlin era ufficialmente assolutamente proibito. Al mio ritorno, al controllo alla frontiera, che avvenne alla stazione di Lipsia, una guardia mi chiese alla dogana da dove venivo, e rispondendo “Berlino est”, mi si gridò che una tale località assolutamente non esisteva. C’era solo Berlin Hauptstadt der DDR, Berlino capitale della Repubblica Democratica Tedesca.
Nelle vie della grande capitale sfilava la gente comune ammassata nei tram e nella metropolitana, abbigliata decentemente, coll’ambìto jeans talvolta teneramente ostentato. E s’incrociavano le Volvo nere degli uomini d’apparato. La gerarchia dispiegata in questa diversa forma di locomozione risultava stridente ed eccessiva. Veniva alla mente Orwell e la Fattoria degli animali, dove si proclama l’uguaglianza eppure “qualcuno” è più uguale degli altri. Tra le persone che conobbi ce n’erano che soffrivano perché, mi dicevano, udivano lo sferragliare della metropolitana della Berlino dell’Ovest passare sotto la loro casa. Ne facevano un’ossessione, ché erano condannati a non potere mai prenderlo quel vagone. E difatti alcune vecchie stazioni erano murate; mattoni su mattoni oltre quelli del lungo grigio nudo minaccioso muro che divideva inesorabilmente la città, sorvegliato dalle torrette dei Vopos, la polizia di frontiera. Ce n’erano altre, di persone, molte altre, che soffrivano la mutua mancanza di fiducia tra gli amici. La paura d’essere spiati dalla potentissima STASI faceva sì che nessuno si fidasse di nessuno. Un conoscente mi raccontava che il suo amico più caro era all’improvviso scomparso, per poi sapersi ch’era fuggito in Occidente passando per l’Ungheria (uno stratagemma che proprio in quell’estate esplose grazie alla liberalità ed alla porosità della frontiera magiara). Ebbene questo mio conoscente era sconvolto dal fatto che l’amico nulla a lui avesse detto del suo piano di fuga, a lui che gli era carissimo. Ed io allora a cercare di giustificarlo dicendo che chissà, forse, era stato un modo per proteggere l’amico, per non coinvolgerlo.
Nel breve tempo che passai allora a Berlino le cose cominciarono a precipitare. Se all’inizio di agosto sentivo solo qualche timido accenno di malcontento, a settembre la protesta si cominciava a fare aperta. Ricordo due episodi. Recandomi alla stazione dei treni per prenotare il viaggio di ritorno mi capitò di fare una fila enorme. Erano tutti giovani e giovanissimi davanti allo sportello, comprando biglietti per l’Ungheria. E l’impiegato domandando “andata e ritorno?”, “hin und zurück”, e la risposta era sempre: “solo andata”, “nur hinfahrt”. Si trattava di una fuga in massa. Qualche giorno prima di partire mi recai all’Opera a vedere “Il ratto dal serraglio” di Mozart. L’Opera era un edificio nuovo, tutto specchi e ori, “protzig”, pretenzioso, di fronte al museo di Pergamon. Il pubblico in sala era numerosissimo. E in un momento in cui uno dei cantanti pronunciava una frase che è di timida protesta verso il sultano, nella storia che racconta l’opera, partì un applauso fragoroso da tutta la sala. Era una protesta contro l’autorità, contro i bonzi del Partito. Un po’ alla maniera di come succedeva nel nostro Risorgimento nei teatri di Milano o di Parma. Era la prima volta che accadeva. L’aria era cambiata. Il popolo era in movimento. Partì prima che quello stesso popolo cominciasse le manifestazioni di masse, agitando la parola d’ordine “Wir sind das Volk”, “siamo noi il popolo”, e infine, complice la debolezza di Gorbacëv, facesse crollare il regime.
Un terzo episodio è ancora più rivelatore del clima d’oppressione. Al mio ritorno, al controllo di Lipsia, le guardie salirono sui vagoni, marciando di compartimento in compartimento. Controllavano i documenti, e contavano quanti bagagli ciascun viaggiatore portasse con sé. Ed i Tedeschi della Germania orientale che ne avessero troppi, e che dunque risultassero sospetti d’un tentativo d’espatrio, senza troppi complimenti li si faceva scendere, scaraventando le loro valigie dal finestrino sul binario. Così anche accadde nel mio compartimento ad una ragazza seduta proprio dinanzi a me, e che fu presa con la forza e costretta in lacrime ad interrompere il viaggio verso la Cecoslovacchia. Non si concedeva nessun diritto all’uscita dallo Stato.
Il pomeriggio del 9 novembre 1989 non ero a Berlino; ero in viaggio da Salisburgo a Bologna. Dovetti cambiare in una remota stazione nelle Alpi austriache di cui ora non ricordo il nome. Entrai nel bar e qui alla televisione si dava la notizia dell’apertura del muro di Berlino. Si vedeva la massa scavalcare il muro senza che la polizia intervenisse. Nessuno ci poteva veramente credere. La notizia era sensazionale; significava la fine di un’epoca. Tutti eravamo lì guardando lo schermo, consapevoli che si trattava di un’ora storica, e che presto il “socialismo reale” sarebbe crollato. E così avvenne, e credemmo tutti nell’inizio di una nuova era. Conclusasi la guerra fredda, si apriva una nuova stagione di pace e di prosperità. Così speravamo. Il nazionalismo pareva dar passo al cosmopolitismo. Bruce Ackermann si affettò a scrivere un libro celebrando la “rivoluzione liberale”. Francis Fukuyama parlò di “fine della storia”. Non era più ora la società senza classi a chiudere la storia, intesa come lunga sequela di conflitti e vicissitudini, ma il trionfo definitivo del capitalismo e del “secolo americano”.
Ma dopo il 1989 venne il 1990. E ci fu l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq, e subito dopo la prima guerra del Golfo, dell’invasione dell’Iraq da parte delle truppe statunitensi e dei sui alleati; ciò sanciva la fine del mondo bipolare governato insieme da Stati Uniti e Unione Sovietica. Iniziava un’altra fase delle relazioni internazionali: la stagione unipolare della potenza americana, ora senza il rivale russo. E la guerra del Golfo ne era il sigillo. E poi si aprì la lunga stagione della guerra balcanica e della dissoluzione della Jugoslavia, che doveva farci rivivere gli orrori di un nuovo olocausto. L’ottimismo tuttavia resisteva. Ed è in questo clima che si produce il Trattato di Maastricht del 1992 che dà vita all’Unione Europea, alla “cittadinanza europea”, e ad apre la rotta verso l’Unione Monetaria Europea, cioè l’introduzione della moneta unica, l’Euro. Il diritto dell’Unione ora più che mai ambisce a presentarsi come il “diritto dopo Auschwitz”; soft law, “soffice”, o “mite”.
In quegli stessi anni si modifica profondamente il sistema politico italiano. La “prima repubblica” uscita dalla seconda guerra mondiale si dissolve sotto i colpi di maglio dei giudici di Milano. È l’avventura di Mani Pulite. Il sistema dei partiti crolla, prima il partito socialista, e poi, seguendolo a ruota, il partito comunista e la democrazia cristiana, accompagnati dai partitini (liberali, repubblicani, socialdemocratici) che ne erano i satelliti. Viene a mancare la “costituzione materiale” che aveva sostenuto la costituzione formale repubblicana del 1948. E si affacciano altri protagonisti alla ribalta politica, La Lega Nord, e il partito-azienda di Silvio Berlusconi, entrambi estranei, se non ostili, ai valori repubblicani e comunque alla storia che questi aveva prodotto. L’Italia entra in una nuova epoca di turbolenza e di instabilità, da cui invero deve ancora uscire. Questa trasformazione radicale è anch’essa in parte il risultato di quel 9 novembre dell’89, che libera il Bel Paese dalla tutela che su di esso si esercitava in ragione della guerra fredda e del carattere di frontiera della sua collocazione geopolitica. L’Italia, crollato il muro, diviene assai meno importante strategicamente, nel mentre la Germania riacquista la sua unità e si profila nuovamente come nazione egemonica del continente europeo. La politica interna italiana si libera dalla sua precedente stretta dipendenza dalla politica estera.
L’Europa e l’Italia che oggi viviamo sono dunque in buona misura il prodotto di quel fatidico novembre di trent’anni fa. Del resto, il 9 novembre è data anch’essa fatidica. Il 9 novembre 1918 si dichiara la Repubblica in Germania, e il Kaiser abdica. Il 9 novembre, 1923, e non a caso, è la data del fallito putsch di Hitler a Monaco di Baviera. E il 9 novembre 1937 è la data poi della “notte dei cristalli”, “Kristallnacht”, in cui i nazisti si scatenano apertamente e furiosamente contro la popolazione ebrea, e ne bruciano le sinagoghe. E il 9 novembre 1799, 18 Brumaio nel calendario rivoluzionario, era stato il giorno in cui Napoleone aveva preso il potere in Francia con un colpo di stato, dissolvendo il parlamento.
Il rimescolamento e il riassetto che si dànno a partire del 1989 spiegano ciò che ci è dato di vivere oggi. La fine del “socialismo reale” rilancia un capitalismo senza freni alla maniera di quello “manchesteriano” tipico dell’Ottocento, il mondo dei disperati di Charles Dickens. Sembra quasi che le lancette della storia vadano all’indietro. Umberto Eco a questo proposito parla di un movimento del gambero, all’indietro per l’appunto. La “grande trasformazione” del ventesimo secolo, studiata e discussa intelligentemente da Karl Polanyi nel suo splendido saggio The Great Transformation del 1939, sembrava per l’appunto essere stata quella di un sistema di mercato ora addomesticato, “embedded capitalism”, capitalismo controllato mediante un attivo intervento di poteri pubblici. Il New Deal di Roosevelt aveva messo fine agli eccessi del capitalismo finanziario e speculativo responsabile della terribile crisi del 1929. Nel 1944 gli Americani riordinano il sistema finanziario mondiale mediante gli accordi di Bretton Woods, mirati ad impedire gi eccesivi squilibri di cambio che avevano esacerbato la crisi del ’29. E dopo la seconda guerra mondiale nell’Europa occidentale è un programma socialdemocratico quello che prevale, Stato sociale un po’ dappertutto seppure declinato in vari modi, a seconda delle diverse contingenze nazionali. In vari paesi, in Italia per esempio, ma anche nel Regno Unito, si ritiene che il sistema sia quello ormai di un’”economia mista”, condiviso tra impresa privata e impresa pubblica. La Francia dopo la guerra si dà un importante sistema di pianificazione economica pubblica.
Ciò libera moltissime energie nella società, e rimescola le classi sociali. Il Wall Street Journal in un numero del 1970 deve comunicare al lettore che gli operai sembrano non aver più paura. Il Regno Unito nella prima metà degli anni Settanta è attraversato da un’ondata massiccia di scioperi operai, a partire da quello famosissimo dei minatori che costringe i Britannici a stare senza luce un paio di sere a settimana. L’inverno del 1978-1979 Inghilterra è ricordato come “the winter of discontent”. Ed allora comincia ad agitarsi lo spettro della “ingovernabilità”. Le masse – si dice, riprendendo un vecchio luogo comune –sono insaziabili, e intrinsecamente turbolente. Ciò riduce produttività e profitti oltre ad alimentare l’incertezza dell’“impresa” e dei “mercati”. Bisogna allora poter ritornare ad una situazione d’ordine e di disciplina nei rapporti sociali. Va ristabilita la gerarchia, e la “paura” dell’avvenire. Un posto di lavoro fisso non rende il lavoratore produttivo, anzi togliendogli la paura lo fa ingestibile. Si dà così una nuova temperie di conflitto sociale culturale, in cui al welfarismo si contrappone il neoliberalismo, e ciò che sembrava marginale e superato, l’idea del mercato come regolatore automatico della produzione e del consumo, ritorna ora prepotentemente ad affermarsi come criterio direttivo della politica economica. Il 1979 in Inghilterra si conclude con la vittoria elettorale della Signora Thatcher, e con questa v’ è l’inizio d’una aggressiva rivincita del governo capitalista dell’azienda e della vita dei lavoratori. Per una suggestiva coincidenza è quello stesso l’anno delle lezioni al Collège de France tenute da Michel Foucault sulla bio-politica, dove in maniera acuta si illustra la governamentalità neoliberale come gestione dell’esistenza vitale dell’individuo, capovolgimento dell’intuizione marxiana dei bisogni quali struttura fondante dell’ordine politico.
Agli anni Settanta dello scorso secolo, anni turbolenti e di grandi scioperi, e di conquiste sociali, seguono gli anni Ottanta. Il numero di ore di sciopero si riduce drasticamente, i salari si bloccano, in Italia si abolisce la “scala mobile”, vale a dire l’automaticità dell’aumento dei salari a seconda dell’inflazione, e si comincia un po’ dappertutto a liberalizzare i movimenti di capitali ed a privatizzare le imprese pubbliche. Nel 1971 gli USA hanno già denunciato gli accordi Bretton Woods, che impedivano loro di stampare moneta liberamente, ridando luogo alla instabilità dei cambi. Con l’Atto Unico Europeo del 1986 si inaugura il passaggio dal “mercato comune”, in buona sostanza unione doganale, al “mercato unico”, che è tutt’altra cosa. Si tratta qui di una “costituzione economica”, alla maniera ordo-liberale, vale a dire dell’instaurazione di un modello economico di libero mercato e di elevata concorrenza tra attori economici privati e pubblici garantito costituzionalmente per via giudiziale dalla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia e per via amministrativa/legislativa dall’opera di monitoraggio, omologazione e omogeneizzazione intrapresa dalla Commissione Europea. E a questo punto arriva l’ondata d’urto del 1989. I paesi del “socialismo reale” abbandonano il sistema socialista. In società in cui non c’è proprietà privata questa viene reintrodotta dall’oggi al domani, con provvedimenti dall’alto, ed una legislazione d’impianto neoliberale. Sono i “Chicago Boys” all’opera nelle capitali dell’Europa orientale; sono loro, i seguaci di Milton Friedman e del mercato liberissimo, coi libri di Ayn Rand sotto il braccio, a ricostruire le economie di quei paesi. È un’opera che può dirsi rivoluzionaria, o controrivoluzionaria se si preferisce, di portata enorme, e che ancora attende uno studio complessivo ed intelligente. Ora, l’Europa di Maastricht si produce e si sviluppa in questa temperie, e il clima culturale dominante nei paesi dell’Europa orientale, neoliberismo radicale, si trasmette anche alle istituzioni europee, in ragione pure dell’allargamento dell’Unione nel 2004, quando d’un sol colpo vengono a far parte di essa ben dieci nuovi Stati-membri, tra cui alcuni che erano stati parti della stessa Unione Sovietica. Globalizzazione, allargamento dell’Unione, privatizzazione, sono quasi dei sinonimi, e definiscono processi che si sovrappongono e si sorreggono mutuamente.
Ciò si dà in un quadro politico anch’esso “liberalizzato”, o “de-regolarizzato”, dove ciò va inteso nel senso di un regressivo smantellamento delle strutture di contenimento internazionale dei conflitti e della forza “bruta”. L’ordine costruitosi faticosamente tra gli Stati a partire dallo stabilimento delle Nazioni Unite nel 1945 sembra subire un’opera di mirata erosione, che spinge verso l’affermazione di poteri fattici globali che si sottraggono alle istituzioni ed alle regole del diritto internazionale. L’Unione Europea sembrerebbe contraddire questa evoluzione, se non fosse che dopo la crisi finanziaria del 2010 e del salvataggio della Grecia molta acqua è passata sotto i ponti di questa strana confederazione di Stati, e che una legislazione sovranazionale d‘emergenza ha per un verso solidificato in maniera radicale il trasferimento di sovranità verso istituzioni epistemocratiche e tecnocratiche sovranazionali, come la Banca Centrale Europea. Ma molto di tale “solidificazione” si è data rifacendosi ai mercati, per esempio coinvolgendo nell’edificio europeo una istituzione ad essa estranea, il Fondo Monetario Internazionale. Il “solido” qui rinvia al “liquido”. E con questo si giustifica. Epperò il “soft law” si rivela tutt’altro che mite, diventato ordine giuridico del creditore, cui il debitore è sottomesso secondo rigidi protocolli di “condizionalità”. L’impressione rimane ancora di disordine. L’onda d’urto espansiva del 9 novembre 1989 non si è ancora esaurita. E nuovi tumulti e “liberalizzazioni” ci aspettano. Il Brexit può anche interpretarsi in questa chiave, un’ulteriore impresa di demolizione, di “liquidazione” e “liberalizzazione”.
SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE