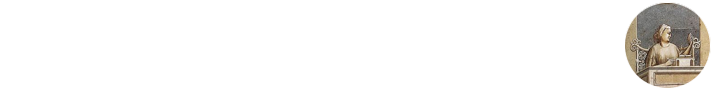EDITORIALE – Noli me tangere
DI MASSIMO LA TORRE
Il Novecento, il secolo ventesimo, è stata un’epoca di grandi rivolgimenti, di speranze e di disperazione estrema. È il secolo cui si consuma l’egemonia europea, nel quale l’Europa cessa di essere il baricentro del mondo, anche se rimane un secolo essenzialmente europeo perché è lì, nel Vecchio Continente, che si dispiega la grande tragedia delle due guerre mondiali, dei totalitarismi, e dello sterminio di massa. Ed è ancora la pacificazione di questo continente, nonostante la sua divisione in due aree di influenza contrapposte, che segna gli anni del secondo dopoguerra. Ed ancora lì con la caduta del muro di Berlino si inaugura una diversa era di relazioni internazionali e di politiche sociali ed economiche. C’è allora chi ha definito quel tempo, il Novecento, come il “secolo breve”. È la definizione di Eric Hobsbawm, come è noto. Il Novecento sarebbe tutto racchiuso tra lo scoppio del primo conflitto mondiale, il fatidico agosto del 1914, e il 9 novembre del 1989, data in cui si apre la frontiera fino ad allora invalicabile tra Berlino Orientale e Berlino Occidentale, la “caduta del muro”. Si tratterebbe insomma di soli settantacinque anni, fondamentalmente marcati da due guerre mondiali, dalla Rivoluzione russa, e poi da nazismo e comunismo sovietico. Sarebbe l’epoca della grande speranza della politica, o meglio della sua hybris, dell’idea che con la politica si può cambiare il mondo in maniera radicale, sia essa una politica di giustizia sociale, oppure di un diabolico tentativo di cancellare diritti, culture e persino umanità e razza. La politica lo può tutto, e lo Stato con il suo nume tutelare, Marte, la guerra, la violenza, è onnipotente. E dietro questa violenza una massa di popolo, sia esso una massa rivoluzionaria di proletari, sia esso una armata di soldati ben addestrati e assi motivati. Li si lancia contro il nemico, e questi marceranno verso la vittoria. L’economia sottostà ai battaglioni di armati. Marte vince su Mercurio, lo domina assolutamente.
Ma si potrebbe sostenere plausibilmente che il Novecento perdura oltre il 1989. Il fallimento del cosiddetto “socialismo reale” nei Paesi dell’Europa orientale è accompagnato da un violento processo che potremmo anche definire “controrivoluzionario”, una restaurazione dall’alto, niente affatto dal basso, della forma capitalistica di produzione e distribuzione economica. Società in cui la casa d’abitazione per esempio è concessa a tutti ed è un bene sociale vedono rintrodursi la proprietà privata. Fabbriche, imprese, di proprietà collettiva si ristrutturano in società per azioni. L’educazione pubblica viene privatizzata. Lo stesso dicasi delle pensioni e della sanità. Si dà un processo di espropriazione del bene pubblico, che non ha per radicalità nulla da invidiare alla stagione delle “enclosures” inglesi nel diciottesimo secolo. La grande trasformazione di cui parlava Karl Polanyi, vale a dire l’addomesticamento del capitalismo, viene interrotta; anzi si rimettono le cose cosi com’erano prima della crisi del ‘29 e del New Deal. Il capitale finanziario e la speculazione di borsa diventano un fatto di massa, e la distanza salariale, la differenza di reddito, tra “alto” e “basso”, si moltiplica in maniera esponenziale. Agli scioperi il lavoratore preferisce il prestito e il consumo. Tutto si sposta dalle piazze ai centri commerciali, Aux bonheur des dames, come recita il titolo di un romanzo di Émile Zola su per l’appunto un primissimo centro commerciale di tardo Ottocento a Parigi. Ed è Zola, il suo mondo, a riproporre la cifra del fin de siècle del Novecento. La fine del Novecento è quasi come il suo inizio, si celebrano i fasti del “libero commercio”, della politica monetaria indipendente dalla politica dei cittadini e dei governi. Sembra quasi chiudersi il cerchio.
La breccia apertasi nel 1914, e con l’economia di guerra, ampiamente statalizzata e pubblica, e poi riconfermata in forma mite dal New Deal e dallo Stato sociale del secondo dopoguerra, viene rinnegata ed espulsa dalla tavola delle possibili strategie di sviluppo economico. Nel 1979 la Cina comunista abolisce il sistema di sanità pubblica indiscriminatamente gratuito. Non se ne accorge allora quasi nessuno, ma vent’anni dopo ecco la Cina caposaldo della globalizzazione capitalista, e manifattura del mondo. La cuvée, L’argent, Pot-Bouillie, tutti titoli ancora di romanzi di Zola potrebbero ben addirsi a storie dell’inizio del secondo millennio. Questo inizia festeggiando la nuova moneta unica europea, l’Euro. E poi subito dopo una guerra d’aggressione contro un Irak senza nessuna arma di distruzione di massa, ma con molto petrolio; guerra con cui il nuovo Impero mondiale, potenza ora senza concorrenti, gli Stati Uniti, pone il suggello al nuovo ordine, ordine senza diritto ma con molta forza e potenza. Tutto questo fa ancora parte del Novecento. Ne è una protesi. La seconda guerra d’Irak è la rivincita sulla sconfitta e l’ignominia subita per la sconfitta in Vietnam. Tutto si tiene. Allora più che di un “secolo breve” dovrà parlarsi di un secolo “lungo”. Il Novecento sopravvive a se stesso nella sua idea di espansione di potenza e di ricchezza. La guerra civile iniziata surrettiziamente nel 1917 si perpetua sotto altra forma negli exploits di Wall Street e nei diktat dell’Eurogruppo. Alla rivoluzione dei poveri succede con maggiore successo la rivoluzione dei ricchi. I quali talvolta sognano secessioni, oppure già se le danno segregando bianchi da neri, emigranti da cittadini, quartieri benestanti da miserevoli periferie. La secessione è anche architettonica. Il quartiere ricco o l’abitazione del potente sono circondati da alti muri, fili spinati, guardie armate. Los Angeles, Miami, Città del Messico, Bogotà, Sao Paulo sono attraversate da trincee tutt’altro che invisibili.
Ed arriva la pandemia di quest’anno. Il Covid 19 si distribuisce per tutto il pianeta. Intere nazioni si fermano, si autorecludono, mentre la morte colpisce i più deboli, i più poveri, i più fragili, tanti troppi vecchi. Improvvisamente tutto un mondo di relazioni e di condotte si accartoccia su se stesso. Non si viaggerà più ogni settimana. L’aereo è un pericolo. L’albergo è off limits. La vacanza prima sempre dietro l’angolo si allontana ora vertiginosamente. Discoteche e ristoranti e negozi e centri commerciali chiudono. Il corpo desiderato come macchina di piacere viene rivissuto come fonte di sofferenza. Non bisogna toccarsi, non bisogna avvinarsi l’uno all’altro. Niente strette di mano. Le auto si fermano. La città è silenziosa, e deserta. Gli alberi respirano. Gli uccelli si riprendono spazi per loro prima rischiosissimi. La globalizzazione si interrompe come flusso di persone e di beni. Niente più libera circolazione. Niente più sabati a comprare l’ultima scarpa alla moda. Niente incursioni in locali notturni. Si dà l’inaspettato, l’imprevisto, l’inimmaginabile. È tornata la peste.
Si dà un evento. Vi siamo ancora dentro ed è perciò difficile interpretarlo e capirlo. Non possiamo ancora misurarne le conseguenze né comprendere il significato. Perché non sappiamo come andrà a finire. Non sappiamo nemmeno se andrà a finire. Se sarà possibile ritornare al mondo grosso modo spensierato di prima. Ma abbiamo già delle reazioni, delle proposte di interpretazione. Queste si dividono innanzitutto in quelle pessimistiche e in quelle ottimistiche. Entrambe in genere fanno riferimento all’idea, non del tutto innocente, dello “stato d’eccezione”. C’è chi legge la pandemia come un fatto drammatizzato ad arte dal potere, dallo Stato, o da chi per lui, al fine di procedere sulla strada della biopolitica, della riduzione del cittadino a “nuda vita”. L’impatto del virus sarebbe così esagerato per legittimare provvedimenti di controllo totale della soggettività. Tutti sono costretti alla quarantena, agli arresti domiciliari. Sono le prove generali di un ancora più globale stato d’assedio cui ci vuole costringere la governance post-moderna. Ci tolgono persino la percezione dei corpi, e ci spingono a concepirci noi stesi come pericolo e rischio.
Untori potenziali sono ora i soggetti. Il consociato si dissolve nel contagiato, ben più letale e maligno dell’hobbesiano homo homini lupus, perché agisce con artificio e per certi versi persino con raggiro, “nottetempo”. Del resto, la peste era stata già da Hobbes concepita come uno dei pericoli contro cui deve proteggerci il Leviatano. Lo si vede nel frontespizio famosissimo del Leviatano dove in basso, sotto il macroantropo che è lo Stato, il “leviatano” per l’appunto, accanto a guardie e soldati si intravvede la figura barocca del medico della peste, intabarrato con la maschera a becco d’uccello. La peste dunque sarebbe una di quelle situazioni che giustificano la cessione assoluta di sovranità che dà origine allo Stato altrettanto assoluto teorizzato dal filosofo inglese. La peste è qui una felice opportunità, o almeno così si potrebbe concepire. Sappiamo anche che Don Abbondio, mosso dalla teodicea cattolica, interpreta benignamente la peste come la “scopa” che cancella dalla faccia della terra il malvagio. Don Rodrigo ne è una vittima e così giustizia è fatta. Tuttavia, un tale ottimismo deve nutrirsi di una visione provvidenziale della vicenda e della storia umana. In un’epoca post-metafisica e disincantata come la nostra sarebbe forse chiedere troppo. Ed allora la bilancia pende per la versione pessimista dell’interpretazione. La pandemia radicalizza la “gabbia di acciaio” che già Max Weber vedeva come il portato dell’era capitalista.
Lo dice un filosofo italiano, che già da anni ci augura un destino concentrazionario pur nei festini e nei baccanali della società dello spettacolo e dei consumi. Si tratta di Giorgio Agamben che per l’appunto fa dello stato d’eccezione la categoria esplicativa di tutta la modernità e della stessa uscita da questa. La pandemia ci condanna ad un’ulteriore perdita di respiro. L’aria si fa sempre più rarefatta per l’umanità del nuovo secolo. Ci dibattiamo in una sensazione di soffocamento, come succede ai malati gravi di Covid 19. Questa malattia è più che una metafora, è un momento di un più generale soffocamento. Ma –dice il filosofo italiano – invero il soffocamento è indotto. La malattia con ogni probabilità sarebbe solo un’invenzione per prepararci a quella più dura mancanza d’ossigeno che per noi progetta lo Stato postmoderno erede di Auschwitz, e lo è in sé per essenza ogni Stato portatore della tradizione razionalistica dell’Occidente illuminista. Come si vede, una tesi questa assai estrema, addirittura negazionista. Che non vede quanto le misure di prevenzione, l’isolamento, il confinamento, la mascherina, i guanti siano il risultato non solo di misure dall’alto, provvedimenti securitari di un governo, ma anche di un movimento societario dal basso, di persone che si vogliono assicurare un domani, per loro ed i loro cari, spesso contro chi in nome delle ragioni dell’economia, della produzione e del consumo, dichiara il pericolo insignificante o lo minimizza o lo sottovaluta, o nella ponderazione di diritti mette al primo posto la libertà d’iniziativa economica e di consumo facendo prevalere questa sul diritto alla vita.
Vi è poi una interpretazione ottimistica della pandemia. In questa seconda prospettiva la malattia, il contagio di massa, ha i tratti di una sorta di “miracolo”, quell’avvenimento del nuovo che Hannah Arendt lega all’azione politica e di cui questa si alimenterebbe. Dopo decenni di normalità, di anni tutti uguali, di passività, di riproduzione passiva della mera vita, la pandemia rompe il ciclo riproduttivo di una storia sempre uguale a se stessa, ed apre così alla mutazione, chissà forse persino alla rivoluzione. L’ “eterno ritorno” è interrotto; si dà nuovamente una freccia progressiva del tempo. Lo sostiene questo tra gli altri Slavoj Zizek, un filosofo sloveno, anche lui come Agamben esponente di pensiero post-moderno, ma meno disperato, anzi sempre pronto a trovare dietro l’angolo un pezzo di comunismo. Invero, un frammento di comunità” riemerge con la pandemia. E sì, giacché siamo tutti nella stessa barca. Il pericolo investe tutti e i danni che provoca l’infezione sono distribuiti sull’intero territorio sociale. L’urto è simmetrico, il guasto anche. E dunque la solidarietà, il soccorso, deve distribuirsi in maniera che il più esposto riceva di più rispetto al meno esposto, perché in verità essi sono tutti egualmente esposti. Abbandonare il povero in questa contingenza è impossibile, non salverebbe il ricco. Anche se pare che i ricchi Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi Bassi tanto per fare un nome, non ne siano ben consapevoli, riproponendo austerità e debito come cifra della solidarietà comunitaria. Shylock, il Mercante di Venezia, non è un buon esempio dl soccorritore, e nella pandemia la sua logica del “pond of flesh”, una libbra di carne, come pegno del credito, insomma quello che in gergo comunitario europeo si chiama oggi “condizionalità”, non è la strategia adatta per alleviare le sofferenze e lo schock indotto da questa peste postmoderna.
Zizek ha anche ragione per un altro motivo. La pandemia riporta a galla, per così dire, riattribuisce visibilità, ma soprattutto centralità al lavoro. In tempi di peste, se il confinamento è la salvezza, la salvezza del confinamento riposa sulle spalle di soggetti che non possono confinarsi, innanzitutto gli operatori sanitari, medici e infermieri, i lavoratori che garantiscono e provvedono al mantenimento della pulizia e dell’igiene del territorio, netturbini, ecc., e poi quegli altri lavoratori che assicurano la catena dell’approvvigionamento, per esempio i fattorini e i cosiddetti riders. Si tratta di lavoratori, parola per lo spirito del tempo quasi impronunciabile, non di imprenditori, e nemmeno di consumatori. Nella peste si consuma meno, poco, e si intraprende assai meno sul mercato, ma si continua a lavorare, anzi per molti si lavora di più e con maggiori rischi. Ciò rende immediatamente percepibile la menzogna della società neoliberale fondata sul mito dell’impresa e del libero mercato. Non è il mercato né la concorrenza a salvarci dal contagio. Anzi se il mercato fosse qui lasciato a se stesso i farmaci e i ventilatori, le mascherine e i guanti, non sarebbero forniti a tutti coloro che ne hanno bisogno, ma solo a coloro che li possono meglio pagare. A ciascuno secondo i suoi bisogni, formula comunista quanto nessuna altra, è il principio fondativo delle politiche di salvaguardia della salute pubblica durante l’emergenza.
Il modello neoliberale è messo poi in dubbio, anzi refutato, dalla pandemia per un’altra ragione ancora. Questa peste ci rivela due cose fondamentali rispetto al nostro rapporto con la natura. La prima è che questa è il nostro ambiente vitale; la vita è il nostro ambiente, non la rete o le transazioni di capitale e nemmeno la televisione. E della vita fanno parte animali, piante e virus. Il virus è la vita che si riprende i suoi diritti di contro all’usurpazione che scienza, tecnica e mercato permanentemente operano rispetto ad essa. Leibniz in un passo famoso parla della scienza moderna come una pratica di tortura della natura. L’esperimento cos’è altro, se non tortura della natura messa sul cavalletto e sottoposta a prove dolorose, affinché la natura così torturata si confessi a noi finalmente, e ci riveli tutti i suoi segreti? Ma la natura si rivolta a questo trattamento crudele. Potrebbe darsi che il suo grido passi attraverso lo sprigionamento di virus con cui ci comunica il suo orrore per il nostro stile di vita.
La seconda verità che la peste postmoderna ci dimostra senza possibilità di replica è che siamo come esseri umani soggetti fragilissimi. La fragilità è il carattere primordiale del nostro stare al mondo. È vero che ci circondiamo di acciaio e plastica e cemento, e diffondiamo onde magnetiche e segnali luminosi. Ma noi rimaniamo della stessa materia di una pianta, anzi di un virus, che facilmente si insinua in noi, si fa corpo nostro, e ci piega e ci uccide. Non siamo creature d’acciaio né schermi brillanti, tantomeno algoritmi. Siamo fatti della stessa pasta del virus, che ci ferisce perché è come noi; si può trasformare in carne e sangue e così ci soffoca e ci toglie aria. A questa verità si accompagna quest’altra. Abbiamo bisogno d’aria, e quest’aria la avveleniamo permanentemente, la lordiamo, la oscuriamo, e poi il nero dell’inquinamento così provocato per essere competitivi e obbedire ai mercati poi ce lo ritroviamo nei polmoni, e il virus ne approfitta, ci ammazza. Ricordandoci che siamo fatti di aria e sì anche di acqua, quell’acqua che infiltra i nostri polmoni, i suoi interstizi, distruggendoli e annichilendoci. L’aria e l’acqua sono beni comuni, beni della vita, ma il mercato se ne vuole appropriare. A chi gli domandava fino a quando durerà il capitalismo Max Weber rispondeva: Fino a quando ci sarà carbone da bruciare e acciaio da fondere. Noi potremmo precisare quell’affermazione e dire che il capitalismo vuole darsi eterno fino a consumare tutta l’aria e l’acqua che ci fa vivere. Fino a quando non ci toglierà la vita insomma. La peste ce lo ricorda con drammaticità acuta.
La pandemia riporta anche all’ordine del giorno la questione dello Stato e della sovranità. Lo Stato si riafferma come attore fondamentale. Nell’emergenza è lui a prendere le redini dell’azione collettiva, non il mercato. Le frontiere si innalzano nuovamente. Ci sono i confini. Che si moltiplicano. Le strade sono vigilate. Si dà un eccesso di controllo invero. E vi deve essere un comando unico, anche se questo poi si rivela alquanto frastagliato e contestato tra governo centrale, regioni, comuni, ciascuno con la sua pretesa di gestione della sicurezza pubblica. La dimensione sovrastatale si attutisce, anche se essa è quella da cui si attende una soluzione alla crisi di rifornimento di materiali e medicine, e poi il soccorso decisivo alla crisi economica la quale inevitabilmente si annuncia. E si assiste ad una metamorfosi della sovranità. Questa si produce nella forma della “immunità”. La distinzione di amico e nemico che secondo alcune drammatizzanti versioni della sovranità è la cifra di questa, la sua “linea d’ombra”, questa distinzione fondamentalmente prestata dal discorso della guerra, si ritraduce come distinzione tra sano e malato. E ci interessa rimanere sani, “immuni”. Non essere contagiati dal “malato”, dall’altro che rappresenta un pericolo. La differenza tra interno ed esterno si rimodula secondo una disciplina di controllo medico. “Non mi toccare”, noli me tangere.
Nondimeno, questa prospettiva e quell’imperativo possono facilmente rovesciarsi. “Non toccarmi” si dice anche per impedire all’altro di mettersi a rischio, non solo per allontanarlo ed escluderlo come potenziale malato. Il controllo medico, la biopolitica che si manifesta nella sovranità come “immunità”, invero ha necessità di darsi come “cura”. E questa può intendersi non solo e tanto come dispensario, ricovero nel lazzaretto, bensì come cura, attenzione all’altro, uscita da se stessi, un mettersi a disposizione dell’altro, non nella forma dell’obbedienza o della sottomissione bensì nella forma della compassione e dell’amicizia. Nella cura la soggettività esce dal suo chiuso, si riflette nell’altro, e dell’altro, e della sua vita, e della sua salute, si arricchisce. Arricchimento esistenziale, e morale, non economico. La centralità della cura, con tutto quanto di ostico ne deriva per la sovranità come dimensione monocratica ed egocentrica, l’interesse per il prossimo e l’ambiente che ci circonda, è questo il principio che ci salva dalla peste, e ciò che essa veramente ci insegna.